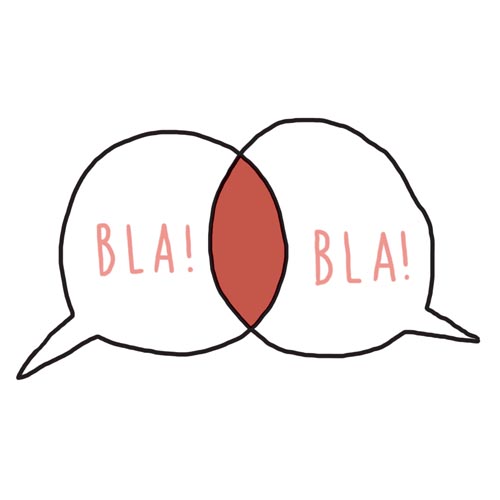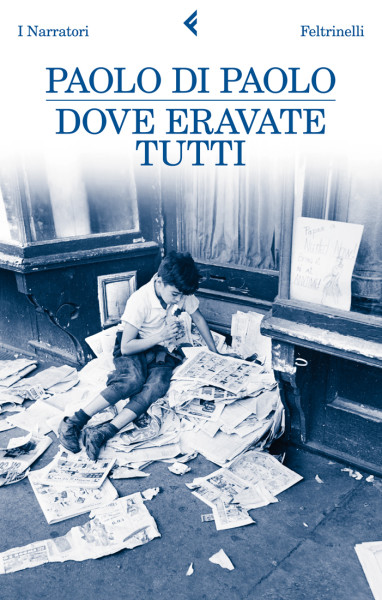“Dove eravate tutti” – processo al personaggio
Il Sole 24 Ore – Domenica, 23 ottobre 2011
Una volta, a scuola (ma forse accade ancora), veniva chiesto di prendere posizione. Leggevi un brano di romanzo sull’antologia e ti trovavi nei panni di giudice. Tu cosa avresti fatto al posto del personaggio? Ti sembra giusto che don Abbondio non abbia avuto il coraggio di ribellarsi ai bravi? E giù critiche a palate: macché, io avrei fatto questo e questo; li avrei denunciati, oppure avrei detto subito a Renzo e Lucia come stavano le cose. Si può essere più vigliacchi? Così, da una parte – quella dei buoni – c’eravamo noi; dall’altra c’erano i personaggi cattivi, condannati senz’appello al tribunale spiccio delle nostre coscienze. Almeno sulla carta dei quadernoni, eravamo coraggiosi, fedeli alle amicizie, incapaci di tradire. Eravamo puri e con la schiena dritta. Perfino all’ultimo anno di scuola superiore, fiorivano all’impazzata tesine che erano vibranti j’accuse contro l’inettitudine di Zeno Cosini, Emilio Brentani e compagnia.
Poi, siamo cresciuti. La vita ha guadagnato qualche sfumatura in più e così pure la capacità di leggere, per chi ha continuato a farlo. Importava davvero ancora giudicare i personaggi? Smarcarsi dai loro difetti, dalle loro viltà, dalle sciocchezze e dai peccati che commettevano? Tutti hanno qualcosa da farsi perdonare, e nel gruppo finalmente eravamo inclusi anche noi. Leggere poteva essere più avventuroso proprio perché compromettente: significava scendere negli abissi altrui per illuminare i propri, mandare in crisi le certezze sul nostro conto, sulla nostra stessa innocenza. Uscire da un romanzo non già rassicurati nella nostra splendente dirittura morale, ma al contrario: allarmati e indifesi.
Al tempo dei blog, di Anobii e dei social network, ogni cultore di libri ha il proprio quadernone a righe. Il cultore di cinema pure, ma appare più scafato, avvezzo a prendere non le distanze dal male rappresentato, ma a valutare il fascino e la riuscita di quella rappresentazione. Per i romanzi contemporanei, invece, è tutto un prendere di petto i personaggi. Il tanto atteso «ritorno all’etica» sta dando i suoi primi frutti nelle valutazioni letterarie? Che pasticcio. È un coro: ma perché quel personaggio di Giordano si comporta da sfigato e non si scuote? Perché proprio nessuno, in Acciaio di Silvia Avallone, ha una «parvenza di vita felice»? perché tanto degrado? Perché il ragazzino dell’ultimo libro di Ammaniti si lamenta se in realtà è solo un «viziato figlio di papà»? Perché i protagonisti dell’ultima Mazzantini hanno rapporti «così malati, morbosi, cattivi»? Non sto inventando.
È toccato anche a me. La presenza su Facebook e l’insana abitudine di spulciare i blog mi hanno messo a contatto con una furia del tutto imprevista. Dove eravate tutti ha un protagonista, Italo Tramontana, quasi trentenne – e già il dato anagrafico sembra non deporre a suo favore. Lungo tutto l’arco del romanzo non commette omicidi. Però si accorge, quasi per un’epifania, che l’intera sua vita cosciente – dal 1993 a oggi – ha coinciso con la presenza sulla scena politica di Silvio Berlusconi: esame di quinta elementare, maggiore età, scuola guida, laurea cosiddetta triennale. «Questa non è una cosa bella, né brutta. È una cosa vera». Prova a concludere una tesi impossibile sugli anni zero e nel frattempo fa i conti con suo padre, professore in pensione accusato di avere investito volontariamente con l’auto un ex alunno. La madre si assenta dal paesaggio delle certezze domestiche facendo un viaggio improvviso, e il giovane si trova tardivamente alle prese con i calzini da lavare. Mal gliene incoglie, sul piano pratico (in effetti ha qualche difficoltà con la lavatrice) e al tribunale dei recensori online. «Ventenne piagnone e ripiegato su sé stesso». «Che pena quando la mamma giustamente si rompe i c. di una famiglia così e se ne va per una meritata vacanza. Scoperta epocale: una casa non va avanti da sola! Bisogna fare la spesa, lavare i calzini, stirare e cucinare. Ma va’ là! Così il nostro eroe si trova da solo davanti al supermercato, al ferro da stiro e al soffritto. Ma non gli viene in mente di rimboccarsi le maniche e darsi una mossa. Meglio sognare davanti alla foto della Ragazza Amata e Mai Avuta». Lì per lì ho pensato a un malumore isolato. Macché: «E io dovrei sentirmi rappresentata da uno come Italo? Mi fa solo rabbia. È solo un “inetto” incapace di sciogliersi dai legacci di questa Italia in decadenza». Vai a spiegare che un personaggio è un personaggio, non è lì per rappresentare nessuno se non sé stesso. Come, tra l’altro, accade per le persone. Italo, Italo, pancia in dentro e petto in fuori! Perché non sei in piazza? Perché non prepari la rivoluzione? «Questo personaggio è un eterno adolescente, è uno che vota Berlusconi vivendo, la sua vita è troppo comoda, la sua vita è fatta di niente». Non basta: Italo è un moralista ipocrita, è un «democristiano». Ma è nato nell’83! Non basta: è assolutamente imbranato con le ragazze, non è in grado di scrivere una tesi, è in sostanza patetico e inerte. Stavo per riprendere fiato quando un’ulteriore scarica di domande mi è arrivata sul naso: «Che senso ha lamentarsi che il padre ha lasciato il libro sulla storia del socialismo nei ripiani più alti della libreria, lontano dalle mani del figlio? Ma monta sopra una sedia e prendilo, oppure vai in libreria e compralo! Quando mai è il padre che insegna al figlio a fare la rivoluzione?». Non importa che in effetti, a fine romanzo, Italo abbia cominciato a leggere quella storia del socialismo e che rimproveri sé stesso di non averlo fatto prima. L’accigliato lettore non se ne è accorto. Non importa nemmeno che da qualche parte il personaggio ammetta che la sua visione storico-politica somiglia a un cartone animato o a un fumetto, o che a un certo punto il suo processo contro il padre gli torni indietro come un boomerang. E se a lui si addebitano troppe indulgenze e mancanze, il rimprovero può allargarsi a dismisura e travolgere la sorella adolescente Anita che si innamora del «teppistello» e «carogna» investito dal padre, e via così.
Qualcuno dirà che è positiva questa visceralità nella lettura di un romanzo. Può darsi. Tuttavia, prendere per il bavero i personaggi dimostra anche un eccesso, non molto lucido, di nervosismo. Avevo scelto di porre a epigrafe di Dove eravate tutti una frase di De Sanctis – «I popoli, come gl’individui, al pendio della decadenza diventano nervosi, vaporosi, sentimentali» – ritenendo che nei tre aggettivi ci fosse il senso del libro (del modo, perfino, d’essere scritto) e la verità sui suoi protagonisti. Tanto mi bastava, senza condanne né assoluzioni. Chiedere a Italo di stare sulle barricate sarebbe come chiedere al Brentani di Senilità di cambiare abbigliamento e pettinatura. I personaggi sono come sono: migliori o peggiori di noi. Talvolta ci somigliano. Pretendere da loro ciò che non pretenderemmo da nessuno – rinunciare a ciò che sono; amare, soffrire di meno o di più; essere più intelligenti o più energici; contribuire, che so, alla primavera araba – è forse piuttosto sciocco. Vanno lasciati nei romanzi, e giudicati al tribunale della letteratura, non a quello della coscienza. Ecco dov’è che vince don Abbondio. Tra l’altro, lo confesso, io ho sempre tifato per lui.
Paolo Di Paolo