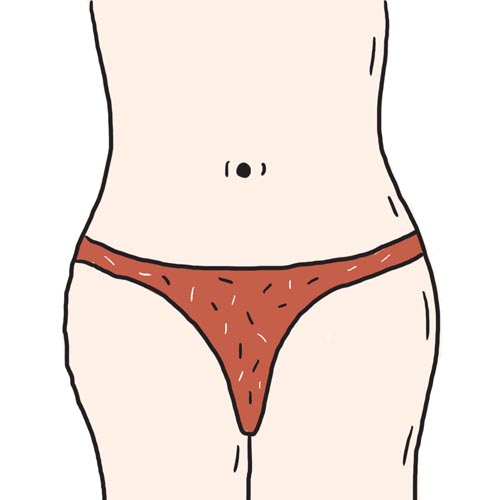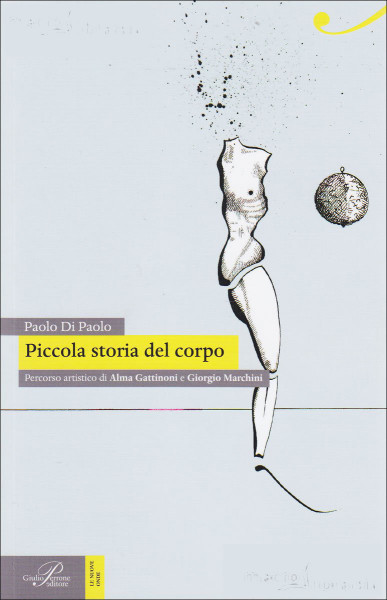La nostalgia del presente che ti muore fra le mani – The dreamers
“…fermarmi un istante e guardare, come se facessi parte della storia, un cespuglio che si mette a tremare… Il cespuglio può diventare importante. O una porta che sbatte.”
(B.B.)
Quando viene intervistato sulla propria infanzia da Dacia Maraini (E tu chi eri?, 1973), Bernardo Bertolucci richiama una serie di dettagli che valgono ciascuno una poesia. L’odore del padre Attilio: «un odore di mandorle amare. Un odore intenso che lo circondava come un alone. Un odore che rimaneva nei posti dove lui era stato, nelle cose che aveva toccato». Poi, l’odore del nonno – «di testa calva. L’odore delle nove di sera, buono, dolce». La vestaglia a fiori della madre. Lui stesso, Bernardo bambino, seduto dentro un paniere che sua madre portava legato al manubrio della bicicletta. Le rane infilzate – torneranno in una scena di Novecento. L’«elaboratissima e festosa» cerimonia dell’uccisione dei maiali, in campagna. L’infanzia – che uno si porta dietro «come i cacciatori si portano appresso il fango e le foglie incollate agli stivali».
Nel dialogo con Maraini, Bertolucci riconosce di essersi mosso a lungo in «un paradiso terrestre in cui la realtà poetica e la realtà naturale si confondevano». E se questa frase potrebbe essere letta come un’epigrafe per l’intera sua opera cinematografica, ce n’è un’altra che ha funzionato per me da rivelazione. Lui la lascia cadere lì, in un discorso, ancora una volta, intorno all’illustre padre. Tra le cose sue, dice, che mi sono rimaste addosso, una è «la necessità di vivere la vita quotidiana in maniera non traumatica, e sempre celebrativa». L’altra è la nostalgia. La nostalgia di che?, domanda Maraini. «La nostalgia del presente che ti muore fra le mani», risponde Bertolucci.
Si scioglie in questa frase un grumo. Lo sentivo fermo in gola mentre andavano sullo schermo – in un pomeriggio estivo dell’adolescenza (troppa luce fuori: avevo abbassato gli scuri per “fare il cinema”) – i fotogrammi di Novecento. L’ho sentito mentre – coetaneo dei protagonisti, nel 2003 – guardavo The Dreamers come un racconto più sensuale che politico, o sensualmente politico (cosa difficilissima). Ma c’è in Bertolucci una verità del corpo che arriva prima di quella delle parole, ovvero delle idee. Ingenuo dirlo quando si parla di un cineasta? Forse sì, e tuttavia poche volte ho sentito così intensamente la verità dei corpi nel cinema italiano del ventesimo secolo. Parlando del Tè nel deserto, Bertolucci stesso ha chiarito il suo tentativo di fare un film «sulla fisicità, sulla sensualità, sostituendo le parole di Bowles con i segni e i gesti tracciati dai corpi, quasi che la fisicità potesse sostituire la psicologia».
Ma torniamo indietro: la schiena di Fabrizio in Prima della rivoluzione. Si contano le vertebre – il bianco e nero le fa risaltare come in una fotografia di Mapplethorpe. Gina/Adriana Asti che si stringe un seno nel sonno.
Trent’anni dopo, in Io ballo da sola, il gesto di Lucy/Liv Tyler che nasconde una fotografia di sé stessa bambina nel reggiseno. Il suo bagno in piscina con un costume nero. Richard che si tuffa nudo mentre lei è ancora in acqua e gli dà le spalle.
Fatico a tradurre in parole la sensazione, confusa e violenta, che mi arriva da scene come queste. E bisogna intanto aggiungere che concorre a produrla una particolare relazione – anch’essa di natura lirica, elegiaca – fra i corpi e il clima. La pioggia fuori (dopo una scena d’amore in Prima della rivoluzione, o mentre il ragazzo Matthew, in mutande, scrive una lettera a sua madre, in The Dreamers). Per un regista di soprammobili, come ironicamente si definiva, possono fare la differenza anche le piastrelle bianche e azzurre di un pavimento – su cui si stendono due giovani corpi nudi. Può la scena di un film sollecitare il tatto, far sentire quasi il brivido sulla pelle nel contrasto caldo/freddo? O ancora, in esterno: la luce dell’estate, di pomeriggi che sembrano interminabili e durano in verità il tempo di un tuffo, il tempo di una canzone.
Torno alla scena del pavimento: ancora The Dreamers; Matthew e Isabelle fanno l’amore distesi a terra, involontarie controfigure giovani dei due di Ultimo tango, che sono invece incupiti, atterriti, brutali (hanno perso – da troppo – l’innocenza; hanno perso la giovinezza). Matthew e Isabelle gemono, mentre Théo fuma una sigaretta e cuoce un uovo al tegamino. Li guarda, distratto e ingelosito insieme. Non voglio eccedere con l’enfasi, ma il tempo in cui l’uovo si rapprende, frigge nel tegame è un tempo poetico straordinario, e perfino rivelatore.
Se si potesse parafrasare davvero questa sequenza, direi che in essa si incarna, prende corpo – come molte altre volte in Bertolucci – l’Irripetibile. Isabelle perde la verginità. L’uovo frigge nel tegamino. Théo si avvicina, si inginocchia accanto a Isabelle, la accarezza. Una luce tenue entra nella cucina – stanza chiusa, difesa come un guscio, con le sue piastrelle, i suoi oggetti mai davvero inanimati («Mia moglie dice che riuscirei a fare sembrare sensuale anche una tazza di tè»). I rumori lontani della città. Tutto questo è irripetibile, è la verità del presente – la sua intensità, un fascio di sensazioni – che si dà nell’istante e poi muore, «ti muore fra le mani». Il primo spettatore non sono io che guardo il film; il primo spettatore è Bertolucci stesso: il suo occhio si insinua nelle pieghe dell’evento, insiste sui dettagli, fa lo sforzo di trattenerli, è un occhio che desidera. Ma anche è l’occhio di chi sta fuori dal tempo, o in un tempo diverso in cui quel presente è già morto, è già svanito.
Una volta Bertolucci, ragionando sul senso del tempo nel lavoro cinematografico, ha spiegato: «Quando dico “stop” è passato un certo periodo di tempo: in questo periodo di tempo gli attori davanti alla macchina da presa sono invecchiati, si sono avvicinati in qualche modo alla morte». È in questo, è nel lungo, lunghissimo attimo prima dello “stop” che Bertolucci riesce – maestosamente – a celebrare la quotidianità. Attivando così quella specialissima nostalgia del presente che è un tratto essenziale del suo cinema. E che mi dà l’impressione di poter ricordare come parte del presente che mi è morto fra le mani, l’indolenza e la rabbia di Fabrizio che dice «Per me è già molto andare via di casa», lo stupore calmo di Lucy che nuota in piscina, la foga del ballo solitario di Lucy, la dolcezza di quello di Olivia, sedici anni dopo, nella cantina di Io e te. Un uovo che frigge nel tegamino, continua a friggere: per sempre, per un attimo.
da Bianco e Nero – Rivista quadrimestrale del CSC, numero dedicato a Bernardo Bertolucci