Un uomo cammina lungo le rive di un grande lago tedesco. È partito all’improvviso, dopo avere provocato una serie di “incidenti emotivi”, come lui stesso li definisce. È ripiombato nella vita di persone che non vedeva da tempo. Ha risposto a email rimaste lì per quindici anni, facendo domande fuori luogo. Ha provato a riannodare fili spezzati.
Mauro Barbi, storico di professione, cerca di aggiustare i ricordi degli altri – le persone che ama e ha amato – proponendo la sua versione dei fatti. Cerca di costruire una “memoria condivisa” che lo riguarda. Ma che impresa è? Forse c’entra una Piccola era glaciale privata, un processo di raffreddamento che ha spopolato la sua esistenza. Dove sono Fiore, Arno, il vecchio Cardolini, Meri, la Ragazza belga di Madrid? Dov’è Anna? Dove sono tutti?
Forse il lago a cui ha dedicato anni di studio può dargli le risposte che cerca. Vede, anzi immagina, l’immensa lastra di ghiaccio che lo copriva da sponda a sponda quattro secoli e mezzo prima. Il sole pallido su una catasta di uccelli morti. Un lunghissimo inverno che travolse l’Europa con i suoi venti polari, le grandinate furiose, le inondazioni. Una remota stagione estrema che faceva battere i denti, perdere la speranza, impazzire. Come se ne uscì? Come se ne esce?
Le immagini del passato ci ingannano sempre. Barbi prova a rientrare nel presente, con tutta l’ansia e la fatica che richiedono i gesti semplici. Uno in particolare potrebbe cambiare tutto.
In questo suo Romanzo senza umani, dove gli umani sono a fuoco più che mai, Paolo Di Paolo interroga i disastri climatici delle nostre singole vite. Gli anni senza estate, i desideri furiosi come acquazzoni tropicali, le secche della speranza, il gelo che intorpidisce e nasconde. E poi il disgelo, che finalmente riporta alla luce.Che cosa ricordano, gli altri, di noi?
“Paolo Di Paolo affronta un tema poco esplorato: la memoria è turbamento. C’è chi ricorda troppo, chi ricorda meno, chi non percepisce lo scorrere del tempo. Siamo tutti congelati fra versioni sconnesse del passato. Non è facile leggere la vita mentre accade. Un romanzo magnifico e audace.”
André Aciman
Trovati un lavoro e poi fai lo scrittore
«C’entrano i geni? il famoso DNA?
C’entra qualche antenato sconosciuto?
un vecchio bibliofilo il cui nome
è nascosto in una enciclopedia polverosa
che non leggerò mai
Ma no, forse è solo frutto di un caso
O di una speciale intelligenza del mondo –
che sarebbe molto noioso se tutti amassimo le stesse cose
D’altra parte, la gente seriamente appassionata è divertente da osservare
ma anche un po’ inquietante
Non c’è mai una ragione precisa,
una ragione seria
a cui ricondurre l’essere diventati,
nella vita, questo o quello
una studiosa di fisica che si occupa
di buchi neri
come affacciandosi da oblò invisibili
nello spazio
un pilota costretto a dimenticare le paure
di molti passeggeri
in volo sull’Oceano
il macellaio migliore del quartiere
l’insegnante rimpianta dagli studenti
che ha dovuto lasciare
il grafico che impagina questo libro
perché così? perché siamo questo e non altro?
A vedermi da fuori, io stesso ho qualche dubbio sul tempo che ho speso a leggere storie
ad accumulare libri
a comprarli
a farmeli prestare
a prestarli
senza riaverli indietro
(ma questo non è importante, perché trovavo – per dire – perfino eccitante di sapere un libro mio a casa di una ragazza che mi piaceva)
E a sfogliarli
a sottolinearli
a perderli
e ricomprarli
Il tempo – non quantificabile – che ho speso anche solo ad accarezzare copertine
come si accarezzano gli animali domestici»
Il giorno in cui la letteratura morì
Uno
«Scusi», dice come sul punto di alzarsi, «non sono d’accordo, non so nemmeno se sono previste domande, e la mia a dire il vero non è una domanda, è un’osservazione».
[quando è successo che le domande si sono trasformate in osservazioni?]
Nessuno gli dice di rinunciare ed è ovvio che lui non rinuncia. Rivolto al conferenziere di turno, dice che non è persuaso fino in fondo dalla tesi appena esposta. E cioè che lo Scrittore di cui si sta parlando abbia vissuto una sua stagione di sfiducia nelle parole, nel senso stesso delle parole, del fare letteratura.
«Sa perché glielo dico?». «No» scuote la testa il conferenziere, «no». «Glielo dico perché penso che uno Scrittore, se tale è, vive di una inesausta fiducia nel suo gesto, nella sua – vorrei chiamarla così, anche se so che è una parola quasi desueta – vocazione». Espone il suo teorema con la sicurezza esibita di chi esclude di poter essere smentito. E infatti nessuno lo smentisce: il conferenziere non ha voglia, è stanco, è sempre così (cerca la parola) svuotato alla fine di una conferenza, di un discorso pubblico, finisce per deprimersi, trascinandosi dopo cena in una camera d’albergo che è accogliente quanto ostile; no, ostile no, se è quattro stelle non lo è
[non sempre ai conferenzieri sono garantite le quattro stelle]
semmai indifferente. Indifferente come diventa lui a sé stesso quando si sciacqua il viso, sente gorgogliare la pipì, accende senza ottimismo la televisione, e si salva da una insostenibile apatia addormentandosi davanti a una trasmissione televisiva qualunque, o masturbandosi.
Che cosa resta del fiato che abbiamo speso per mettere in sequenza sillabe sostantivi verbi congiunzioni preposizioni a voce alta? Respiro e stille di saliva sono già disperse, svanite col pulviscolo della sala conferenze ormai chiusa, ormai al buio.
Non vale la pena farsi la domanda, nemmeno quando il conferenziere dovesse mettere in discussione la sequenza di gesti, di atti, che ha preceduto il torpore in cui finalmente molla gli argini della coscienza e sprofonda.
L’arrivo in stazione, il treno, il tempo in treno, una ragazza cerca di superare i suoi complessi parlando brusca, smargiassa a un suo coetaneo, poi per blandirlo gli chiede se vuole una galletta yogurt-e-fragola, lui fa no con la testa, la voce registrata nomina la prossima fermata. È un pomeriggio freddo e umido, sbarcando pensa che per scaldarsi ci vuole un caffè, appena un po’ lungo, e sa che se ne pentirà sentendo bruciare lo stomaco dopo neanche mezzora, nel tragitto in macchina accanto a un guidatore ragazzo che gli dice di collaborare con l’Organizzazione, e ogni tanto smessaggia tenendo una mano sola sul volante, eccetera
[non è facile chiedere a uno sconosciuto di guidare con più attenzione, con prudenza]
Comunque resta l’amaro in bocca, questo è il fatto, tanto più se la cena non è stata convincente, e come un campanello fastidioso la mattina dopo continua a suonare nella testa l’obiezione, la non-domanda, l’osservazione del signore che ha detto scusi come fosse sul punto di alzarsi.
da Il giorno in cui la letteratura morì, Tetra

Quello che possiamo imparare in Africa
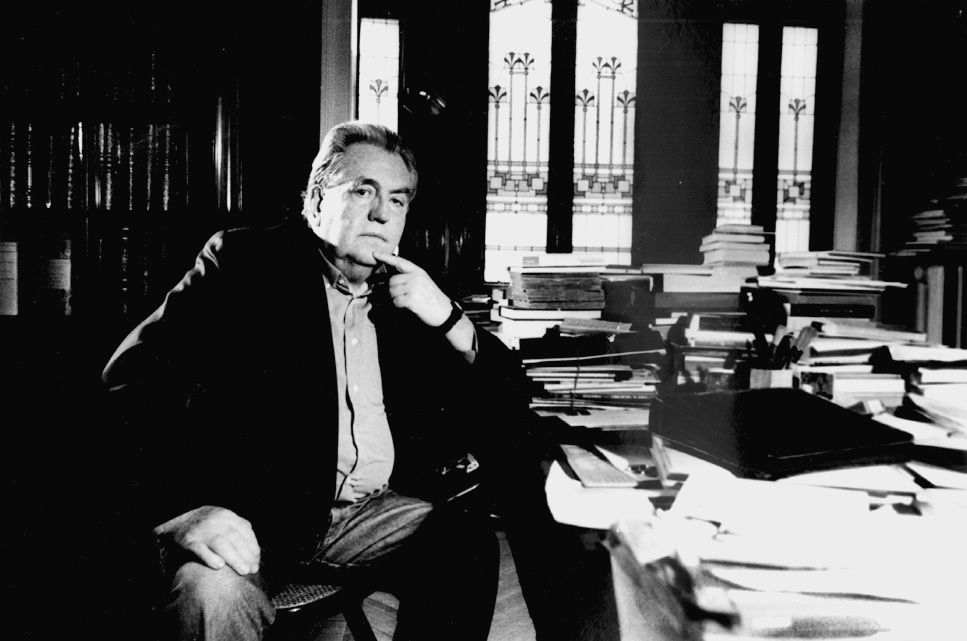
Giuseppe Pontiggia. Tentativi, scacchi, fallimenti
Cominciamo dai peccati espressivi. Sono i più gravi, anzi: gli unici davvero gravi. D’altra parte, scrivere vuol dire «evitare l’espressività più debole e ottenere quella più efficace». Sembra facile: è tutto, ed è una strada in salita. Un maestro vero, un maestro come Giuseppe Pontiggia, non è uno che nasconde gli ostacoli. Li indica. Sembra quasi di vedere il dito che si tende verso un punto, più o meno lontano. La vedi? Quella è la sciatteria. Quella è la (pericolosa) confusione fra parlato e scritto. E quella? Quella è la linea della noia, anzi il muro della noia. Va abbattuto. Come? Il maestro vero segnala l’ostacolo, ma costringe il discepolo a ingegnarsi per superarli. Non gli prepara il libretto delle istruzioni, anche perché non esiste.
L’amore per la trasparenza, per una onesta chiarezza, spingeva Pontiggia a evitare illusioni e camuffamenti. Imparare a scrivere – inutile girarci intorno – vuol dire imparare a leggere. Gli altri e sé stessi. Leggendo meglio – esercitando cioè, alla lettera, l’intelligenza – si può sperare di fare passi più sicuri sulla strada della scrittura. Più precisi. Più efficaci. E di saltare gli ostacoli, quando ci si parano davanti. Lo scintillio fosforico di questo libro deriva – come spiega nelle pagine finali la curatrice, Cristiana De Santis – dalla impressionante capacità didattica di Pontiggia. Un maieuta della sollecitazione, un conversatore capace di attivare percorsi dialettici di fronte ai quali un Socrate del ventunesimo secolo, magari titolare di un corso di scrittura creativa, non avrebbe obiezioni. Questo volume, fatto di moltissime domande, fa diventare le risposte interrogativi ulteriori: tanto più quando Pontiggia risponde con quel suo disarmato, meraviglioso «Non lo so». Un professore che alza le braccia e dice «Non lo so»! La frase più sincera e più aperta. Solo dicendo coraggiosamente «non lo so» si può sperare di imparare ancora qualcosa.
Non è falsa modestia. Pontiggia racconta in queste pagine di essersi interessato ai problemi del linguaggio narrativo molto presto. Fin dalla metà del secolo scorso, quando era redattore del “Verri”, la storica rivista letteraria diretta da Luciano Anceschi. Si era laureato, nel ’59, con una tesi sulla tecnica narrativa dei romanzi di Svevo. È uno scrittore consapevolissimo, «padrone dei propri strumenti, cosciente del proprio mestiere». E tuttavia convinto che applicare un taglio normativo alla scienza inesatta dello scrivere sia poco sensato: «Non insegno regole, ma scelgo esempi, non propongo un modello di prosa o di racconto, ma vorrei concorrere a sviluppare potenzialità originali. E in generale, anziché suscitare illusioni euforiche, mostro le difficoltà effettive per poterle affrontare in modo adeguato».
Consapevolezza: forse è questa la parola chiave. Pontiggia mette sul banco medicinali utili ad accrescerla, ad affinarla. Piccole dosi di Proust e di Karl Kraus, domande di Rilke e risposte di Braque, pillole di Seneca e di Manzoni, aforismi di La Rochefoucauld e intuizioni di Swift o di Virginia Woolf. Sposta avanti e indietro il cursore sulla linea del tempo, Kafka e Dante si incontrano e si danno la mano, convinti entrambi – come Pontiggia – che scrittori non si nasce.
«Non ho mai conosciuto nessuno che sia “nato” scrittore. Ho conosciuto alcuni che lo sono diventati dopo un tirocinio molto duro, fatto di tentativi, scacchi, fallimenti, provvisorie esultanze e ricorrenti depressioni» scrive Pontiggia. E quando allude alla preziosità dei «collaudi» da parte di lettori «severi e impazienti, consci che stiamo sottraendo loro il bene più prezioso, il tempo», si coglie all’istante una speciale vibrazione, un tono. Ironico e caldo insieme, simpatico – aggettivo che gli stava a cuore nella radice profonda, quella che rimanda al soffrire con.
Rileggo le righe di una sua letterina scritta a mano, su un cartoncino stretto e lungo, datata 20 giugno 2003. Sette giorni prima che morisse. Gli avevo, da lettore sconosciuto, confessato quanto mi piacesse la sua idea di simpatia come un «camminare insieme nel viottolo che abbrevia il percorso» incontro a ciò che ci fa più paura, la verità.
«Lo spazio la simpatia se lo prende da sé», rispondeva Pontiggia – e così lo spazio di questo scrittore nato su un ramo del lago di Como il 25 settembre 1934 è invaso da una luce chiara: è uno spazio, appunto, di simpatia. Lo capisci nelle pagine vive di questo volume che raccoglie lezioni di scrittura. Lo capisci leggendo i suoi racconti, i suoi romanzi, che sono lezioni di scrittura nascoste.
«Sua madre, in gioventù attrice dilettante, gli trasmette il gusto di una recitazione “sincera”. Suo padre, funzionario di banca, gli trasmette il gene della bibliomania, brama di conoscere l’universo attraverso i libri». Così Pontiggia stesso si raccontava in terza persona, mettendo l’accento sulla passione che l’avrebbe spinto ad accumulare negli anni oltre quarantamila volumi, custoditi in scaffali appesi perfino ai soffitti. Una ragazza entrata in casa sua per un’indagine sulle abitudini di lettura restò sbalordita: «Sa che non ne ho mai visti tanti? Di solito le case dove vado non ne hanno. Questa mi fa paura!».
Nel suo primo romanzo, uscito nel ’59, La morte in banca, Pontiggia narrava le vicende di un giovane bancario con la passione per la letteratura. Era lui. Era lui quel ragazzo impelagato tra i numeri che sognava i libri. Guardava la pioggia e pensava a una fuga, «desiderava di evadere, di tornare a muoversi, di distrarsi». Questo desiderio dovrà aspettare trent’anni e un altro romanzo per compiersi: nelle pagine di La grande sera (1989), il protagonista è un parente stretto di Mattia Pascal e di Wakefield: fa perdere le proprie tracce. «Oggi non è andato nel suo studio e non ha avvisato nessuno».
Una delle domande ricorrenti del Pontiggia narratore sembra questa: se si possa abbandonare la propria vita da vivi; se nella grande partita a scacchi dell’esistenza (amava molto quel gioco), sia possibile fare una mossa spiazzante che modifichi il corso delle cose. E questa mossa, che spesso è casuale e involontaria, la studia in uno dei suoi libri più belli, Vite di uomini non illustri (1993), esistenze di individui anonimi mirabilmente condensate in una decina di pagine. Che cos’è davvero decisivo nella nostra esistenza? Di solito, non i giorni a cui attribuiamo valore. Sono gli altri, quelli da niente, che alla luce del dopo acquistano spessore. «Il 16 novembre 1996 il cardiologo Federico Traglia, di Arezzo, gli sconsiglia di continuare la pratica della attività sportiva»; «L’8 luglio 1940 sale con lui nel crepuscolo, per una breve passeggiata, fino alla piscina vuota».
Pontiggia, con il passo di quelli che chiamiamo classici, riduce all’osso queste vite, alla loro nuda trama, alla linea tortuosa di un destino. Ma dietro il tono da enciclopedista ironico c’è molto strazio e molto mistero.
«Possiamo immaginare tante vite, ma non rinunciare alla nostra»: lo dice nell’ultimo, bellissimo romanzo, Nati due volte (2000). La lingua è pura e veloce, senza una sbavatura, senza un cedimento al pietistico. È il risultato forse più alto di questo illuminista lombardo del secondo Novecento, l’approdo della sua saggezza benevola, mai distante. «La normalità – sottoposta ad analisi aggressive non meno che la diversità – rivela incrinature, crepe, deficienze, ritardi funzionali, anomalie». Qui Pontiggia salda alla narrativa la sua vocazione di saggista, di osservatore del costume e di brillante aforista.
Superata a modo suo la stagione dell’avanguardia degli anni Sessanta, si era ritrovato, solitario e sorridente, sulla strada poco affollata di chi cerca la chiarezza e provoca l’intelligenza. Lui – il meno cattedratico e il più simpatico di tutti – l’ha fatto come se giocasse ancora una volta a scacchi: con la stupidità («ci assedia da tante parti, compresa la nostra»), con l’ignoranza, con le malattie del linguaggio, con le tentazioni del conformismo e del luogo comune. Perché scrivere (e parlare) bene non è solo una questione per letterati.
Ma ora basta con gli elogi: «Gli scrittori morti – scriveva Pontiggia – sono ricercati, blanditi, adulati». Poi però aggiungeva: «Difficile appurare se essi ne siano lieti».
Prefazione al volume Per scrivere bene imparate a nuotare, Mondadori 2020

Tanta vita, uno spazio su Vanity Fair
Una nuova avventura, una rubrica settimanale che firmerò su Vanity Fair. L’ho chiamata “Tanta vita”. Racconterò piccole storie lontane (o magari vicinissime), storie che ci sfuggono e invece dicono di noi, di una temperatura emotiva che è anche nostra. Storie di esseri umani, gente di questo pianeta.
Concordia, Argentina
Se sei la voce storica del carnevale, un po’ di malinconia è il minimo. Lisandro A. non nasconde di essere disorientato: per la prima volta in vent’anni non condurrà – «con il suo timbro inconfondibile» – l’evento più importante dell’estate a Concordia, nella provincia di Entre Ríos, Argentina. Dice che non ricorda più cosa significa vivere un’estate senza carnevale: forse, nella sua vita, non c’è mai stata.
14 Febbraio 2021
Vai qui per continuare a leggere
Derry, Irlanda del Nord
L’azienda ha sede a Londra, è specializzata in palloncini di alluminio a forma di lettere dell’alfabeto e spedisce in tutto il mondo. «Hai qualcosa da dire ma non sai bene come? Spiegalo con i palloncini!» è il loro slogan. Shannon H., una ragazza di venticinque anni che vive a Derry, Irlanda del Nord, ha fatto il suo ordine, ma le è arrivato un messaggio con scritto: «Riscontrato un problema imprevisto nel completamento».
Lynette M. dice che quando ti trovi in serie difficoltà economiche, come è accaduto a lei, e sei una donna, e qualcuno ti tende la mano per aiutarti, di solito ti chiede se hai bisogno di cibo. Difficilmente ti chiederà se ti servono degli assorbenti. È un argomento di cui non si parla. Una volta ha saputo di una ragazza che, non avendo denaro per comprarli, usava i calzini. Insieme a sua figlia Nya, Lynette ha messo in piedi a Philadelphia un piccolo centro di raccolta di prodotti sanitari e igienici per le donne.
1° Marzo 2021
Vai qui per continuare a leggere
Wuhan
Per le strade, come sempre, lanterne rosse, vetrine decorate, banchi che vendono spiedini di caramelle. Il Capodanno cinese a Wuhan è stato un esercizio di dimenticanza collettiva. Nessuno ha più voglia di parlare del virus: appena si affaccia nei discorsi, si cambia argomento. «È come se avessimo preso un anestetico», dice una donna, Mary Xu, a una cronista del Los Angeles Times. Fa la terapeuta; e spiega che dietro i silenzi, i modi evasivi, c’è ancora il dolore.
5 Marzo 2021
Vai qui per continuare a leggere
Georgetown, Ontario, Canada
Fanno anche quello che tutti vorremmo saper fare, ma che ci riesce solo in sogno: volano». Bisogna fidarsi di un grande cultore delle creature del cielo come Jonathan Franzen, romanziere e birdwatcher. Gli uccelli – dice – si trovano in ogni angolo di mondo, anche nei luoghi più inospitali; le circa diecimila specie si sono evolute «in una spettacolare varietà di forme». Alti due metri o piccoli come un’ape, «sono i rappresentanti più visibili e diffusi della vita sulla Terra prima che arrivassero le persone».
16 Marzo 2021
Vai qui per continuare a leggere
Madrid
Ha appena pubblicato, in Spagna, il suo nuovo romanzo. Al collega che lo interroga dice che parlare di sé lo annoia e che, avendo rilasciato centinaia di interviste, forse questa sarà l’ultima. Dice che ha scritto questo romanzo nei mesi del confinamento più duro, e che scriverlo è stato una sorta di rifugio. Poi dice che la vita è fatta in gran parte da ciò che ci è nascosto e che noi stessi nascondiamo.
«Sui giornali leggiamo espressioni come “scioglimento dei ghiacciai”, “temperature record”, “acidificazione degli oceani”, “aumento delle emissioni” e crediamo di capirle», scrive Andri Snær Magnason, islandese, in un bellissimo libro intitolato Il tempo e l’acqua (Iperborea). Se le capissimo davvero, dovremmo compiere subito scelte radicali. Natalie e Melanie, studentesse all’ottavo anno della Salt Lake Performing Arts, ne sono convinte.
29 Marzo 2021
Vai qui per continuare a leggere
Passeggiando per Milano, Marina M. trova due album di fotografie accanto a un bidone della carta. Li raccoglie, li sfoglia. Dentro, c’è «una storia di antica felicità: una bella sposa con un delizioso abito bianco», il papà commosso all’altare, lo sposo trepidante, un’amica che ride. Marina porta l’album a casa con sé, pubblica una delle foto su Facebook. Si fa viva con lei la moglie del testimone dello sposo.
4 Aprile 2021

“Dove eravate tutti” – processo al personaggio
Il Sole 24 Ore – Domenica, 23 ottobre 2011
Una volta, a scuola (ma forse accade ancora), veniva chiesto di prendere posizione. Leggevi un brano di romanzo sull’antologia e ti trovavi nei panni di giudice. Tu cosa avresti fatto al posto del personaggio? Ti sembra giusto che don Abbondio non abbia avuto il coraggio di ribellarsi ai bravi? E giù critiche a palate: macché, io avrei fatto questo e questo; li avrei denunciati, oppure avrei detto subito a Renzo e Lucia come stavano le cose. Si può essere più vigliacchi? Così, da una parte – quella dei buoni – c’eravamo noi; dall’altra c’erano i personaggi cattivi, condannati senz’appello al tribunale spiccio delle nostre coscienze. Almeno sulla carta dei quadernoni, eravamo coraggiosi, fedeli alle amicizie, incapaci di tradire. Eravamo puri e con la schiena dritta. Perfino all’ultimo anno di scuola superiore, fiorivano all’impazzata tesine che erano vibranti j’accuse contro l’inettitudine di Zeno Cosini, Emilio Brentani e compagnia.
Poi, siamo cresciuti. La vita ha guadagnato qualche sfumatura in più e così pure la capacità di leggere, per chi ha continuato a farlo. Importava davvero ancora giudicare i personaggi? Smarcarsi dai loro difetti, dalle loro viltà, dalle sciocchezze e dai peccati che commettevano? Tutti hanno qualcosa da farsi perdonare, e nel gruppo finalmente eravamo inclusi anche noi. Leggere poteva essere più avventuroso proprio perché compromettente: significava scendere negli abissi altrui per illuminare i propri, mandare in crisi le certezze sul nostro conto, sulla nostra stessa innocenza. Uscire da un romanzo non già rassicurati nella nostra splendente dirittura morale, ma al contrario: allarmati e indifesi.
Al tempo dei blog, di Anobii e dei social network, ogni cultore di libri ha il proprio quadernone a righe. Il cultore di cinema pure, ma appare più scafato, avvezzo a prendere non le distanze dal male rappresentato, ma a valutare il fascino e la riuscita di quella rappresentazione. Per i romanzi contemporanei, invece, è tutto un prendere di petto i personaggi. Il tanto atteso «ritorno all’etica» sta dando i suoi primi frutti nelle valutazioni letterarie? Che pasticcio. È un coro: ma perché quel personaggio di Giordano si comporta da sfigato e non si scuote? Perché proprio nessuno, in Acciaio di Silvia Avallone, ha una «parvenza di vita felice»? perché tanto degrado? Perché il ragazzino dell’ultimo libro di Ammaniti si lamenta se in realtà è solo un «viziato figlio di papà»? Perché i protagonisti dell’ultima Mazzantini hanno rapporti «così malati, morbosi, cattivi»? Non sto inventando.
È toccato anche a me. La presenza su Facebook e l’insana abitudine di spulciare i blog mi hanno messo a contatto con una furia del tutto imprevista. Dove eravate tutti ha un protagonista, Italo Tramontana, quasi trentenne – e già il dato anagrafico sembra non deporre a suo favore. Lungo tutto l’arco del romanzo non commette omicidi. Però si accorge, quasi per un’epifania, che l’intera sua vita cosciente – dal 1993 a oggi – ha coinciso con la presenza sulla scena politica di Silvio Berlusconi: esame di quinta elementare, maggiore età, scuola guida, laurea cosiddetta triennale. «Questa non è una cosa bella, né brutta. È una cosa vera». Prova a concludere una tesi impossibile sugli anni zero e nel frattempo fa i conti con suo padre, professore in pensione accusato di avere investito volontariamente con l’auto un ex alunno. La madre si assenta dal paesaggio delle certezze domestiche facendo un viaggio improvviso, e il giovane si trova tardivamente alle prese con i calzini da lavare. Mal gliene incoglie, sul piano pratico (in effetti ha qualche difficoltà con la lavatrice) e al tribunale dei recensori online. «Ventenne piagnone e ripiegato su sé stesso». «Che pena quando la mamma giustamente si rompe i c. di una famiglia così e se ne va per una meritata vacanza. Scoperta epocale: una casa non va avanti da sola! Bisogna fare la spesa, lavare i calzini, stirare e cucinare. Ma va’ là! Così il nostro eroe si trova da solo davanti al supermercato, al ferro da stiro e al soffritto. Ma non gli viene in mente di rimboccarsi le maniche e darsi una mossa. Meglio sognare davanti alla foto della Ragazza Amata e Mai Avuta». Lì per lì ho pensato a un malumore isolato. Macché: «E io dovrei sentirmi rappresentata da uno come Italo? Mi fa solo rabbia. È solo un “inetto” incapace di sciogliersi dai legacci di questa Italia in decadenza». Vai a spiegare che un personaggio è un personaggio, non è lì per rappresentare nessuno se non sé stesso. Come, tra l’altro, accade per le persone. Italo, Italo, pancia in dentro e petto in fuori! Perché non sei in piazza? Perché non prepari la rivoluzione? «Questo personaggio è un eterno adolescente, è uno che vota Berlusconi vivendo, la sua vita è troppo comoda, la sua vita è fatta di niente». Non basta: Italo è un moralista ipocrita, è un «democristiano». Ma è nato nell’83! Non basta: è assolutamente imbranato con le ragazze, non è in grado di scrivere una tesi, è in sostanza patetico e inerte. Stavo per riprendere fiato quando un’ulteriore scarica di domande mi è arrivata sul naso: «Che senso ha lamentarsi che il padre ha lasciato il libro sulla storia del socialismo nei ripiani più alti della libreria, lontano dalle mani del figlio? Ma monta sopra una sedia e prendilo, oppure vai in libreria e compralo! Quando mai è il padre che insegna al figlio a fare la rivoluzione?». Non importa che in effetti, a fine romanzo, Italo abbia cominciato a leggere quella storia del socialismo e che rimproveri sé stesso di non averlo fatto prima. L’accigliato lettore non se ne è accorto. Non importa nemmeno che da qualche parte il personaggio ammetta che la sua visione storico-politica somiglia a un cartone animato o a un fumetto, o che a un certo punto il suo processo contro il padre gli torni indietro come un boomerang. E se a lui si addebitano troppe indulgenze e mancanze, il rimprovero può allargarsi a dismisura e travolgere la sorella adolescente Anita che si innamora del «teppistello» e «carogna» investito dal padre, e via così.
Qualcuno dirà che è positiva questa visceralità nella lettura di un romanzo. Può darsi. Tuttavia, prendere per il bavero i personaggi dimostra anche un eccesso, non molto lucido, di nervosismo. Avevo scelto di porre a epigrafe di Dove eravate tutti una frase di De Sanctis – «I popoli, come gl’individui, al pendio della decadenza diventano nervosi, vaporosi, sentimentali» – ritenendo che nei tre aggettivi ci fosse il senso del libro (del modo, perfino, d’essere scritto) e la verità sui suoi protagonisti. Tanto mi bastava, senza condanne né assoluzioni. Chiedere a Italo di stare sulle barricate sarebbe come chiedere al Brentani di Senilità di cambiare abbigliamento e pettinatura. I personaggi sono come sono: migliori o peggiori di noi. Talvolta ci somigliano. Pretendere da loro ciò che non pretenderemmo da nessuno – rinunciare a ciò che sono; amare, soffrire di meno o di più; essere più intelligenti o più energici; contribuire, che so, alla primavera araba – è forse piuttosto sciocco. Vanno lasciati nei romanzi, e giudicati al tribunale della letteratura, non a quello della coscienza. Ecco dov’è che vince don Abbondio. Tra l’altro, lo confesso, io ho sempre tifato per lui.
Paolo Di Paolo

PdP
Qui racconto qualche tappa della mia “formazione“.
I miei libri
Romanzo senza umani, Feltrinelli 2023.
Trovati un lavoro e poi fai lo scrittore, Rizzoli 2023.
Il giorno in cui la letteratura morì, Tetra 2023.
I desideri fanno rumore, Giunti 2021.
Montanelli. Vita inquieta di un anti-monumento, Mondadori 2021.
I classici compagni di scuola, Feltrinelli 2021.
Quello che possiamo imparare in Africa – con Dante Carraro, Laterza 2021.
Svegliarsi negli anni Venti, Mondadori 2020, seconda edizione Mondadori 2023.
Sold out, Laterza 2019.
Lontano dagli occhi, Feltrinelli 2019. Traduzioni: Francese.
Esperimento Marsiglia, EDT 2019.
La classe operaia va in paradiso, drammaturgia per spettacolo teatrale, 2018
Papà Gugol, Bompiani 2017 – audiolibro.
Vite che sono la tua. Il bello dei romanzi in 27 storie, Laterza 2017.
Una storia quasi solo d’amore, Feltrinelli 2016 – audiolibro. Traduzioni: Francese, Tedesco.
Tempo senza scelte, Einaudi, 2016.
Istruzioni per non morire in pace, Edizioni di Storia e Letteratura 2015.
La Divina Commedia, La Nuova Frontiera Junior 2015.
Giacomo il signor bambino, Rrose Sélavy Editore 2015.
Viaggio a Roma con Nanni Moretti, Bompiani, 2016 (1° ediz. Lozzi Publishing 2015). Traduzioni: Francese.
Raccontami la notte in cui sono nato, Feltrinelli 2014 (1° ediz. Giulio Perrone Editore 2008) – audiolibro. Traduzioni: Olandese.
Perché non sono ancora. La resurrezione, Effatà Editrice 2014.
La mucca volante, Bompiani 2014 – audiolibro. Traduzione: Cinese.
Tutte le speranze. Montanelli raccontato da chi non c’era, Rizzoli 2014.
Ci ha raccontati come nessuno. Fellini visto dagli scrittori, Empirìa 2013.
Piccola storia del corpo, con Alma Gattinoni e Giorgio Marchini, Giulio Perrone Editore 2013 (1° ediz. Edilet 2008).
Mandami tanta vita, Feltrinelli 2013 – audiolibro. Traduzioni: Francese, Albanese, Greco.
La fine di qualcosa. Scrittori italiani tra Novecento e Duemila, Giulio Perrone Editore 2012.
La miracolosa stranezza di essere vivi, Feltrinelli 2012 (eBook). Traduzioni: Inglese.
Dove eravate tutti, Feltrinelli 2011 – audiolibro. Traduzioni: Francese, Greco.
I libri sono figli ribelli. Tappe e segreti dell’avventura editoriale, Giulio Perrone Editore 2011.
Scusi, lei si sente italiano?, con Filippo Maria Battaglia, Laterza 2010.
Dove siamo stati felici. La passione dei libri, Filema Edizioni 2009.
Questa lontananza così vicina, Giulio Perrone Editore 2009.
Raffaele La Capria. Risalire il vento, Liaison Editore 2008.
Queste voci queste stanze, con Elio Pecora, Empirìa 2008.
Ogni viaggio è un romanzo. Libri, partenze, arrivi, Editori Laterza 2007.
Come un’isola. Viaggio con Lalla Romano (1906-2006), Giulio Perrone Editore 2006.
Ho sognato una stazione. Gli affetti, i valori, le passioni, con Dacia Maraini, Editori Laterza 2005.
Un piccolo grande Novecento, con Antonio Debenedetti, Manni 2005.
Nuovi cieli, nuove carte, Edizioni Empirìa 2004.
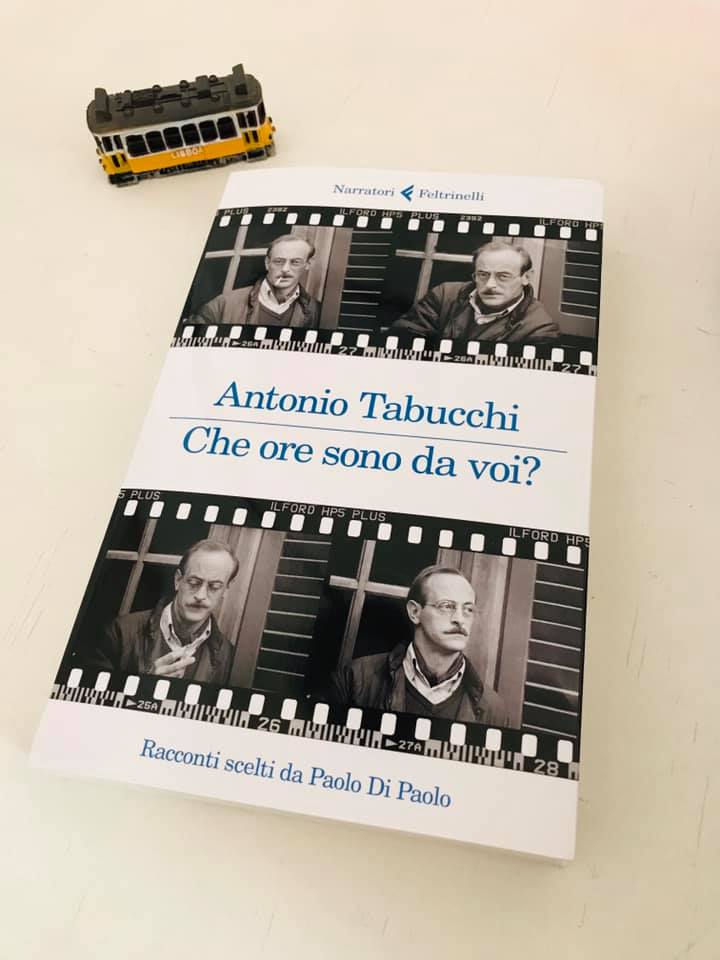
Che ore sono da voi?
Ho curato per Giangiacomo Feltrinelli Editore una scelta dei grandi racconti di Antonio Tabucchi. L’abbiamo chiamata “Che ore sono da voi?” – come una domanda che lui, dal suo altrove, pone a noi.
Ci sono due inediti e alcuni dei più bei testi scritti fra il 1981 e il 2011. Trent’anni di storie, un timbro inconfondibile. Per i molti che conoscono solo “Pereira” sarà una scoperta. E per chi non li legge da anni, una riscoperta.
È stato uno dei pochi autori italiani capaci di varcare frontiere internazionali, di farsi amare nel mondo, di farsi riconoscere nel mondo, non somigliando a nessuno. Aprite e leggete il primo racconto, “Lettera da Casablanca”, e ditemi se non è un piccolo capolavoro.
*
In un tardo pomeriggio di primavera, a Parigi, mentre cucinava del pesce, mi aveva chiesto di sedermi al computer e di trascrivere un racconto a cui stava lavorando. Non sono sicuro di riuscire a orientarmi fra le correzioni, gli avevo risposto.
Te lo detto io, mi ha rassicurato.
E così, dalla cucina, Tabucchi faceva a voce il suo racconto; e c’erano gli a capo, e le virgole, i due punti, gli aggettivi che, se gli suonavano male, mi faceva cancellare. Fuori, nel frattempo, era diventato buio. E io avevo acceso le luci, lui aveva spento i fornelli, e si era affacciato per guardare il racconto che aveva preso forma sullo schermo del mio computer.
Che te ne pare?, mi ha chiesto.
Preoccupato di avere fatto qualche errore, gli ho chiesto di darmi le sue carte per controllare.
Quali carte?
Mi ha sorriso – il suo sorriso divertito, giocoso. Poi ha detto: la cena è pronta. Ho cercato i fogli, ho insistito: da dove l’hai letto?
Dalla mia testa, ha risposto.
Antonio Tabucchi, Che ore sono da voi? Feltrinelli
*
Il podcast – La voce di Tabucchi
Nell’archivio della casa editrice Feltrinelli abbiamo ritrovato tre dialoghi con la voce viva del grande scrittore. Un’occasione per ascoltare davvero Tabucchi ed emozionarci. Perché – come lui stesso scriveva – la voce è un mistero. “Voce, vita. I fonologi sostengono che la voce imita il ritmo vitale, perché segue il principio della respirazione. Ogni frase che pronunciamo nasce, cresce, si stabilizza, decresce, muore. Respira con noi. La voce crea, la voce salva. La voce ha un potere magico”.

Tempo senza scelte
La scelta è dubbio, responsabilità, costruzione di sé e del futuro. Ma dove la Storia non chiede risposte nette, dove si è esposti a miriadi di opzioni evanescenti, è ancora possibile prendere decisioni radicali, accettare il rischio, percorrere una strada fino in fondo?
Tempo senza scelte, Einaudi, 2016
Panorama, 9 ottobre 2016, di Michele Lauro
Con Monica Mondo per Soul, Tv2000:

L’esistenza interiore di una città. Calvino e Roma
È arrivato alla fine della sua esistenza, Calvino, quando risponde alle domande che Maria Corti gli ha posto per la rivista “Autografo”. «Credo che ci rivedremo negli Stati Uniti quest’autunno» scrive in un biglietto che accompagna l’intervista. È nella sua casa di Roccamare, sta lavorando alle Lezioni americane (sarà colpito da un ictus il 6 settembre 1985 e morirà a Siena il 19). Corti l’aveva interrogato a tutto campo sulla sua formazione intellettuale e letteraria, sul disegno d’insieme della sua produzione, sull’identità del suo linguaggio, sulle fasi del processo creativo. Una risposta ampia Calvino la dà riguardo agli «ambienti naturali e culturali» in cui è vissuto: Torino, Roma, Parigi. Parte in verità da New York, che – per sua stessa ammissione – si vede «pochissimo» nelle sue storie. Vale lo stesso per Parigi:
Il fatto è che molti dei miei racconti non si situano in alcun luogo riconoscibile. Forse per questo rispondere a questa domanda mi costa un certo sforzo: per me i processi dell’immaginazione seguono itinerari che non sempre coincidono con quelli della vita.
Se il paesaggio natale e familiare «non si può respingere o nascondere» (e Sanremo – rivela – è presente in molte delle Città invisibili), se Torino, definita «guardinga», va pensata anche «come scelta culturale», riguardo a Roma – «centro di residenza d’un gran numero di gente che scrive» – Calvino riflette in questi termini:
Sto bene solo quando non ho da pormi la domanda: «perché sto qui?», problema da cui si può prescindere di solito nelle città che hanno un tessuto culturale così ricco e complesso, una bibliografia così sterminata da scoraggiare chi fosse tentato di scriverne ancora. Per esempio, a Roma da due secoli in qua vivono scrittori d’ogni parte del mondo che non hanno nessuna ragione particolare di stare a Roma più che altrove, qualcuno di loro esploratore curioso e congeniale dello spirito della città (Gogol’, più di tutti), altri approfittando dei vantaggi di sentirsi straniero.
Non sono molte altre le occasioni in cui lo scrittore parla di Roma. Il suo indirizzo di Piazza di Campo Marzio appare in calce alle lettere dei primi anni Ottanta, ma sarebbe difficile – dai dati testuali – dedurre che si tratta del teatro di alcuni episodi di Palomar (1983). Lo conferma Chichita Calvino, anche per ciò che riguarda l’episodio del geco, in cui la città non è nominata:
Sul terrazzo, come tutte le estati, è tornato il geco. Un eccezionale punto d’osservazione permette al signor Palomar di vederlo non di schiena, come da sempre siamo abituati a vedere gechi, ramarri e lucertole, ma di pancia. Nella stanza di soggiorno di casa Palomar c’è una piccola finestra-vetrina che s’apre sul terrazzo […].
Anche la città, dunque, benché spesso innominata entra negli esperimenti di Palomar, nel suo scrutinio della superficie delle cose.
«Solo dopo aver conosciuto la superficie delle cose, – conclude, – ci si può spingere a cercare quel che c’è sotto. Ma la superficie delle cose è inesauribile».
È dunque un’illusione, quella coltivata da signor Palomar? Lo è, quasi certamente lo è. Eppure i suoi esercizi di osservazione (esercizi di lettura, si potrebbe dire, seguendo il titolo del primo capitolo del libro) vengono compiuti con assoluta concentrazione e precisione, quasi che l’impegno – un impegno profondo, totalizzante – possa condurre, di per sé solo, alla riuscita dell’impresa.
Da qualche parte bisognerà cominciare. Palomar sceglie un’onda; la vede spuntare in lontananza, la vede «crescere, avvicinarsi, cambiare di forma e di colore, avvolgersi su sé stessa, rompersi, svanire, rifluire». Poi, sceglie un seno nudo di donna, e ancora: il riflesso del sole sull’acqua, due tartarughe in amore, il fischio attraverso cui comunicano i merli, il prato intorno casa («costituito di dicondra, loglietto e trifoglio»), la luna di pomeriggio, i pianeti visibili a occhio nudo, le stelle nel cielo d’agosto, la vegetazione sul terrazzo, un geco, l’invasione degli storni nel cielo di Roma, un negozio di formaggi, una macelleria, lo zoo di Vincennes, lo zoo di Barcellona e più nello specifico la gabbia del gorilla albino, un giardino zen, le rovine di Tula in Messico, una pantofola spaiata acquistata in un bazar orientale.
Questo ostinato guardare, questo accanito cercare i dettagli, attendere che schiudano il loro mistero, è una sfida dell’intelligenza. Dentro e oltre il senso dell’etimo: leggere dentro, a fondo; leggere dentro il già letto («Viviamo in un mondo – scrive Calvino – dove tutto è già letto prima ancora di cominciare ad esistere»). Palomar tenta di recuperare «una porzione, sia pure minima, di spazio non colonizzata dalle parole generiche e astratte» (Silvio Perrella). Quanto più è minuta la cosa osservata, tanto maggiore è la possibilità che sia detta con parole nuove, quasi ripartendo da zero, da una mente di nuovo vergine, resa pressoché tabula rasa. «Il signor Palomar ha deciso di limitarsi a guardare, a fissare nei minimi dettagli il poco che riesce a vedere, tenendosi alle idee immediate che gli suggerisce ciò che vede».
Gli occhi di Palomar sono occhi miopi («occhio nudo per lui che è miope significa occhiali»). Per scrutare il firmamento, usa il telescopio. In questo rapporto tra vicino e lontano, tra «pathos della distanza» (Cesare Cases) e quello che si potrebbe per contrasto definire «pathos della vicinanza», si gioca molto dell’opera di Calvino. La sempre più inquieta e perfino dolorosa contemplazione dell’altro da sé – oggetto, pianta, animale, essere umano, stella o città – diventa davvero una «celebrazione del vedere», del vedere-pensare. Il mondo esiste perché lo vedo (lo penso), io esisto perché vedo (penso) il mondo, e dunque anche la città, questa antica città che «si lascia corrodere dal basso e dall’alto senza opporre più resistenza che altravolta alle invasioni dei barbari, come vi riconoscesse non l’assalto di nemici esterni ma gli impulsi più oscuri e congeniti della propria esistenza interiore».

Esperimento Marsiglia, le prime pagine
Allora, tieni presente che le chiavi le trovi nel panificio dell’egiziano. Tanto perché tu non faccia pasticci. Entra, lo vedi subito, sta all’angolo, cioè fa angolo con due strade, come si dice? un incrocio, insomma tu entra e chiedi di me. Cioè, di’ che sei lì per conto mio, e se tutto va come deve, l’egiziano – alzando gli occhi al cielo, o guardandoti comunque senza alcuna simpatia – ti lascerà le chiavi. A quel punto, guardando il panificio, vai a destra e scendi per quella strada, che si chiama rue des Petites Maries, considera che il portone è un po’ duro, non ti scoraggiare, insisti, sei un uomo no? Entri, ti trovi sulla destra subito la cucina, sopra c’è la camera, la scala è un po’ stretta e ripida, c’è sempre qualcuno che si lamenta, ma ritengo che sia un po’ sciocco lamentarsi per così poco. Cioè, voglio dire, per undici gradini stretti, o dodici che siano, c’è di peggio. La camera accanto alla tua è occupata, ma è una coppia tranquilla, gente che tutt’al più fa l’amore di pomeriggio, ho la sensazione che abbiano una loro precisa routine: che escono al mattino, fanno colazione fuori – d’altra parte gli ho indicato una meravigliosa boulangerie, benché anche l’egiziano, devo dire, fa ottimi dolci –, se la spassano per la città – pare siano appassionati d’arte contemporanea, pranzano da qualche parte e poi rientrano come fanno certe coppie più mature per riposare un po’, ma loro non riposano, a quanto deduco, hanno un appuntamento fisso con i loro corpi, il che potrebbe essere segno di buona salute e di giovinezza, o forse del fatto che stanno provando ad avere un bambino, ma mi rendo conto che questi sono affari loro. Lo dicevo perché hanno la stanza già da una settimana, ne hanno ancora un’altra e c’è chi si è lamentato, cosa che ho trovato francamente eccessiva. A dire il vero, non è stata una lamentela, più che una lamentela, una considerazione, del tipo: poi quei due ragazzi della stanza accanto ci danno dentro eh. Che è una frase in cui non capisci se c’è più tenerezza per i loro sensi surriscaldati o più invidia. Non importa. Lo dicevo per completezza di informazioni. Poi, suppongo che tu non sia né intenerito né invidioso, e che abbia altro da fare, o che trovi i gemiti di due giovani che fanno l’amore gradevoli – come un cinguettio che arriva da un albero o, che ne so, il vento della sera nelle città portuali come questa: arriva come da una porta che qualcuno ha spalancato all’improvviso, e cambia il colore delle cose, lo rende più tenue e vagamente più malinconico. A proposito di meteorologia, che è una delle mie passioni principali, principale dopo il cibo – ma si tratta proprio di tirare una riga: il cibo, e sotto, ma molto sotto, tutto il resto, ecco, dicevo, a proposito di meteorologia, qui il vento va considerato con una certa attenzione, per esempio se intendi fare una di quelle escursioni vagamente atletiche che si fanno alle Calanques, se c’è troppo vento non se ne parla; e a meno che tu non sia interessato al surf, è l’unica ragione per cui tu debba interessarti alla questione. Ma mi stavo concentrando sulla meteorologia, al di là dei miei specifici interessi, in virtù del fatto che non sei stato salutato da una bella giornata, cosa – la giornata nuvolosa – che a Marsiglia di per sé è un’eccezione, e comunque non un’eccezione che mi piace occorra davanti a un nuovo arrivato. Quando il rischio di fidarsi della prima impressione può portare seriamente fuori strada. Non registro con fierezza questa imprecisione del cielo nel giorno del tuo arrivo, questa lente sporca dietro cui hai guardato Marsiglia, arrivando al porto, come ingiallita o ingrigita, perché si è trattato di una colorazione simile a quella che assumono le pagine di certi libri in un punto preciso a eguale distanza fra l’essere nuovi, cosa che non sono più, e l’essere davvero vecchi, cosa che non sono ancora. Hai presente? Ecco. Marsiglia ti si è mostrata con quel colore lì, che pure in qualche modo è suo, di chi mai invecchia e pure non è più giovane, ma doveva restare nascosto, intuibile ma non esplicito. Il colore più netto, squillante è stato quello di un ragazzino nero che giocava a calcio con una t-shirt giallo fosforescente, proprio a un passo da due vecchietti – uno con la camicia a quadri infilata nei pantaloni, l’altro con la maglietta a righe fuori dai pantaloni – che stavano animatamente discutendo di giocatori che magari saranno sostituiti, o per meglio dire caparbiamente marcati stretti, fra nemmeno dieci anni, dal ragazzino nero che giocava a calcio con la sua maglia fosforescente. Non farti ingannare dall’aria dimessa di quei vecchietti, non farti ingannare da niente: perché se c’è una cosa che Marsiglia sa fare bene è proprio questa – ingannare. Come ti inganna l’aria da galeone maestoso di uno stupido yacht ormeggiato. O come ti inganna lo struggimento a cui non sai dare un nome alle 19.51 di un giovedì di agosto. Ma bisogna darglielo, poi? chi ne ha bisogno? E come ti ha ingannato, per arrivare al punto, la fame, a ondate, da stamattina: da quando sei entrato nel panificio dell’egiziano per recuperare le chiavi, ma il suo sguardo per niente simpatico ti ha inibito; e poi ancora, quando sei entrato in casa, vedendo un barattolo di marmellata sul tavolo, e più tardi, lasciandoti ispirare solo dal solo nome bouillabaisse, che suona così squinternato, labiale e fricativo, una specie di tamburo della gastronomia locale, di cui è meglio diffidare finché non sia il momento giusto. Hai placato il placabile con un croissant troppo unto e dopo mezzogiorno con una baguette farcita di burro e pasta d’acciughe, invitante ma grosso modo prevedibile, ti ha fatto salire una sete pomeridiana persistente, e nemmeno il caffè ha cancellato il crepitio del sale sotto la tua lingua. Sei in tempo per azzerare tutto a cena, l’indirizzo è chiaro, rue des Trois Rois, puoi arrivarci con calma, questa non è Francia, o non pienamente, questo è sud, prenditela comoda, e goditi il chiacchiericcio fitto delle sere estive, questa specie di frenesia da fermi, questo luccichio di denti giovani dietro i calici col vino ancora ghiacciato, le cartine per tabacco trinciato hanno la stessa consistenza delle lanterne cinesi, in questo tempo che pare sospeso e che fai bene a sospendere, perché è utile sprofondarci dentro, sederti a un angolo dello spiazzo che si apre appena dietro la strada che a breve imbocchi – e non sapere più quanti anni hai. Nemmeno ti tocca l’aria stranita dei fidanzati che cercano un posto economico dove fermarsi – lui più sciolto, lei nervosa per le sorti del budget residuo, finiranno per non parlarsi a tavola, o per litigare più tardi, prendendo il via da quelle frasi che iniziano male, con se mi avessi dato retta. E non ti tocca il cipiglio un po’ stronzo dei viaggiatori adulti, la spocchia di chi teme di non essere servito bene ancora prima di aver ficcato le zampe sotto un tavolo.
E insomma, sei tu, sei pronto a battezzare te stesso e la città come se tutto fosse nato oggi, e a goderti – in quel cicaleccio masticatorio che sarà fra poco rue des Trois Rois – lo spettacolo di ciò che gli umani fanno con più disinvoltura. Mangiare. Soprattutto se davvero affamati, si dispongono all’impresa con una freschezza, una vitalità, un’assenza di pregiudiziali che sorprende, tanto più se si considera che anche un ventenne, arrivato a quell’altezza della sua biografia, ha già consumato qualcosa come, a occhio, ventiduemila pasti, eccettuando quelli frazionati e ossessivi della primissima infanzia. Un vero miracolo, non trovi? E se è vero, come credo sia vero, che viaggiare mette fame, meglio così, fai conto che stai assaggiando la città, fai conto che stai assaggiando Marsiglia, in senso metaforico, se così si dice, e letterale allo stesso tempo – coincidenza fra astratto e concreto che di rado, o forse mai, capita in altre occasioni. Attendi ancora qualche istante, indugia. Poi ti dico da dove cominciare.
Le chiavi di una città
Le cose essenziali, in un arrivo, quali sono? Sfogliare una guida? Ruvida e non sempre bella – dice, di Marsiglia, questa guida. Non è certo Cannes o Saint-Tropez. Dice che vanta millecinquecento anni di storia. Dice che a lungo ha avuto una pessima reputazione: criminalità, degrado. Dice che spesso è stata denigrata ingiustamente. Dice che il cuore antico della città è il quartiere Le Panier. Dice che nel vecchio porto le navi gettano l’ancora da oltre ventisei secoli. Guardo la mappa, non riesco mai facilmente a capire, a orientarmi. Credo sia proprio qualcosa che mi manca, come una vite nei marchingegni della testa, un rocchetto senza il suo filo. Così guardo Marsiglia sporta sul mare e mi faccio le canoniche domande: sui punti cardinali della geografia e della conoscenza in genere. Quand’è che uno può dire di conoscere qualcosa? Quand’è che uno può dire di conoscere davvero una città? Non basta esserci nati, non basta nemmeno viverci. Forse una città non la conosciamo mai, mai per intero – c’è sempre troppa vita altrove, materia umana o comunque viva che ci sfugge. Posso dire di conoscere il vicolo, la finestra su cui la pioggia ha lasciato i suoi ghirigori di calcare, posso dire di conoscere non il mistral in assoluto ma il modo preciso in cui si incanala sotto il portone dell’appartamento di cui sono ospite e fa volare le cartacce come schegge leggere e un po’ mette in agitazione. Una città è soprattutto il resto delle cose escluso me, gli infiniti punti in cui non sono. Lo sbuffo di un autobus, il rumore di una trivella, il rumore della risacca costante, disperso, il tuffo di qualcuno, un’attesa, i ragazzini che mangiano gaufre al cioccolato con una splendida voracità, i vecchi che si trascinano, e una sottovita che resta notturna anche di giorno, uomini e topi, nei tombini, nei cessi delle stazioni, in qualunque luogo che coincida con un segreto, secretum, appunto, appartato, separato, staccato da. Avere un’idea completa di una città è come avere un’idea completa del mondo, è presunzione e illusione. E tuttavia, c’è un momento – non è facile isolarlo – in cui di una città dici mia, la mia città, e lì dev’essersi depositata una opportuna, sufficiente somma di ricordi sulle strade, sulle piazze, sulle rotonde, i balconi, i parchi, perché quel possessivo indichi un’appartenenza.

Pasolini, l’inattuale che non dà lezioni
Mi piace Pasolini, non mi piacciono i pasoliniani. Mi piace la vitalità – disperata o no che sia – di chi non si risparmia, di chi non calcola mai la quantità di energia da spendere. Né il rischio che quello spendersi produce. Mi piace un verso di Zanzotto che, parlando di lui, dice che «era dappertutto con la sua passione di tutto». Mi piace la serietà: il fatto che in pubblico non ridesse praticamente mai – ciò che l’avrebbe reso inadatto ai social, e ciò lo rende abissalmente distante dalla fiera del ghigno, della risata permanente, a cui purtroppo contribuiscono anche gli scrittori. Mi piace l’autorevolezza, il credito guadagnato in fretta, con ostinazione; e nonostante le vessazioni, le ostilità aperte, le espulsioni. Quando pubblica Ragazzi di vita ha trentatré anni. Quando gira Accattone non ne ha compiuti quaranta. Mi piace il fatto che non perdesse tempo.
Mi piace il suo continuo sperimentare, forme e generi; il suo cercare lingue e linguaggi: il friulano delle origini per dire l’idillio disperso, il romanesco, acquisito, studiato, per dire la vita di borgata, e ancora, l’italiano aulico, l’italiano giornalistico, l’italiano illuminista, l’italiano contorto, l’italiano sciatto, l’italiano sensuoso. E la lingua del cinema: per superare i limiti della lingua italiana. Mi piace il fatto che, al contrario di quanto si dica – attualizzandolo in modo frivolo – sia al fondo inattuale. Ma l’Inattuale è spesso lo spazio abitato dagli intellettuali autentici, che non sono, come si crede, profeti. Mi piace il contraddirsi, anche davanti a ciò che non capiva, che si sforzava comunque di capire. Il tono perentorio con cui, in una “lettera luterana” a Calvino, così diverso da lui, gli domanda più volte: ma perché questo? Perché questo? Mi piace che molte sue convinzioni risultino tuttora inaccettabili per gli stessi che lo ammirano, e che fingono di dimenticarle, di non vederle, o – molto più banalmente – non le conoscono. Intanto, si scattano un selfie con la sua icona alle spalle. Mi piace che suscitasse e possa ancora suscitare anche profonda antipatia: in un racconto di Parise, intitolato proprio “Antipatia”, appare un intellettuale con una «faccia ossuta a forma di pugno» e una «voce dolcina». Non nasconde di detestarlo, di detestare, dietro quella maschera, «il Pasolini Castigatore», la coscienza della Nazione, la vittima sacrificale.
Mi piace che non vi sia nessuna lezione, nessuna eredità, nessuna concreta possibilità di imitarlo o di seguirne la strada; ed è patetico chiunque se lo proponga o se lo sia proposto. Mi piacciono anche le pagine oggettivamente brutte, imperfette, irrisolte, superflue, di un’opera che ha nella sua esuberanza, nel suo sperpero, nella sua enormità la sua forza: più nell’impressionante sequenza dei gesti, che nel gesto singolo. Mi piace, dietro tutto ciò che pure risulta sgradevole, l’irriducibile tenerezza, la capacità di sentire le cose, tutte, una per una – il rotolio dei tram, le dita che contano i soldi, le urla dei ragazzi davanti al rombo del mare, la città, in un colore eterno d’estate, e i corpi che siamo. E la sera che, «benché triste, così dolce scende / per noi viventi».
L’Espresso, 25 ottobre 2020

La nostalgia del presente che ti muore fra le mani – The dreamers
“…fermarmi un istante e guardare, come se facessi parte della storia, un cespuglio che si mette a tremare… Il cespuglio può diventare importante. O una porta che sbatte.”
(B.B.)
Quando viene intervistato sulla propria infanzia da Dacia Maraini (E tu chi eri?, 1973), Bernardo Bertolucci richiama una serie di dettagli che valgono ciascuno una poesia. L’odore del padre Attilio: «un odore di mandorle amare. Un odore intenso che lo circondava come un alone. Un odore che rimaneva nei posti dove lui era stato, nelle cose che aveva toccato». Poi, l’odore del nonno – «di testa calva. L’odore delle nove di sera, buono, dolce». La vestaglia a fiori della madre. Lui stesso, Bernardo bambino, seduto dentro un paniere che sua madre portava legato al manubrio della bicicletta. Le rane infilzate – torneranno in una scena di Novecento. L’«elaboratissima e festosa» cerimonia dell’uccisione dei maiali, in campagna. L’infanzia – che uno si porta dietro «come i cacciatori si portano appresso il fango e le foglie incollate agli stivali».
Nel dialogo con Maraini, Bertolucci riconosce di essersi mosso a lungo in «un paradiso terrestre in cui la realtà poetica e la realtà naturale si confondevano». E se questa frase potrebbe essere letta come un’epigrafe per l’intera sua opera cinematografica, ce n’è un’altra che ha funzionato per me da rivelazione. Lui la lascia cadere lì, in un discorso, ancora una volta, intorno all’illustre padre. Tra le cose sue, dice, che mi sono rimaste addosso, una è «la necessità di vivere la vita quotidiana in maniera non traumatica, e sempre celebrativa». L’altra è la nostalgia. La nostalgia di che?, domanda Maraini. «La nostalgia del presente che ti muore fra le mani», risponde Bertolucci.
Si scioglie in questa frase un grumo. Lo sentivo fermo in gola mentre andavano sullo schermo – in un pomeriggio estivo dell’adolescenza (troppa luce fuori: avevo abbassato gli scuri per “fare il cinema”) – i fotogrammi di Novecento. L’ho sentito mentre – coetaneo dei protagonisti, nel 2003 – guardavo The Dreamers come un racconto più sensuale che politico, o sensualmente politico (cosa difficilissima). Ma c’è in Bertolucci una verità del corpo che arriva prima di quella delle parole, ovvero delle idee. Ingenuo dirlo quando si parla di un cineasta? Forse sì, e tuttavia poche volte ho sentito così intensamente la verità dei corpi nel cinema italiano del ventesimo secolo. Parlando del Tè nel deserto, Bertolucci stesso ha chiarito il suo tentativo di fare un film «sulla fisicità, sulla sensualità, sostituendo le parole di Bowles con i segni e i gesti tracciati dai corpi, quasi che la fisicità potesse sostituire la psicologia».
Ma torniamo indietro: la schiena di Fabrizio in Prima della rivoluzione. Si contano le vertebre – il bianco e nero le fa risaltare come in una fotografia di Mapplethorpe. Gina/Adriana Asti che si stringe un seno nel sonno.
Trent’anni dopo, in Io ballo da sola, il gesto di Lucy/Liv Tyler che nasconde una fotografia di sé stessa bambina nel reggiseno. Il suo bagno in piscina con un costume nero. Richard che si tuffa nudo mentre lei è ancora in acqua e gli dà le spalle.
Fatico a tradurre in parole la sensazione, confusa e violenta, che mi arriva da scene come queste. E bisogna intanto aggiungere che concorre a produrla una particolare relazione – anch’essa di natura lirica, elegiaca – fra i corpi e il clima. La pioggia fuori (dopo una scena d’amore in Prima della rivoluzione, o mentre il ragazzo Matthew, in mutande, scrive una lettera a sua madre, in The Dreamers). Per un regista di soprammobili, come ironicamente si definiva, possono fare la differenza anche le piastrelle bianche e azzurre di un pavimento – su cui si stendono due giovani corpi nudi. Può la scena di un film sollecitare il tatto, far sentire quasi il brivido sulla pelle nel contrasto caldo/freddo? O ancora, in esterno: la luce dell’estate, di pomeriggi che sembrano interminabili e durano in verità il tempo di un tuffo, il tempo di una canzone.
Torno alla scena del pavimento: ancora The Dreamers; Matthew e Isabelle fanno l’amore distesi a terra, involontarie controfigure giovani dei due di Ultimo tango, che sono invece incupiti, atterriti, brutali (hanno perso – da troppo – l’innocenza; hanno perso la giovinezza). Matthew e Isabelle gemono, mentre Théo fuma una sigaretta e cuoce un uovo al tegamino. Li guarda, distratto e ingelosito insieme. Non voglio eccedere con l’enfasi, ma il tempo in cui l’uovo si rapprende, frigge nel tegame è un tempo poetico straordinario, e perfino rivelatore.
Se si potesse parafrasare davvero questa sequenza, direi che in essa si incarna, prende corpo – come molte altre volte in Bertolucci – l’Irripetibile. Isabelle perde la verginità. L’uovo frigge nel tegamino. Théo si avvicina, si inginocchia accanto a Isabelle, la accarezza. Una luce tenue entra nella cucina – stanza chiusa, difesa come un guscio, con le sue piastrelle, i suoi oggetti mai davvero inanimati («Mia moglie dice che riuscirei a fare sembrare sensuale anche una tazza di tè»). I rumori lontani della città. Tutto questo è irripetibile, è la verità del presente – la sua intensità, un fascio di sensazioni – che si dà nell’istante e poi muore, «ti muore fra le mani». Il primo spettatore non sono io che guardo il film; il primo spettatore è Bertolucci stesso: il suo occhio si insinua nelle pieghe dell’evento, insiste sui dettagli, fa lo sforzo di trattenerli, è un occhio che desidera. Ma anche è l’occhio di chi sta fuori dal tempo, o in un tempo diverso in cui quel presente è già morto, è già svanito.
Una volta Bertolucci, ragionando sul senso del tempo nel lavoro cinematografico, ha spiegato: «Quando dico “stop” è passato un certo periodo di tempo: in questo periodo di tempo gli attori davanti alla macchina da presa sono invecchiati, si sono avvicinati in qualche modo alla morte». È in questo, è nel lungo, lunghissimo attimo prima dello “stop” che Bertolucci riesce – maestosamente – a celebrare la quotidianità. Attivando così quella specialissima nostalgia del presente che è un tratto essenziale del suo cinema. E che mi dà l’impressione di poter ricordare come parte del presente che mi è morto fra le mani, l’indolenza e la rabbia di Fabrizio che dice «Per me è già molto andare via di casa», lo stupore calmo di Lucy che nuota in piscina, la foga del ballo solitario di Lucy, la dolcezza di quello di Olivia, sedici anni dopo, nella cantina di Io e te. Un uovo che frigge nel tegamino, continua a friggere: per sempre, per un attimo.
da Bianco e Nero – Rivista quadrimestrale del CSC, numero dedicato a Bernardo Bertolucci

Lubrico. Sul Casanova
Lubrico
Prima di tutto, c’è l’acqua. Si può dire che il film abbia preso il colore dell’acqua di Venezia: non del cielo, dell’acqua – scura, scintillante di notte, anche fetida, gorgogliante come perennemente gorgoglia nei canali. C’è anche il canonico mare-telone, sì. Ma nel Casanova l’acqua è soprattutto quella chiusa, inscatolata nella geometria della città; emana odore, a vampate, ne intuisci la presenza da piccole finestre, la dai progressivamente per scontata. Come a Venezia, nei fatti, accade. È un inchiostro, una colla scura che si salda alla tinta del cielo notturno, rischiarato dai fuochi del carnevale, o aperto come cateratta mentre diluvia.
Fellini “chiude” Venezia, ne fa un interno, una boule dai vetri opachi, sporchi. E la agita – anti-turistica com’è, la scuote: il letto a baldacchino scivola da un lato all’altro, sbanda, mentre si consuma l’ennesimo amplesso. La scuote con divertimento un po’ sadico da bambino invecchiato, mentre la condensa dei vapori acquei appanna gli specchi e si deposita sulla superficie del mondo, rendendolo umido – e lubrico – come lo sguardo di Casanova, come lo sguardo di Fellini. Umido, quando è sul punto di piangere: accade più volte. È il pianto infantile durante il discorso della marchesa sui tesori spirituali e sull’eternità. Umido dopo ogni orgasmo, come l’epidermide sudata. La liquidità dell’intero film è confermata dalla somma di umori, in senso letterale. Un ingorgo liquido: pianto, sudore (abbonda sulla fronte e sulle guance di Donald Sutherland) – e sperma, che pure resta invisibile.
Nella scena del nubifragio – Casanova è in carrozza a Parigi – c’è come una intensificazione della presenza acquosa: piove in abbondanza, Giacomo è eccitato dal viaggio nella capitale francese (celebra con esclamazioni infantili la città di Mazzarino e Voltaire) e inizia a masturbarsi. Diluvia, la carrozza attraversa un muro d’acqua che la mette in pericolo e lui si tocca freneticamente, fino alle soglie di un orgasmo che coincide con l’incidente in cui la carrozza si ribalta. Casanova ha celebrato il proprio cuore «giovane e ingordo» e si è rivolto direttamente al suo sesso: «Tu sei Parigi!» gli dice, chinando lo sguardo verso il pube. Fellini ci mostra poi la mano impazzita del libertino, l’ennesimo atto meccanico esagitato, qualcosa di ginnico, di scomposto, di esaltato. Nella carrozza-bolla, il desiderio di Casanova manifesta per intero il suo egotismo, la sua autoreferenzialità. Così la vita del libertino rivela il suo cuore masturbatorio – ed è una scena di masturbazione diversa da quelle cameratesche di Amarcord, col cigolio dei sedili di un’auto parcheggiata, o di La città delle donne, di nuovo collettiva, sotto un ampio lenzuolo. Non c’è nessuna dolcezza, nessun sogno adolescente: irreversibilmente adulto, Casanova esaspera una letizia che è come spiritata, ride e gode, gode e ride, ride sino quasi a piangere. La sua protesta contro il mondo a cui appartiene – quello dei cresciuti, dei destinati a invecchiare – è in quella ridicola e invincibile smania onanistica nella carrozza che traballa sfidando la bufera.
Fellini scommette su Sutherland per rendere maestosamente il lato patetico di Casanova, il lato disperato (il celebre finale del ballo con la bambola meccanica è di una malinconia invernale quasi insostenibile). Ma è piuttosto nell’architettura narrativa che riesce a rendere la tensione pre-orgasmica, a farne proprio la sostanza del film: il rinvio, l’estenuazione del piacere prima della sua acme, il tentativo di dilatare all’infinito quel prima – in fisiologia, plateau– al punto da farne una condizione permanente dell’esistere. Il godimento è misto così a un dolore sottile, a un’ansia, che il film non si limita a tematizzare, ma rende miracolosamente visibile.
Resta affascinante e misteriosa, a ogni ulteriore visione, quest’opera carnascialesca senza allegria, notturna come il cielo delle prime sequenze, da cui gli dei si sono assentati. «’Mbriacone» e «magnone» dicono le voci terrestri, e tali restano anche nel loro votarsi alla dea Luna: che comunque non ascende, non può ascendere, e precipita in acqua.
A metà strada fra il Satyricon e La città delle donne, del primo assorbe gemiti di piaceri gastrici e genitali, contorsioni a lume di candela, trapiantando il tutto dal sottosuolo del I secolo alla cartapesta scenografica della Venezia settecentesca; del secondo esclude lo spirito sbruffone e un po’ misogino. Così, Casanova è un film più ambiguo – lubrico, appunto – e più disperato. Più funereo: «Che uomo strano che sei, Giacomo, non puoi parlare d’amore senza immagini funebri?» domanda la marchesa a Casanova, domanda Fellini a sé stesso. E, naturalmente, non può che evocare «la più dolce delle morti».
da Tutto Fellini, a cura di Enrico Giacovelli, New Books
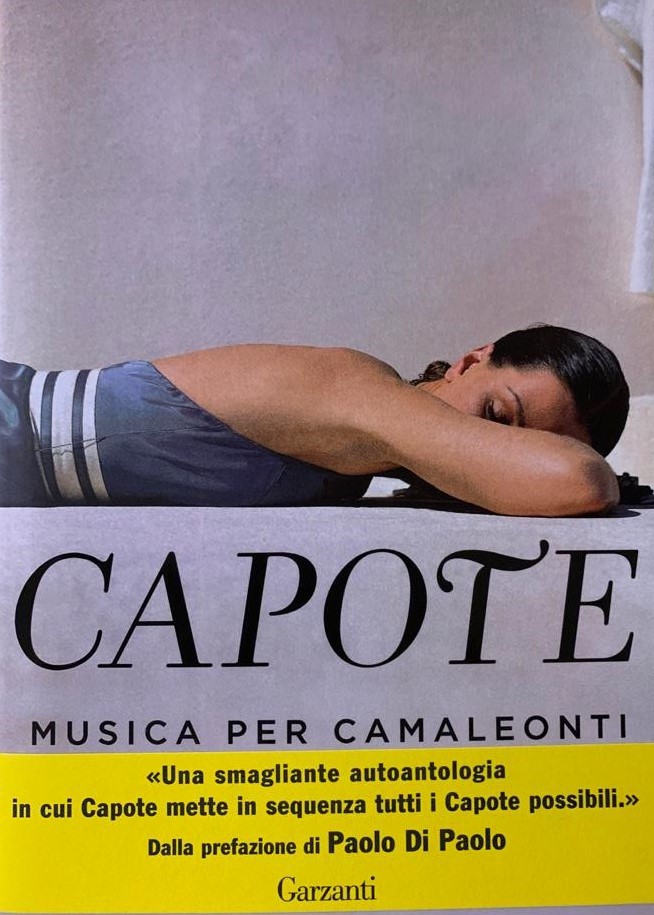
Le parentesi
La differenza tra un ottimo stile e la vera arte è sottile ma feroce.
T.C., Musica per camaleonti
Gli scrittori, di solito, sanno fare bene due o tre cose. Affinare una tecnica, avere un mestiere significa, in fondo, sfruttare al meglio le proprie qualità evitando di mostrare troppo i propri limiti. Ciò che fa la differenza, intanto, è riconoscerli. È raro, comunque, che si abbia una tastiera stilistica illimitata: l’autore dotato nella costruzione delle trame spesso è debole altrove; il grande romanziere non sempre riesce a scrivere un buon pezzo giornalistico; l’abile, poetico descrittore inciampa nella credibilità dei dialoghi.
Un libro come questo, un libro come Musica per camaleonti, certifica l’eccezione: se fosse il frutto dell’allievo di un corso di scrittura, se fosse la raccolta dei suoi “compiti”, mostrerebbe una duttilità impressionante e tutt’altro che comune. Ma in verità l’allievo e il maestro qui sono la stessa persona: Truman Capote impara da Truman Capote. Truman Capote è messo alla prova da Truman Capote.
«Ho cominciato a scrivere a otto anni: di punto in bianco, senza un esempio ispiratore», annuncia nella prefazione lo stesso scrittore, con il tono apodittico e un po’ civettuolo che spesso è il suo timbro. D’altra parte, è inconfutabile il talento precoce e selvaggio di questo ragazzino autodidatta nato a New Orleans e cresciuto in Alabama senza genitori. Però un conto è il talento, anche quando esuberante; un conto è esordire con un romanzo delicato e struggente come Altre voci, altre stanze e essere, quasi vent’anni dopo, l’autore di A sangue freddo. Scrivere una storia lieve, quasi frivola e indimenticabile come Colazione da Tiffany e imbarcarsi nell’impresa acida, cupa e autodistruttiva di Preghiere esaudite.
Nelle pagine di Musica per camaleonti – a tutti gli effetti una smagliante auto-antologia – Capote mette in sequenza tutti i Capote possibili, i frutti del suo lungo «noviziato all’altare della tecnica, del mestiere», il corpo a corpo con «le diaboliche complessità dei paragrafi, della punteggiatura, del dialogo». Si rappresenta nei panni scomodi e tormentati del condannato al genio – «Quando Dio ti concede un dono, ti consegna anche una frusta» – ma al lettore resta invece la sensazione di una sconcertante naturalezza.
Quando enumera, sempre in un passaggio della prefazione, i generi di scrittura sperimentati nel corso degli anni – racconti, saggi e ritratti, lavori teatrali, copioni cinematografici, reportage – sta anche offrendo una sorta di indice di questo volume. Di più: segnala le forme, quindi gli ingredienti, che riesce a introdurre più o meno in ogni testo – facendo diventare, mettiamo, il bellissimo ritratto di Marilyn Monroe un racconto e allo stesso tempo un saggio, un’opera teatrale, un copione cinematografico, un reportage. «Uno scrittore» sostiene Capote, «dovrebbe avere tutti i suoi colori, tutte le sue capacità a disposizione sulla medesima tavolozza per poterli mescolare (e nei casi opportuni applicarli simultaneamente)». Qui, fingendo di provare a farlo, lui ci riesce.
L’attacco, con la scena del funerale di Constance Collier, una vecchia diva diventata maestra di recitazione, è da reportage, così come alcune immagini di Manhattan, della Bowery, «i minuscoli banchi di pegno e sedi per donatori di sangue e dormitori con cucce da cinquanta centesimi e alberghetti miseri con letti da un dollaro e bar per bianchi, bar per neri, dappertutto barboni…». Il dialogo con Marilyn è un’intervista e insieme una pièce teatrale, con tanto di didascalie: «Marilyn (riparandosi il viso con la borsetta)…». E c’è il cinema, quando Capote definisce con esattezza l’inquadratura: «la vista di un traghetto ormeggiato, il profilo di Brooklyn al di là dell’acqua, i gabbiani che volteggiavano e danzavano bianchi contro un orizzonte marino striato da sottili nubi fioccose fragili come trina…». Lo spirito complessivo del pezzo è quello di chi prova a forzare i limiti del giornalismo, fino a farlo diventare un genere poetico (il «giornalismo come forma di arte in sé»). Capote fa precipitare sulla pagina l’inconsistenza delle conversazioni quotidiane, fa brillare la loro banalità, rende ritmica l’esitazione, l’incertezza. Ricostruisce drammaturgicamente la situazione, con estrema – apparente – fedeltà, e in verità reinventandola maestosamente.
I segni più imponenti, in testi come quello su Marilyn, sembrano essere le parentesi: Capote se ne serve come di uno specialissimo “a parte”. Sottolinea un dettaglio, evidenzia un gesto. E solo alla lunga ti accorgi che sta travasando in quello spazio la sua propria voce: è lì il suo commento, la sua interpretazione, il referto del suo pensiero, il voice over che indirizza il lettore/spettatore, che lo spinge verso l’emozione che Capote vuole che provi. Nel finale del racconto dialogato con Marilyn, poco prima di chiudere il cerchio con un colpo da maestro, scrive – fra parentesi:
(La luce andava calando. Lei pareva dissolversi con essa, fondendosi col cielo e le nubi, svanendo ancora oltre. Io volevo alzare la voce superando le strida dei gabbiani e richiamarla: Marilyn! Marilyn, perché doveva andare tutto come è andato? Perché la vita dev’essere un tale schifo?)
Né Marilyn può rispondere, né Capote pronuncia davvero quella domanda. «Volevo alzare la voce»: lo fa, ma su carta. Il voice over sale dunque di tono, e le strida dei gabbiani, le nubi, l’attrice fragile su un molo, tutto sembra così intensamente, insopportabilmente esatto. Tanto più rispetto a quella domanda potenziale, bloccata sulle labbra, rimasta senza risposta – posta lì a indicarci il cuore del sentimento che Capote ha di Marilyn, il sentimento che desidera abbia il lettore: «Perché doveva andare tutto come è andato? Perché la vita dev’essere un tale schifo?». Da dove parla Capote? Da dove scrive? Da dopo, e dall’alto. L’ambientazione effettiva è l’aprile del ’55, ma risulta via via dolorosamente evidente che il personaggio e la persona sono già dissolti, svaniti «ancora oltre».
La varietà – in questo libro camaleontico sin dal titolo – è anche contenutistica. C’è il ritratto di una splendida settantenne dai capelli argentei che racconta cose curiose – il suo giardino invaso da gigantesche farfalle notturne, i camaleonti che si affollano ad ascoltare una sonata di Mozart. C’è la storia di una giornata trascorsa in compagnia di una donna delle pulizie; la vicenda di un membro della banda criminale di Charles Manson. C’è la «cronaca vera di un delitto americano», Bare intagliate a mano, che funziona quasi come uno spin-off di A sangue freddo, più sadico e forse anche più inquietante. Anche in questo caso, reportage, teatro, cinema. Le parentesi, naturalmente. E inattesi rimandi alla propria storia, lampi di vissuto: «Era estate, e io avevo cinque anni, stavo presso certi parenti in una cittadina dell’Alabama…».
Gli affondi autobiografici, che altrove danno corpo a racconti carichi di tenerezza e di dolore (penso per esempio all’ultimo in assoluto, Un Natale, scritto poco prima di morire), qui diventano parte di un sistema congegnato in modo che ogni soggetto narrativo, rivelando qualcosa di sé, riveli qualcosa di chi ne sta scrivendo. Così, nel racconto “Barbagli”, la signora Ferguson cui Capote intende confidare un suo segreto, rivelandosi, rivela gli affanni del giovane Truman. Il quale le si confida, mentre il cuore fa scherzi strani. «Era come se nelle ultime ore avessi corso per cento chilometri e avessi vissuto mille anni». Truman confessa alla signora Ferguson, quella donna curiosa e un po’ sciocca che pareva avesse poteri magici, che gli piacerebbe fare il ballerino di tip tap, scappare via e andare a Hollywood per tentare la strada del cinema. Ma non solo questo:
«Non voglio essere un ragazzo. Voglio essere una bambina.»
Iniziò con un suono strano, un gorgoglio strozzato che dal fondo della sua gola risalì in una risata. Le sue labbra sottili si tesero e si allargarono; uno scroscio ubriaco di risa le fiottò dalla bocca come vomito, quasi investendomi… una risata che aveva l’odore acre del vomito.
«La prego, la prego. Signora Ferguson, lei non capisce. Io sono molto preoccupato. Continuamente. C’è qualcosa che non va. Per favore. Cerchi di capire.
Il finale è spiazzante, ancora volta carico di tenerezza e di dolore. Mentre rivela ancora qualcosa della signora Ferguson, rivela di nuovo qualcosa di Capote.
Nell’ultimo testo, il più giocoso e forse il più disperato, l’autore dialoga con sé stesso, T.C. parla con T.C. Lo interroga, lo provoca, lo sfida. Parla di masturbazione, di insonnia, di forti avversioni, di simpatie (anche per i trapassati: Proust, Sarah Bernhardt, Oscar Wilde, Agatha Christie), di paure («rospi veri in giardini immaginari», tradimenti, abbandoni). Così qui è davvero Truman Capote a svelare Capote, a civettare fra sé e sé, a prendersi in giro e molto sul serio allo stesso tempo («Sono un alcolizzato. Sono un tossicomane. Sono un omosessuale. Sono un genio»), a confessare il desiderio di svegliarsi una mattina «e sentirmi finalmente una persona adulta, svuotata di risentimenti», a parlare di Dio, di come viene sciupata la fede, della solitudine più abissale. Ma la parte più bella è il lungo inciso, una parentesi senza parentesi, sul primo incontro con una scrittrice già molto affermata.
New York Society Library, Settantanovesima, 1942. Una giornata di neve, una signora con gli occhi azzurri che dice al ragazzo sconosciuto: «Crede che una tazza di cioccolata gioverebbe?». I due cominciano a parlare. Lui le racconta di sé – il sogno di fare lo scrittore. Lei gli chiede quali scrittori americani ama leggere. Lui cita anche Willa Cather. E non sa di avere davanti Willa Cather.
Come tutti gli autentici conversatori, era un’ottima ascoltatrice, e quando era il suo turno di parlare non era mai verbosa ma puntuale e stringata. Una volta mi disse che ero troppo sensibile alle critiche. In realtà lei era più sensibile di me agli appunti critici; ogni accenno negativo alla sua opera provocava un calo di umore. Quando glielo feci notare lei rispose: «Sì, ma non è forse vero che ricerchiamo continuamente i nostri difetti negli altri e glieli rimproveriamo? Io sono un essere umano. Ho i piedi d’argilla. Senz’altro.
(Prefazione alla nuova edizione Garzanti)

Svegliarsi negli anni Venti
“Svegliarsi negli anni Venti” l’ho immaginato come un corridoio spazio-temporale tra due secoli – futuristi, futurocrati, feste dell’Età del jazz e aperitivi negati, Thomas Mann e la rabbia sociale, Kafka e gli spettri di WhatsApp.
C’è una scena di un romanzo di Julian Barnes, “Il senso di una fine”, che amo molto. Un ragazzo è alla cattedra per essere interrogato.
“Allora, sentiamo Marshall. Come descriverebbe il regno di Enrico VIII?”.
Pausa, silenzio. Sollievo dei compagni di classe. Marshall tace ancora. Poi, finalmente: “Un tempo inquieto, signore”.
L’insegnante non è soddisfatto: “Le dispiacerebbe approfondire il concetto?”.
Lui, dopo avere annuito, ci pensa ancora un po’ e tira fuori la sua risposta definitiva: “Un tempo molto inquieto”.
Qui leggo un capitolo del libro a cui sono molto legato. Racconta di Monet; di quando, cento anni fa, pensò di abbandonare la pittura – e del mondo intorno.

Wet Market. La fiera della (nostra) sopravvivenza
Un mercato coperto nel cuore di una grande città. Ogni padiglione è un’epoca diversa. In questo ideale campo comune, tra superstizioni, ripensamenti e deliri di onnipotenza, gli uomini e le donne di scienza – i medici, i pionieri, i “cacciatori di microbi” (da Montagu a Jenner, da Pasteur a Koch, dal misconosciuto Tiberio a Blackwell) – incrociano i loro passi e si confondono con la massa, dando vita al grande affresco della ricerca del vaccino più sicuro, degli antibiotici più efficaci. “Wet Market” intreccia storie che raccontano trionfi e sconfitte della scienza, e in fondo del genere umano. Una fiera della (nostra) fragile sopravvivenza che ci dà la misura delle speranze e delle paure con cui quotidianamente, e a maggior ragione oggi, siamo tenuti a fare i conti.
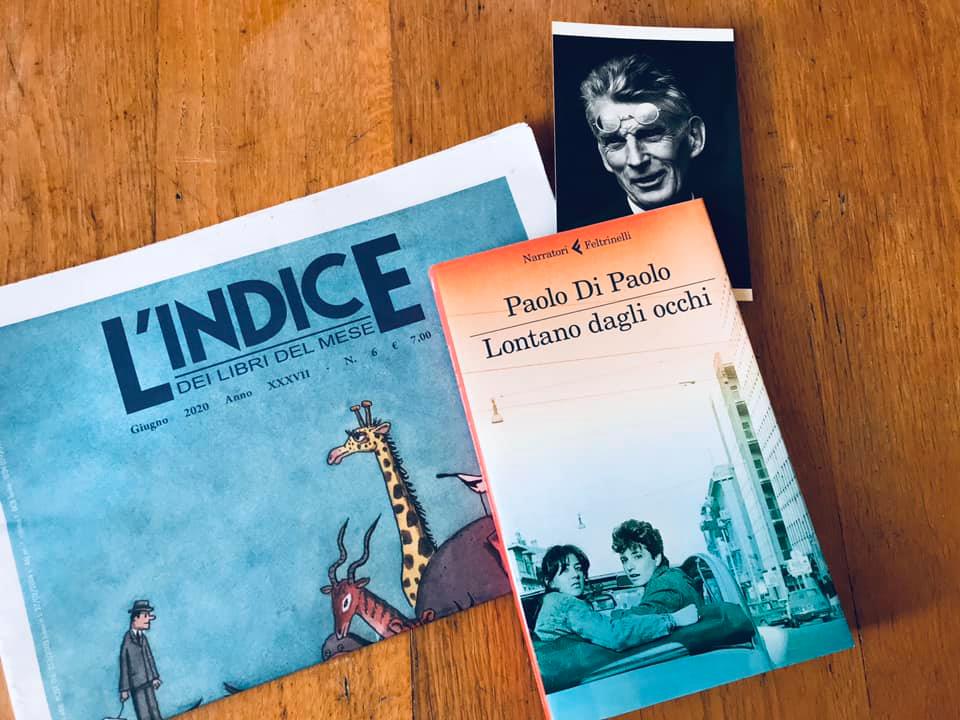
Lontano dagli occhi
Spesso, mentre si scrive un romanzo, viene voglia di nascondere fra le pagine qualcosa, sperando che venga scoperta:
L’ultimo romanzo di Paolo Di Paolo potrebbe provocatoriamente essere considerato un romanzo di formazione, ma di formazione nell’utero, nel quale il protagonista scopre chi è riguardando se stesso, molto indietro nel suo passato, ovvero valicando la soglia prenatale e avventurandosi nel mito delle origini nebulose e immaginarie, presupposte nella nascita di ognuno […]
Ma il romanzo è tutto proiettato sull’essere figli, perché come dice l’esergo riprendendo dalla mise en abime finale del libro “nulla ci accomuna come l’essere figli”, e bisognerebbe aggiungere alla fine della lettura “figli del caso”, “figli scangiati” avrebbe detto Pirandello nell’omonima favola, figli senza padri e senza madri se non quelli scelti o immaginati, edipicamente sognati a occhi chiusi o a occhi aperti come i personaggi dell’ultimo testo teatrale di Beckett, Cosa dove (1983), pur evocato in Lontano dagli occhi, forse come la chiave o una delle chiavi interpretative più sotterranee dell’intera vicissitudine […]
Giovanni Greco – L’indice dei libri del Mese, sul mio “Lontano dagli occhi” – Premio Viareggio Rèpaci 2020
About a book, Repubblica, con Giulia Santerini

Moravia questo sconosciuto
Se dici Alberto Moravia, dici Gli indifferenti, il sesso, La noia. Tutt’al più, il film di Bertolucci, Il conformista. Ah, e quelli di De Sica e di Godard. E poi? L’avete mai letto Moravia? La fama, per paradosso, è il principale nemico di alcuni scrittori. Ne condiziona la lettura e la rilettura, quasi al punto da renderla superflua. Inscatola, etichetta, neutralizza. Ho in mente almeno una ventina di conoscenti fra i trenta e i cinquant’anni, diciamo pure letterati, che al nome di Moravia farebbero un’espressione da saputelli tediati. In verità, non ne sanno niente. Si fidano di un sentito dire, di un lunghissimo, avvolgente e ormai arido sentito dire. Che non è passato nemmeno dai banchi di scuola, dove Moravia non è mai stato davvero accolto.
Giocando d’anticipo, il trentennale della morte, il prossimo 26 settembre, può essere l’occasione giusta per ricominciare finalmente il racconto da una prospettiva nuova. Nel 2000, a dieci anni dalla scomparsa, la sensazione dominante fu che l’autore degli Indifferenti fosse stato già dimenticato. Sandro Veronesi, rispondendo a una provocazione di Antonio Debenedetti sul “Corriere della Sera”, scrisse che ad avere dimenticato subito Moravia, più che i suoi colleghi giovani e meno giovani, erano stati «medici, consiglieri comunali, professori, ingegneri, dirigenti di banca, commercialisti, avvocati, proprietari di negozi e di ristoranti: gli italiani, insomma, borghesi e benestanti che non hanno fatto molta fatica ad assorbire, attraverso i decenni, le travolgenti trasformazioni della società occidentale, ma che continuano a non avere la minima idea di quanto proprio per loro sarebbe importante ricordarsi di Moravia».
Nel settembre 1990 al governo c’era Andreotti; presidente della Repubblica era Cossiga. Tempo fa, ho passato mezza giornata in un’emeroteca per recuperare i quotidiani usciti all’indomani della morte di Moravia, e sono rimasto impressionato. La scomparsa di Moravia era la notizia principale, con titoli a cinque, sei colonne. Mai più visto tanto spazio per uno scrittore, se non da ultimo per Camilleri. “Repubblica” apriva con un cubitale «Senza Moravia», una vignetta malinconica di Forattini, un editoriale di Umberto Eco. Enzo Golino raccontò di averlo visto a cena l’ultima sera: «Era arrivato da solo, guidando quella sua macchina un po’ terrorizzante, con i pedali invertiti per consentire alla sua gamba offesa un controllo sicuro… A tavola era stato brillantissimo in quella sua conversazione così particolare, a scatti, incisiva. Dall’Iraq a Gorbaciov, dal ruolo degli Stati Uniti nella crisi del Golfo all’Italia mangiata dalla mafia: per tutto aveva una sua idea, magari discutibile ma lucida, essenziale, precisa. E la esprimeva con quel linguaggio squadrato, brusco, che ti faceva sentire attraversato dal laser della sua intelligenza».
Moravia opinionista. Anche questo, nella ricezione postuma, ha nuociuto? In un divertente passaggio televisivo in bianco e nero accanto al suo amico di vecchia data Montanelli, Moravia si fa spiare al telefono con giornalisti che gli chiedono di tutto. Che cosa pensa dell’ipocrisia? Che cosa pensa del maquillage della donna? E lui risponde, non si nega. Così confermava e cristallizzava – anche dalle pagine di questo giornale – la fisionomia dell’intellettuale novecentesco engagé, il firmatario di appelli. Ma con una curiosità, una passione, un desiderio di capire inesausti. Per “L’Espresso” del 27 novembre 1983 – uno fra centinaia di esempi – andò a intervistare un consigliere di Andropov, l’allora segretario del partito comunista sovietico, e gli chiese: «Signor Arbatov, lei crede che nel prossimo futuro verrà varcata la soglia atomica con l’uso, in una guerra minore, di armi atomiche tattiche di piccolo calibro?». «Signor Moravia – risponde Arbatov – io non credo che ci possa essere un conflitto nucleare limitato con uso di armi nucleari tattiche di piccolo calibro in quanto, a mio avviso, questo conflitto limitato sarebbe soltanto l’inizio di un conflitto più vasto».
Vedeva all’orizzonte «una realtà insidiosa e per giunta incontrollabile se non con strumenti molto sofisticati, lenti a pronunziarsi e, alla fine, terribilmente ambigui nelle loro risposte». Eccola! E l’inverno nucleare era la sua grande angoscia negli ultimi anni. Se ne occupa anche nel libro postumo che raccoglie gli articoli scritti da parlamentare a Strasburgo («con il proposito pubblicamente dichiarato di servirmi di questa elezione per fare la propaganda al disarmo nucleare»), Diario europeo. E se ricominciassimo a leggere Moravia da qui? C’è uno scrittore quasi ottantenne che continua a interrogare la realtà con la pretesa che essa si riveli, a forza di domande. Lui ne pone innumerevoli: nette, di una intelligenza smagliante perché capace anche di ingenuità. «Questa borghesia così civile e così sfumata farà l’Europa?». «L’Europa è un continente nervoso, scontento, problematico, ed è notevole che lo è non soltanto nelle parti occidentali ma anche in quelle orientali, dal Portogallo alla Polonia. Perché questo?».
«Perché questo?» è una domanda che ripete di continuo, di fronte a un libro che ha appena letto, a un discorso politico, di fronte al “comunicatore” Reagan o alle clip di Videomusic, «le cui immagini in qualche modo si accordano molto bene con l’idea della fine del mondo ballata, cantata e suonata». C’è una pagina straordinaria sulla storia europea come «ricca e preziosa stoffa double-face. Da una parte, ci sono i particolarismi feudali, monarchici, nazionali; dall’altra, l’universalismo culturale europeo». E poi, per tradurre in un’immagine «la cultura europea ai suoi buoni momenti», evoca un temporale africano nella stagione delle piogge, drammatico e universale, che disseta imparzialmente la terra, noncurante di frontiere, proprietà, limiti.
Di spirito europeo, d’altra parte, il giovanissimo Moravia si era nutrito per via di letture precoci («Spesso penso a Shakespeare, a Dostoevskij, questi grandi creatori, questi grandi padri e allora mi sento il diavolo in corpo – come si farà a ripercorrere tali strade?», scriveva in una lettera a vent’anni), ma anche dal vero: frequentando a Londra, nei primi anni Trenta, salotti, circoli, club letterari con protagonisti come Lytton Strachey e E.M. Forster. La cultura di Moravia – nato Pincherle, per metà ebreo, cugino dei fratelli Rosselli – è tutto fuorché provinciale; e nel Diario europeo, come in un distillato ultimo, si coglie la rara e impressionante disinvoltura di chi sa passare, come cambiando un paio di occhiali, da Machiavelli e Guicciardini a Balzac e Proust, da Kafka a Borges; di chi sa connettere l’ultimo libro di Elsa Morante, che era stata sua moglie, a Stendhal e a Manzoni in un disegno interpretativo nitido, anzi trasparente.
La trasparenza, d’altra parte, è una delle qualità essenziali della scrittura di Moravia. Che non allude, ma piuttosto chiarisce, semplifica, porta ai minimi termini. Ciò che appare meccanico, monotono, o asciutto al punto da sembrare freddo, asettico, è il risultato di uno sforzo preciso: ridurre l’esistenza alla sua nuda e pura trama. Sorprendere in azione il meccanismo semplice e sconcertante che la governa. La tematizzazione “esistenzialista” di molti titoli – indifferenza, ambizione, disubbidienza, conformismo, noia, disprezzo – risponde all’esigenza di indagare, per mezzo di una storia, un sentimento, una malattia morale, di trasformare le domande («Perché questo?») in personaggi. Se è vero che «è borghese chi possiede un segreto», Moravia sfida ossessivamente quel segreto, ovvero l’intimo, il nascosto, e fa tutto quello che può per disvelarlo, per portarlo alla luce.
I romanzi e i racconti degli ultimi anni, giudicati brutti soprattutto da chi non li ha letti, sono senza dubbio ripetitivi, ma – ischeletriti come favole, favole erotiche – inchiodano, con «un certo senso morale, didattico», una verità spesso sgradevole e tuttavia inoppugnabile. La contemplano, la scrutano: senza difese. Perché questo significa diventare adulti – crescere, esaminare gli stessi temi da angolature diverse, svegliarsi e sapere («Ormai mi ero svegliato e sapevo», dice il protagonista dell’ultimo romanzo, Il viaggio a Roma), accettare «la monotonia e la necessità di certi atti, un’ossessiva condanna a ripeterli». La realtà come è. Non c’è niente di confortante, Moravia si rifiuta di esserlo, intende perseguire l’idea di “scrittore estremo” che teorizza in un testo del 1946: non scamiciato, rivoluzionario, ma «inflessibilmente e totalmente sincero», che non accetta di farsi tirare la manica dal conformismo, che dice «la verità, tutta la verità e nient’altro che la verità». Nel 1952 i libri di Moravia saranno messi all’indice dal Sant’Uffizio. E il salotto buono a cui, nei cliché, tanti lo riconducono era nei fatti costantemente provocato dalle storie che scriveva. Nelle «ampie case col parquet per terra, le terrazze aperte e soleggiate, gli ascensori scricchiolanti, i portoni blindati e le foto di famiglia nelle cornici d’argento», i libri di Moravia erano in ordine sugli scaffali. Apparentemente inoffensivi, in realtà implacabili nel fare i conti con la falsa coscienza, con le ipocrisie, o anche solo con i desideri segreti di una borghesia «paurosa, prudente, gretta», con il nostro essere «eredi irriducibilmente individualisti ed anarchici di un impero livellatore», con gli eterni falsi scandali di una società «piena di violenza, di trame tenebrose, di abusi del potere, di ricchezze mal guadagnate», dove «un’aria di nascosta normalità sostituisce l’atmosfera di pesante anormalità» in cui viviamo.
Proprio su questo giornale, nel febbraio del 1968, diceva che la funzione dell’artista «è, in certo modo, di essere antisociale». Il non conforme, il non conformista. Diffidate di chi liquida in blocco la produzione dell’ultimo Moravia: c’è il nostro Houellebecq prima di Houellebecq. Celebrato, vezzeggiato e forse neutralizzato come il grande vecchio della letteratura, con i maglioni sgargianti, le cravatte, la vita mondana, Moravia si divertiva ancora – con quella prosa secca, brusca, antisentimentale, perfino inestetica, ma da romanziere puro come pochi altri in Italia – a raccontare storie girando intorno all’indicibile e all’inconfessabile. E a far scivolare giù le maschere della nostra eterna mascherata, a chiamare per nome le nostre fantasie, i traumi, i tabù, le ossessioni, gli inganni familiari, le nostre vite parallele, le voglie, le debolezze. Tutti i nostri desideri. La nostra fatica di crescere.
L’Espresso, 6 settembre 2020

Il romanzo globale della quarantena
Ady, otto anni, di San Francisco, dopo avere letto il Diario di Anne Frank, decide che vuole scrivere anche lei. L’esperienza che sta vivendo è molto diversa, ma quando scopre che le lezioni di clarinetto dovrà farle online, si spaventa. «Cara Ela – scrive alla sua amica immaginaria – la contea di Santa Cruz è in quarantena. Ho davvero paura! Lo sapevi che le cose si stanno mettendo molto male?». La pagina del diario di Ady è davanti ai miei occhi, è già pubblica. È un pezzo di questo romanzo.
Rachel, di Londra, racconta che la sua sarebbe stata una primavera difficile «anche senza coronavirus». L’anziana madre operata all’anca, il padre che smarrisce uno dei cani durante una passeggiata. Poi arrivano la quarantena e la distanza obbligata. Incontrandosi su Zoom, la sera, si finisce per piangere dall’inizio alla fine. […]
Scrive Ady e scrive Rachel, scrive William e scrive l’avvocato italiano ottantenne ricoverato in una casa di riposo: «Sai Michelina, la barba me la tagliavano solo quando sapevano che stavate arrivando…». È l’autobiografia della specie umana alla prova del ventunesimo secolo: un volume invisibile fatto di miliardi di pagine, un gigantesco romanzo corale. Forse nessun evento storico, dalla peste del Trecento alle ultime guerre mondiali, può vantare una simile quantità di testimonianze. Degli oltre quattro miliardi di umani che hanno vissuto, quasi in contemporanea, la stessa esperienza, una larga parte non si è limitata a parlare di ciò che stava accadendo. L’ha scritto. Ha potuto scriverlo. Lo sta scrivendo. Siamo allo stesso tempo i lettori, gli autori e i personaggi. […]
Repubblica, 30 maggio 2020

Lo stupore di un’ora sul palco con Franca Valeri
La prima, primissima cosa compiuta che ho scritto dopo i temi di scuola è stato un testo per il teatro. Era l’estate dei miei diciott’anni. Si trattò, per una serie di circostanze fortunate e imprevedibili di cui sarebbe lungo raccontare, di scegliere una serie di testi letterari sull’Abruzzo, e di cercare un filo drammaturgico che li tenesse insieme. Tutto pensavo fuorché di ritrovarmi su un palcoscenico a fare, per una sera, anche l’attore, o quantomeno il dicitore.
E accanto a me, sullo stesso palco, c’era Franca Valeri.
Sono quelle cose che alla lunga ci sembrano talmente irreali da mettere quasi in dubbio che ci siano capitate davvero. Ma comunque: era agosto, un palco all’aperto, in montagna, faceva freddo e indossavo una camicia bianca. Tremavo, forse soprattutto per l’emozione. L’ultimo testo che lei lesse era di Natalia Ginzburg, lo conoscono in pochi, un piccolo capolavoro di intelligenza e di dignità, si chiama “Inverno in Abruzzo”. Franca Valeri lo rese ancor più acuto e divertente con le sue pause, i suoi accenti. Il pubblico rideva! E vi assicuro che, leggendo, semmai si sorride, non si ride.
Poi arrivò al finale, che è un finale molto triste, parla della prigionia di Leone, delle torture nel carcere di Regina Coeli. La Ginzburg scrive: “Davanti all’orrore della sua morte solitaria, davanti alle angosciose alternative che precedettero la sua morte, io mi chiedo se questo è accaduto a noi, a noi che compravamo gli aranci da Girò e andavamo a passeggio nella neve. Allora io avevo fede in un avvenire facile e lieto, ricco di desideri appagati, di esperienze e di comuni imprese. Ma era quello il tempo migliore della mia vita e solo adesso che m’è sfuggito per sempre solo adesso lo so”.
E io ricordo come fosse ora il tono della voce. Come mutò improvvisamente, come rallentò, come si spezzò. Quando penso a ciò che non dimenticherò mai, penso anche a quella sera, alla commozione che una gigantesca attrice produsse in quel pubblico che un istante prima era riuscita a far ridere di cuore.
E l’applauso.
E il privilegio immeritato e stupefacente di stare un’ora sullo stesso palco con Franca Valeri.

Dietro le quinte. Umberto Orsini, Sold out
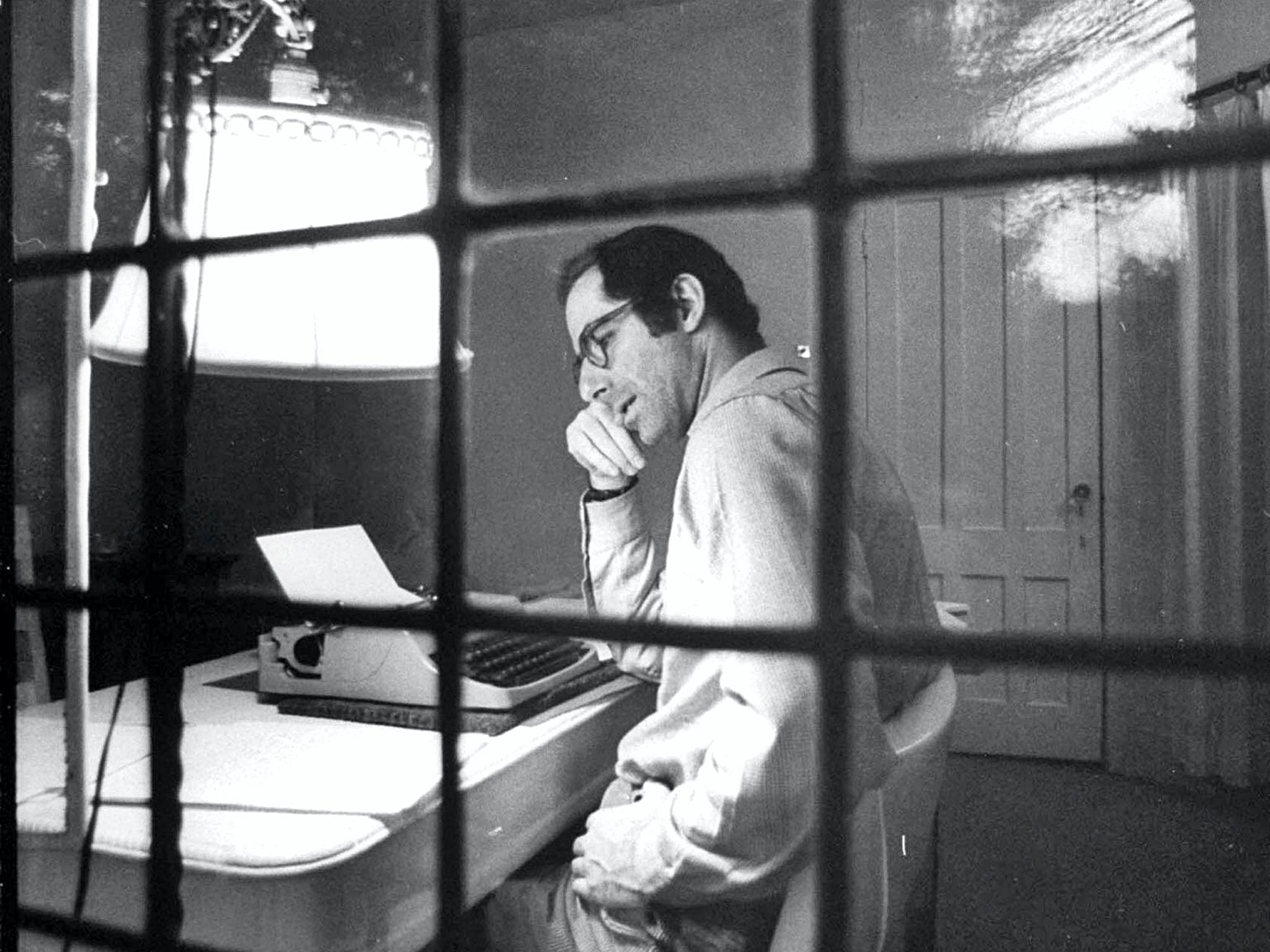
“Insensato, contingente, incongruo e tragico”. Philip Roth, Nemesi
Un gioco che viene anche troppo facile, con la grande letteratura, è quello di cercare profezie e conferme. È quasi impossibile non trovare un’intuizione, una proiezione metaforica, una certificazione o un presagio di ciò che accade e accadrà agli umani. Così, era naturale che ci venissero in soccorso, nei giorni della pandemia, Lucrezio o Boccaccio, Camus e Manzoni. Anche Saramago, risalito nella magra, contratta classifica dei bestseller digitali: il suo Cecità è stato letto o riletto come la stilizzazione di un improvviso e angosciante contagio. Ma c’è un romanzo che poco o per niente è stato citato, che non contiene visioni fantascientifiche né allegorie. È di una asciuttezza disarmante. Un capolavoro trascurato, per una ragione legata alla pigrizia intellettuale. Quando si attribuisce una impegnativa quanto retorica etichetta – «il più grande scrittore americano vivente» – si finisce in qualche modo per neutralizzare chi la riceve.
Così, Philip Roth (1933-2018) è stato a lungo il più grande scrittore americano vivente; ma molti si erano fermati a Pastorale americana (1997). Insistendo su considerazioni trite, sia in positivo che in negativo: racconta il sesso, la vecchiaia, la morte, è misogino, è il Proust della prostata. Ma gli ultimi due romanzi pubblicati prima dell’addio – rigorosissimo e mai smentito – alla scrittura sono bellissimi. Se in L’umiliazione scrive, giocando ancora una volta con un alter ego, «aveva perso la sua magia», in Nemesi la ritrova. Ecco, Nemesi! Mi impressionò alla prima lettura – il libro usciva dieci anni fa esatti – che tale forza venisse da un autore quasi ottantenne. E mi impressionò che, in barba a una sua boutade da misantropo erotomane («Si rivolga a McEwan se vuole leggere di bambini, a me se vuole leggere di figa»), avesse scritto di bambini. E in modo commovente.
In una torrida estate, l’estate del 1944, si abbatte sulla comunità di Newark l’epidemia. Poliomielite. «I pochi privilegiati sparivano dalla città, mentre noialtri restavamo lì a fare esattamente quello che non avremmo dovuto». Le sirene delle ambulanze rompono il silenzio. Le notizie false, spinte da una superstizione spesso xenofoba, dilagano. Gira la voce che a portare il contagio siano stati gli italiani. I casi cominciano ad aumentare, si moltiplicano. E sono misteriosamente concentrati in un’area: «Guardate Weequahic, dicevano, una delle zone della città più pulite e igieniche, eppure la peggio colpita». Non c’è una spiegazione. Solo numeri, solo «gli spaventosi numeri che certificavano l’avanzata di un’orribile malattia». E solo le sirene in lontananza: «Ormai si sentivano giorno e notte, accendersi e spegnersi». Aumentano i ricoveri, i casi di persone che non riescono a respirare da sole. La comunità resta sospesa: chiudere tutto? Non chiudere? Oscilla, assediata dalla paura.
Un ragazzo, Bucky, l’animatore di un campo giochi, tenta un discorso di buon senso, davanti a un gruppo di genitori in apprensione: «Io non sono un medico. Non sono uno scienziato. Non so perché attacca quelli che attacca. Credo che nessuno lo sappia. Ecco perché tutti cercano di scoprire di chi o di cosa sia la colpa». Qualcuno obietta: «E gli italiani? Devono essere stati gli italiani!». E lui: «Non sono stati gli italiani. Sentite, non dovete lasciarvi divorare dalla paura. L’importante è non contagiare i bambini con il germe della paura. Ne usciremo, credetemi. Faremo ognuno la nostra parte e resteremo calmi e faremo tutto quel che possiamo…».
Quando la parola, invece, la prende un medico, parla così: «Per tutti noi, in quanto medici, è doloroso restare a guardare il diffondersi di questa terrificante malattia senza poter far nulla per fermarla». Quando la parola la prende chi è stato toccato dalla malasorte, chi ha perso qualcuno, parla così: «Perché allora è morto? Dove sta la giustizia? (…) Fai solo la cosa giusta, la cosa giusta e la cosa giusta e la cosa giusta. Mille volte la cosa giusta. Cerchi di essere oculato, di essere ragionevole, di essere premuroso. E poi succede questo? Qual è allora il senso della vita?».
Una grande opera di letteratura può permettersi di far risuonare una domanda così, una domanda imponente e imbarazzante. Roth si dispone a osservare l’epidemia e i suoi effetti devastanti – sanitari, sociali – con un occhio lucido, disincantato. Spietato e pietoso insieme. C’è l’ottusità, la grettezza. C’è la gente spaventata («Sono atterriti, perciò si preoccupano di qualunque cosa»). Ma c’è anche la forza d’animo, lo slancio di chi non vuole arrendersi. La rabbia di fronte all’indecisione di chi amministra: «Quand’è che qualcuno deciderà qualcosa!». C’è il lutto insopportabile e c’è il mondo che, comunque, continua a girare. I desideri altrui che non si spengono: «Che differenza fa per le loro famiglie? Abbracciarsi, baciarsi e ballare come adolescenti malati d’amore ignari di tutto… serve qualcosa a qualcuno?».
Bucky – il ragazzo che non si dà pace di fronte alle vittime, perlopiù bambini, di fronte alla città che chiude tutto e si chiude – vuole trovare una ragione a questa assurda nemesi, a questa condanna senza colpa. Si rivolta contro Dio, non accetta l’idea di perdonare: «Come poteva esserci il perdono – per non parlare degli alleluia – di fronte a una tale folle crudeltà?». Il padre della sua ragazza lo incoraggia; gli dice che ha dimostrato equanimità, competenza, e questo è molto. «Bucky, ora sei scosso da quel che sta succedendo, ma anche agli uomini forti viene la tremarella. Devi capire che anche molti di noi sono scossi, nonostante siamo più vecchi e più ferrati di te in fatto di infermità».
Vuole trovare una necessità a quanto accaduto. Vuole trovare il suo ruolo, il ruolo giusto, anche se sa di non poter fare molto. «Non è questione di fare» conclude. «È questione di esserci!».
Nemesi consola nell’unico modo in cui la letteratura autentica può consolare: non consolando. Costringendo il lettore a guardare alla realtà senza che sia edulcorata, offuscata, attenuata la sua insensatezza. Puoi, come Bucky, piangere di disperazione e di nostalgia – per la tua vita com’era: la luce prodiga di luglio che si stende densa sopra ogni cosa, la polpa di una pesca; una serata trascorsa a ballare con una ragazza I’ll be seeing you con la voce di Billie Holiday. Puoi sentirti impotente. Puoi cercare impetuosamente una ragione a ciò che non ha ragione, cercare una necessità per qualcosa di «insensato, contingente, incongruo e tragico». Devi accettare di non trovarla. Devi accettare quei quattro aggettivi – esatti – che solo un grande scrittore è capace di individuare. Insensato. Contingente. Incongruo. Tragico.

Con Banana Yoshimoto
Il suo primo libro – si chiamava Kitchen – è del 1988. In quasi trent’anni di lavoro, ha dato forma a un mondo che coincide con lei, e dunque porta il suo nome: che convinca o meno, di libro in libro, Banana Yoshimoto l’ha alimentato e tenuto vivo. Quasi sempre ci sono gatti, nonne che muoiono, delfini, e soprattutto questo: persone – così scrive nel nuovo libro – che «si fingono forti ma si portano dentro ogni sorta di segreto». Come manga tristi, i suoi romanzi e racconti sono avvolti dalla stessa luce lattiginosa e sonnolenta; il tempo scorre come in un videogioco rallentato; il confine tra ciò che accade nella testa e ciò che accade fuori sparisce di continuo. Guarire dal dolore è sempre la prima e l’ultima urgenza dei suoi personaggi: richiede viaggi, in avanti o a ritroso, nella geografia e nel calendario dei sentimenti; trasformazioni, scoperte, e talvolta gesti estremi. Ora, con Another World (Feltrinelli, pp. 128, euro 14, trad. di Gala Maria Follaco), Banana chiude il Ciclo del Regno, la tetralogia di romanzi quasi fantasy intrapresa tre anni fa con Andromeda Heights. Qui, una ragazza cresciuta da due padri vive la propria educazione sentimentale fra il Giappone e un’isola greca. Ma più che la trama, al solito, conta il marchio di fabbrica. La prosa sempre più rarefatta, le sentenze sulla vita, le domande («troverò la pace?»), la solitudine. E un’androgina e adolescente sensualità, che nemmeno l’estate di Mykonos riesce a scaldare davvero. Kataoka Noni vede Kinoshita su una scalinata di pietra, comincia a parlargli, lo trova affine; gli racconta i suoi lutti e il suo rapporto con le piante («sono sempre state come sorelle»). Kino parla a lei di sua moglie, «la sovrana del regno dei gatti», morta in un incidente. Il ritorno in Giappone, al «suono dell’acqua in mezzo a cui ero cresciuta», il confronto con l’assenza magica di sua nonna, con una madre capace di essere amica dei giardini e delle creature vegetali, spingono Noni verso l’altro mondo del titolo – un regno di «grazia superiore».
I punti di contatto fra romanzo e romanzo sono moltissimi, e questo non vale solo per la recente quadrilogia. Se guarda all’intera sua opera, che impressione le fa?
«Nella mia carriera ho sempre cercato di trasmettere un messaggio e continuo a farlo. È un messaggio molto semplice: che la vita valga la pena di essere vissuta (niente di più e niente di meno, non la si deve sottovalutare ma neanche dobbiamo prenderci troppo sul serio). La critica si mostra talvolta poco generosa nei confronti dei miei libri, ma io mi sento sempre – e lo sento adesso più che mai – in comunicazione con le vite di una parte dei miei lettori, so che la mia voce arriva fino a loro. E sin dall’inizio ho sempre voluto questo, per me era la cosa più importante: sono felice di esserci riuscita.
È bello sapere che ci sono persone che si immergono nel mondo dei miei romanzi così come ci si immerge nell’acqua di una sorgente termale, e spero sempre che alla fine si sentano meglio, anche solo un poco. È ciò che ho sempre desiderato. E in questi trent’anni penso di esserci riuscita».
«Io non ho ancora capito molto bene come funzionano gli esseri umani» dice la voce narrante del romanzo. E lei?
«Ho l’impressione che tra me e la protagonista di Another World non ci siano grandi differenze: mi sembra di comprendere i cani meglio degli uomini, e in tutta onestà gli uomini mi fanno anche un po’ paura. Shizukuishi, però, ha ricevuto un’educazione molto più particolare della mia, e nel suo carattere ci sono elementi eccentrici che non ritrovo nella mia personalità, perlomeno non fino a quel punto».
La “Disneyland botanica” che appare nel romanzo rende ancora più protagoniste le piante, i giardini, la natura. È anche questo “another world“? E cosa può insegnarci?
«Mi immaginavo un posto diverso dai soliti giardini botanici, qualcosa di più simile ai progetti di Derek Jarman: un luogo che racchiude tanti mondi in miniatura.
La differenza principale tra la natura di un giardino e quella incontaminata, secondo me, è che nel primo caso ci troviamo di fronte al prodotto della maestria di uno o più esseri umani, una maestria che in alcuni casi comprende anche una percentuale di follia».
Si può davvero salvare qualcuno con il proprio modo di essere? Come si conquista quella «grazia superiore» di cui lei parla nel libro?
«Penso che gli esseri umani possano aiutarsi, persino salvarsi a vicenda, ma solo se capiscono che non devono strafare. A mio avviso possiamo e dobbiamo accontentarci di sollevare l’umore di chi ci sta intorno, di aiutare gli altri a star meglio. Io ci provo con i romanzi, che arrivano al cuore di tante persone, e ho intenzione di continuare così».
Il desiderio di un altrove si avverte molto forte in questo romanzo, che inizia su un’isola greca. Lo sente anche lei? Si può fuggire dal presente che non ci piace? E se pensa alla minaccia del disastro ambientale, alle minacce del leader nordcoreano, ai missili che cadono nel Mar del Giappone, al terrorismo internazionale, come reagisce emotivamente?
«Il mondo è e sarà sempre pieno di problemi, l’epoca in cui viviamo ci mette di fronte a enormi trasformazioni, ma penso che vi siano almeno due aspetti fondamentali, due punti da prendere molto sul serio: le produzioni alimentari locali e, più in generale, la capacità delle realtà locali di provvedere al proprio sostentamento, alla gestione del territorio, allo smaltimento dei rifiuti. Nel caso del Giappone, secondo me, il sostegno alle piccole e medie imprese costituisce un aspetto di grande importanza. Se pure esistesse una via di fuga dal mondo, questa non potrebbe mai metterci al riparo da noi stessi. Perciò penso che per ciascuno di noi sia essenziale guardarsi dentro, accettare ciò che si è senza bugie né fragili illusioni».
Tuttolibri – La Stampa, 29 settembre 2019

Come va il mondo senza di noi. Calvino, Palomar
Ho un appunto, da qualche parte, che fissa l’immagine di qualcuno che – in una sera di novembre di trentacinque anni fa (aggiungo il più prevedibile dato ambientale: luce fioca di lampioni, ventaccio, aria umida) – passa davanti a una libreria. E nella vetrina vede esposto un libro nuovo di Italo Calvino. L’immagine mi emoziona, e di sicuro esagero; ma, più che una forma di feticismo intellettuale, c’entra la mia passione per le vite – immaginarie, immaginate. La donna che vede il libro in vetrina, ci pensa su, decide di acquistarlo. Il ragazzo che ne aspettava l’uscita, con quell’ansia propria dell’artista da giovane, del lettore che già si immagina scrittore. Eccetera. In ciascuna di queste ipotesi narrative (che a Calvino, il Calvino che nel ’79 giocava con l’orizzonte della ricezione in Se una notte d’inverno, non sarebbero dispiaciute), c’è un’altra questione che mi sta a cuore. Una specie di domanda impossibile: un libro – quel libro fresco di stampa, appena uscito, che stasera pago alla cassa e ficco in una busta – come entra di preciso nella quotidianità? Come la tocca, come la modifica? Ancora: c’è la possibilità di verificarlo in tempo reale? Giochiamo, à la Calvino, con l’avventura di un lettore di Calvino: il ragazzo (forse aspirante scrittore) saluta il libraio, torna in strada – luce fioca di lampioni, ventaccio, aria umida – e si sente elettrico, la pienezza misteriosa dei vent’anni e delle giornate buone, prende un caffè, inizia a leggere le prime righe già mentre lo sorseggia, «Il mare è appena increspato e piccole onde battono sulla riva sabbiosa», l’immaginazione lo strattona, lo sposta di lì – dal balcone del bar alla riva sabbiosa – per un istante lunghissimo. Paga il caffè, esce di nuovo, pensa alla sua ragazza, ragiona su un esame universitario, aspetta l’autobus, continua a leggere. Quel piccolo libro, in quella giornata, in quel segmento nella linea del tempo della sua vita, di preciso in che modo agisce? Stando ancora a uno schema calviniano: adesso si tratta di lui più il mondo più il libro che ha acquistato e iniziato a leggere. Come funziona quel “più”?
Me lo chiedo, insistendo nell’immaginare il testimone diretto. Il ragazzo allora ventenne che, oggi cinquantacinquenne, che una sera di novembre del 1983 acquistò una copia di Palomar, il nuovo libro di Calvino, praticamente l’ultimo che fece in tempo a vedere pubblicato. Quanto a me, ero appena nato; ed è forse questa insignificante coincidenza che mi spinge a vedere la copia di Palomar – Einaudi, Supercoralli – nella busta del famoso ragazzo come un talismano, un piccolo cuore luminescente. Per me – lungo gli anni che mi separano dalla prima lettura, databile agli inizi del secolo in corso – così è stato. E forse sì – ma me ne accorgo solo adesso – il ragazzo di vent’anni che scopre Palomar in una sera di novembre, non importa di quale anno, sono io; sono io che in una busta di carta mi porto appresso un cuore luminescente e attraverso piazza dei Cinquecento, Roma, la grande spianata fuori dalla Stazione Termini, e nel cielo autunnale passano gli storni, esattamente come descritto in un capitolo di Palomar, «una folla aerea che sembra sempre stia per diradarsi e disperdersi, come granelli d’una polverina in sospensione in un liquido»; e mando un sms a un’amica degli anni di università e le chiedo se ha mai letto Palomar, e che se non l’ha letto deve leggerlo, il capitolo sugli storni subito, e che se non ce l’ha glielo regalo io.
Ora che ho l’età del libro, torno a interrogarlo con le fede perplessa e divertita che si accorda ai “libri delle domande e delle risposte”. Apro a caso, trovo un’orecchia, un segno, un post-it, una sottolineatura. Palomar è un libro statico: si compone di quadri, come Marcovaldo, pubblicato da Calvino vent’anni prima, il ’63, lo stesso anno di un altro alter ego “contemplativo”, l’Amerigo Ormea di La giornata d’uno scrutatore. Politico Amerigo, sociologico Marcovaldo, esistenziale Palomar. E ancora, volendo, in sequenza: la giornata, le stagioni, il tempo intero. Calvino guarda e scrive, o meglio, descrive: si vota – così spiega lui stesso – a un «esercizio letterario caduto in disuso e considerato inutile: la descrizione». Perciò, se dovessi andare per le spicce davanti a una platea impaziente di studenti, con la certezza di non incuriosirli, direi questo, sì: un esercizio di descrizione. Un uomo appena arrivato ai sessant’anni – così Calvino nel 1983 – piglia le parole, gli strumenti di elaborazione della realtà che meglio domina, e le mette alla prova. Non è forse ciò che uno scrittore fa sempre? Sì. Ma qui Calvino rinuncia alle storie, alla narrativa – dopo averne concettualmente esaurito le possibilità in Se una notte d’inverno. Allora scrive un saggio? No. Saggi veri ne ha scritti – alcuni fra i più sorprendenti li raccoglierà nel 1984 in Collezione di sabbia; e sta per lavorare alle proverbiali Lezioni americane. Dopo una ventina e più di titoli, dopo avere scritto un romanzo resistenziale ad altezza bambino, tre drammi morali travestiti da fiaba, dopo avere finto di essere un neorealista, spostandosi poi velocemente verso una sghemba fantascienza filosofica, dopo avere messo il romanzo, per via francese, nella centrifuga della letteratura potenziale e scacchistica, sbarca negli anni Ottanta come un vecchio ragazzo pronto a ricominciare da capo. Qui nasce Palomar: rimodella esperimenti di elzeviro prestati prima al “Corriere della Sera” e poi a “Repubblica”, e viene fuori un non meglio identificato signor Palomar, con il nome di un osservatorio astronomico – e il desiderio di raggiungere, stanare, e svelare, un segreto.
Calvino, dopo quattro decenni di scrittura, mette alla prova le parole. È, a ogni pagina, una sorta di banco di prova per il lessico, per la sintassi: «Il mare è appena increspato e piccole onde battono sulla riva sabbiosa». Che cosa ho detto dicendo questo? Che cosa vedete se dico “onde”? E se invece non voglio dire “onde” ma dico “onda”? Che cosa cambia? «Infine non sono “le onde” che lui intende guardare, ma un’onda singola e basta: volendo evitare le sensazioni vaghe, egli si prefigge per ogni suo atto un oggetto limitato e preciso». Lo sforzo dell’occhio del signor Palomar – e dunque delle parole di Calvino – è di afferrare l’onda, la singola onda: nel suo «crescere, avvicinarsi, cambiare di forma e di colore, avvolgersi su sé stessa, rompersi, svanire, rifluire». Ma si può isolare un’onda da quella che immediatamente la precede e immediatamente la segue? No. E tuttavia il senso dell’intero libro è in questo esperimento perso in partenza. Una partita fra le parole e il reale – ovvero, appunto, un’onda, il seno di una ragazza, un riflesso luminoso, due tartarughe in amore, un prato, la luna di pomeriggio, un negozio di formaggi. Nel capitolo in questione – “Il museo dei formaggi” – si legge in modo trasparente (aggettivo chiave dell’ultimo Calvino) il corpo a corpo di Italo/Palomar con il lessico: se la formaggeria si presenta come «un’enciclopedia a un autodidatta», basta imparare nomi e classificazioni per sapere, per conoscere? «Potrebbe memorizzare tutti i nomi, tentare una classificazione a seconda delle forme – a saponetta, a cilindro, a cupola, a palla –, a seconda della consistenza – secco, burroso, cremoso, venoso, compatto –, a seconda dei materiali estranei coinvolti nella crosta o nella pasta – uva passa, pepe, noci, sesamo, erbe, muffe –, ma questo non l’avvicinerebbe d’un passo alla vera conoscenza, che sta nell’esperienza dei sapori, fatta di memoria e d’immaginazione insieme». Ecco! Memoria e immaginazione insieme: «Dietro ogni formaggio c’è un pascolo d’un diverso verde sotto un diverso cielo: prati incrostati di sale che le maree di Normandia depositano ogni sera…».
Palomar vorrebbe fidarsi delle parole, trova preziosi, fondamentali i nomi delle cose, e così gli aggettivi, così i verbi, le preposizioni e le virgole. Ma c’è qualcosa che, quanto più insiste nella sua scommessa enciclopedica, tanto più gli sfugge di mano, spesso abbattendolo, trasformandolo in un Bartleby potenziale, uno che da un istante all’altro potrebbe mollare la presa, preferire di no, preferire il silenzio. Ciò che oggi mi appare lampante (e perfino commovente) di questo estenuante esercizio di descrizione è che nasce sul crepaccio del fallimento, nella certezza della sconfitta. Capisco che Calvino mette in discussione, senza darlo troppo a vedere, il suo stesso statuto di scrivente/scrittore: ho le parole, sembra dire, sì, ma che altro? Il taciturno Palomar, il balbuziente Calvino, posti di fronte al vastissimo inesauribile materiale di realtà che chiamiamo mondo fanno un passo avanti e dieci indietro. Ma non sono dei rinunciatari: né può essere un caso che l’ultima lezione americana, quella non scritta, intitolata alla consistency, dunque allo spessore, alla consistenza, alla coerenza, avrebbe dovuto prendere le mosse dallo scrivano di Melville. Letto – mi viene da azzardare – come uno che definisce i parametri della sua coerenza, ovvero del suo spessore, in base non solo ai sì che dice, ma pure ai no che sa difendere.
Dove sarebbe andato Calvino, il multiforme Calvino, dopo Palomar? Oltre che le Lezioni americane, stava costruendo una raccolta di scritti autobiografici, con un titolo di lavoro bellissimo nella sua onestà: Passaggi obbligati (la versione parziale, pubblicata postuma, si trova con il titolo La strada di San Giovanni); uno dei testi, risalente al ’71, si intitola Dall’opaco, e chiarisce, una volta per tutte, una posizione: «Dal fondo dell’opaco io scrivo». Dove sarebbe andato Calvino? Lavorava anche a una raccolta di cinque racconti, ciascuno basato su un diverso senso (l’udito, l’olfatto, il gusto). Ma è evidente una inquietudine sempre più profonda verso la scrittura (narrativa, letteraria) come strumento percettivo, e un sempre più netto orrore del “generico”, dell’impreciso. Non basta, a attenuarlo, né l’accumulo, la vertigine della lista, dell’enumerazione, né la precisione classificatoria e nomenclatoria, che pure ha un rilievo inaggirabile. Allo zoo di Barcellona, osservando un gorilla albino giocare con un vecchio copertone, il signor Palomar, fra sé se sé, conclude: «Tutti rigiriamo fra le mani un vecchio copertone mediante il quale vorremmo raggiungere il senso ultimo a cui le parole non giungono».
Un vecchio copertone! La scrittura, se non addirittura il linguaggio, come un vecchio copertone. Nelle ultime pagine, il filo del ragionamento filosofico si ingarbuglia, si spezza, si ricompone in una serie di assurdi logici: il mondo senza i nostri occhi, sguardo che viene dal di fuori/sguardo che viene da dentro, l’Io inteso come centro che ha centro in ogni punto, eccetera. Ma che cosa sta inseguendo? Una giusta e perciò forse impossibile distanza? Un «sublime distacco»? O perfino «il sollievo d’essere morto»? L’ultima frase del libro, dopo un ulteriore paradosso («decide che si metterà a scrivere ogni istante della sua vita»), suona letteralmente definitiva: «In quel momento muore». A Palomar tocca nell’ultima pagina del libro, a Calvino di lì a un paio d’anni. Resta il vecchio copertone, sì; e resta un involontario modello di parlante-scrivente-umano – sanamente perplesso, quando non scettico, sul potere dello strumento che connota la specie a cui appartiene. Capitoletto aureo è, tra i conclusivi, quello dedicato al «mordersi la lingua». Palomar – ci informa Calvino – ha preso l’abitudine di mordersi la lingua tre volte prima di fare qualunque affermazione. «Buone occasioni per tacere non mancano mai». Silenzio vile? No. «In tempi di generale silenzio, il conformarsi al tacere dei più è certo colpevole». Ma «in tempi in cui tutti dicono troppo, l’importante non è tanto dire la cosa giusta, che comunque si perderebbe nell’inondazione, quanto il dirla partendo da premesse e implicando conseguenze che diano alla cosa detta il massimo valore». La scelta obbligata è perciò necessariamente quella fra il parlare in continuazione e il non parlare mai? Un silenzio «può servire a escludere certe parole oppure a tenerle in serbo perché possano essere usate in un’occasione migliore». E allora? «Il fatto è che lui più che affermare una sua verità vorrebbe fare delle domande, e capisce che nessuno ha voglia di uscire dai binari del proprio discorso per rispondere a domande che, venendo da un altro discorso, obbligherebbero a ripensare le stesse cose con altre parole, e magari a trovarsi in territori sconosciuti, lontani dai percorsi sicuri».
Ci arriva un segnale dallo spazio-tempo, nel cuore luminescente di Palomar c’è un ciao che dal 1983 raggiunge gli amici social di sette lustri dopo. Eccoci qua – scimmie che si aggrappano a un vecchio copertone, usato da «supporto tangibile per un farneticante discorso», una folla di gorilla dai modi spicci che hanno fretta, si fanno largo a gomitate, «senza guardarsi in faccia, tra alte mura spigolose e scrostate». E qualche signor Palomar, che vorrebbe essere amico dell’universo, si morde la lingua, fa un passo avanti e dieci indietro, aspetta, ascolta, contempla, tace; non intende «ostentare né competenze che non ha né incompetenze che non sono mai interessanti in sé». E cerca di imparare a essere morto, «per vedere come va il mondo senza di lui».
Chefare, dicembre 2018

Con John Irving
Per definirsi come scrittore, pesca almeno cinque o sei aggettivi. Emotivo, prima di tutto. Poi: teatrale, drammatico, psicologico, sessuale, spirituale. Tutto – aggiunge – fuorché intellettuale. «Non ho mai letto romanzi intellettuali, e di sicuro non ne scrivo» chiarisce subito John Irving, perentorio: il tono di un pugile gentile. Abbandonato anni fa il ring, è scrittore a tempo pieno: «Scrivo tutto il giorno ogni giorno. Ho più romanzi da scrivere di quanto sia il tempo che ho davanti per scriverli». È già alle prese con il prossimo – una storia di fantasmi – mentre in Italia esce l’ultimo, già pubblicato in mezzo mondo. Si intitola Viale dei Misteri, è un viaggio prodigioso, lungo seicento pagine. Uno scrittore cinquantenne, Juan Diego, appena un po’ confuso dai farmaci beta-bloccanti che assume con disinvoltura, vola dall’America verso le Filippine per ritrovare un pezzo della sua infanzia messicana. Quando viveva in una discarica, salvava i libri dall’inceneritore, e scopriva a ogni passo – con una sorellina quasi veggente al fianco – qualcosa di miracoloso. Anche nella disperazione e nella miseria più nera. Pochi scrittori sono “dickensiani” come Irving. Orfani, figli illegittimi, ragazzini “atipici”: il bambino Homer nella comunità raccontata in Le regole della casa del sidro, diventato film premio Oscar, Owen nel commovente Preghiera per un amico, Billy e la sua “diversità” nel più recente In una sola persona. Irving continua a esplorare il paesaggio turbolento dell’infanzia e dell’adolescenza – la lotta libera con il mondo adulto, la ricerca di una possibilità di riscatto.
Nella vita dei suoi personaggi, l’infanzia ha sempre un ruolo centrale. Verrebbe da pensare che sia così anche per lei.
«Nel tipo di storie che mi interessano, i personaggi sono plasmati da qualcosa che accade nell’età del desiderio – quando il desiderio prende forma in noi. Ma se lei dice “penso sia così anche per te”, be’, non proprio. Onestamente, non saprei tirare fuori esperienze dell’infanzia e dell’adolescenza che mi abbiano plasmato o che abbiano avuto un effetto traumatico. Di sicuro, le cose accadute a quell’età, come per chiunque, hanno contribuito alla mia crescita. Ma niente di disastroso, di sconvolgente, o di realmente duraturo. Ho avuto un’infanzia relativamente pacifica e poco movimentata. Noiosa, davvero. Ciò che passa per la mia testa, ciò che accade nella mia immaginazione ha sempre avuto più importanza rispetto alla mia storia personale. E se ho scelto di dare importanza all’infanzia e all’adolescenza nei miei romanzi, è perché questo produce buone storie. Melville teneva incollata allo scrittoio una frase di Schiller: “Rimani fedele ai sogni della tua giovinezza”. Be’, penso a questo come a un consiglio di scrittura. Non si applica necessariamente alla vita reale di tutti. Non alla mia, comunque».
L’idea di un ragazzino che pesca i libri dalla spazzatura è molto bella. Leggere può essere anche un modo per sopravvivere?
«Sicuramente non sono il solo a temere che leggere sia un’abitudine in via di estinzione. E questo mi pareva un buon momento per raccontare la storia di un bambino che impara da solo a farlo, salvando libri dal fuoco. La lettura è sacra. Fare in modo che un bambino legga è fondamentale. Guardi cosa è successo, politicamente, negli Stati Uniti. Solo una popolazione scarsamente istruita avrebbe potuto eleggere Donald Trump. Solo la mancanza di istruzione può convincere i poveri e la classe media a pensare che i repubblicani siano davvero interessati a loro. Questo è l’effetto della poca lettura: una popolazione facilmente ingannabile. Se la gente smette di leggere, smette di pensare. Leggere è l’unico modo per sopravvivere, l’unica forza che abbiamo per resistere alla tirannia. Trump è impegnato a vendere odio e xenofobia – il fascismo, in altre parole – a una popolazione troppo ottusa per capire meglio. Non sto esagerando».
I beta-bloccanti bloccano i ricordi del protagonista del romanzo. C’è una reale possibilità di sbloccarli? Senza essere scrittori, intendo.
«Ho i miei dubbi sul valore della memoria. È sopravvalutato. C’è una battuta, in Preghiera per un amico: “Tu pensi di avere un ricordo, ma lui ha te”. Questo è un modo per dire: non fidarti della tua memoria. Gli scrittori sono ossessionati dalla memoria; abbiamo bisogno di ricordi, ma ci ingannano. Quando stavo scrivendo Le regole della casa del sidro, ho dovuto studiare parecchia medicina, ed ero certo che avrei commesso molti errori. Ho dato da leggere il manoscritto a diversi medici, e ho scoperto di aver sbagliato piccolissime cose. Per il resto, ero cresciuto lavorando in un frutteto. Conoscevo il frutteto, o credevo di conoscerlo. E invece ho fatto un sacco di errori sulla coltivazione delle mele. Fortunatamente, un buon amico coltivatore ha letto il romanzo e li ha scovati. Da allora, non mi sono più fidato della mia memoria, o del valore (nella finzione) dell’esperienza personale. I nostri ricordi mentono».
«La religione sta a metà fra la paura e il sesso». È una frase che il suo personaggio sottolinea. Lei è d’accordo?
«Penso che ci siano in giro un sacco di cazzate mistiche sulla religione e sul sesso; c’è un modo “mitologico” di vedere entrambe le cose, di gonfiarne il significato, di rivendicarne un’importanza simbolica. Però c’è anche una gran quantità di bellezza negli occhi di chi le guarda. Le persone hanno sentimenti molto forti in materia e sono riluttanti a cambiare idea. Ma in Viale dei Misteri è con un occhio ironico o malizioso che viene scrutato ciò che riguarda il sesso e la religione. Mi diverto un po’ con quanto la gente prenda l’uno e l’altra terribilmente sul serio».
Secondo Juan Diego, che è uno scrittore, scrivere esplicitamente di sesso è una scelta politica. Lo è anche per lei?
«Sono testimone delle recenti elezioni in Alabama, dove un pedofilo è stato quasi eletto al Senato degli Stati Uniti, ma era un pedofilo ultra-religioso, e molte persone ultra-religiose lo hanno sostenuto, spiegando che non avrebbero mai potuto sostenere il suo avversario, in quanto liberale in materia di aborto. Ecco che persone religiose, contrarie a ciò che nuoce a un feto, non erano così preoccupate di proteggere da un pedofilo ragazzine di dodici o tredici anni. E le persone “religiose” come questa sono anche quelle più contrarie ai passaggi espliciti su questioni sessuali nei film o nei romanzi. Sì, scrivere esplicitamente di sesso è una scelta politica. Questi ipocriti devono impararlo: non conta la lingua che usi, conta quello che fai».
Nei suoi romanzi, la realtà non è mai solo quella che si vede. In Viale dei Misteri, il paesaggio messicano accentua la relazione con il miracoloso. Cos’è la trascendenza per lei?
«È impossibile trascorrere del tempo in Messico e non sentire la forza della fede popolare. Volevo stare dalla parte del credere, o della vera fede, mentre allo stesso tempo volevo condannare ciò che manca alla chiesa – qualsiasi chiesa, non solo la Chiesa cattolica romana. Le regole della chiesa sono stabilite dall’uomo; falliscono, ogni volta. Ho provato a creare una situazione in cui solo un miracolo avrebbe salvato Juan Diego. È un orfano nelle mani dei gesuiti; loro controllano il suo destino. E le uniche due persone che lo amano e vogliono adottarlo sono due gay: un prete fallito e il suo amante transgender. Non c’è possibilità che quei vecchi sacerdoti consentano che ciò accada, a meno che la Vergine Maria stessa non intervenga. E Maria fa esattamente questo. Versa grandi lacrime».
Questo romanzo sembra anche un inno alla capacità umana di non arrendersi. Secondo la sua esperienza, è possibile cancellare la paura?
«Scrivo di cose che non voglio accadano mai a me o a persone che amo. Non è possibile liberarsi della paura, o almeno non posso io. Non la perdo di vista. C’è sempre un momento che temo in ogni romanzo, una scena o un capitolo, o un evento, di cui non voglio scrivere: non voglio immaginarlo. Ma se quell’elemento spaventoso non ci fosse, non varrebbe la pena scrivere il libro».
Faccio a lei una domanda che c’è nel suo romanzo: «Quanto si può credere ai sogni di uno scrittore?».
«I sogni, come i ricordi, ci ingannano. Ma tutti gli scrittori sognano a occhi aperti nei romanzi, e i romanzi vengono dal sognare a occhi aperti. Non si può smettere di sognare, anche se i sogni sono fuorvianti. Più di quarant’anni fa, quando stavo scrivendo Il mondo secondo Garp, pensavo che il tema dell’odio sessuale sarebbe stato superato prima che avessi finito il romanzo. Ecco, quello era un sogno ingannevole. L’odio sessuale è ancora fra noi. Ho appena riscritto quel romanzo in forma di serie tv. Il mondo – be’, gli Stati Uniti, in ogni caso – ha bisogno di una serie tv femminista in questo momento, e Garp era un romanzo femminista. Purtroppo, non è affatto datato, come all’epoca temevo che diventasse».
Vanity Fair, 23 gennaio 2018

Riportare sempre qualcosa da un viaggio
da Vite che sono la tua. Il bello dei romanzi in 27 storie, Laterza 2017
Non so se la ricordi, ma io sì, la prima volta che mi hai regalato un libro. Temevi che non ne fossi contento, e mi hai guardato: come si guarda un bambino quando si sta per deluderlo. Invece è andata che l’ho scartato – avevo capito che cosa fosse – con un entusiasmo che deve averti stupita.
È bastato poco per riconoscersi fra lettori: mi rigiravo fra le mani quel volume di grande formato, con i disegni che occupavano le pagine per intero. Raccontava gli dèi dell’Olimpo, «in pantofole»: Zeus come un padre dispotico, sovrappeso, cialtrone, Apollo come un rubacuori seriale, Ermes come un nipote magro, sbadato, sempre di fretta. Non so dove sia finito il libro – però mi è rimasto quel pomeriggio, nel piccolo soggiorno di casa tua, poca luce, tua madre minuscola, malata, l’avevo intravista su un grande letto pieno di cuscini. Era un pomeriggio di autunno, e non c’era nessun motivo per farmi un regalo. Da paziente di mio padre medico, costretto ogni tanto a trascinarci nelle sue visite a domicilio, tu ti eri affezionata al ragazzino occhialuto e a sua sorella. Mi chiedevi: ti piace leggere? Rispondevo sì, ed ero convinto. Da allora, il patto non scritto, stabilito da te, era regalarmi un libro quasi a ogni incontro, tenerlo pronto per l’occasione, oppure farmelo recapitare.
Come li avessi chiusi un minuto fa, come fosse rimasta impressa sui polpastrelli la loro forma, saprei dire tutto dei primi ricevuti da te.
La grande copertina in pelle azzurra di un’edizione per ragazzi del Giro del mondo in ottanta giorni – Phileas Fogg disegnato con un tratto che mi ricordava il libro di catechismo. E Passepartout, buffissimo, che dei luoghi, e di tutto, capiva molto più del suo distratto datore di lavoro. E quella domanda, che arrivava alla fine del libro – «Che cosa aveva riportato da questo viaggio?» – mi piaceva, mi sembrava quella fondamentale.
La Storia di Roma scritta da Montanelli, un cofanetto elegante, la costina che lo faceva somigliare a un volume antico, di pregio.
La collezione di classici della letteratura italiana: me li prendevi in edicola, uno a settimana, c’era Ariosto e c’era Pascoli, c’era Fogazzaro e c’era Verga, di cui mi incantò una novella intitolata La roba, con un tramonto largo sopra i campi e un uomo che non vuole morire e ammazza le oche gridan
Ho perso il conto, hai esagerato. A Natale, o per il mio compleanno, a giugno, sapevo che sarebbe arrivato un pacco più grande. Furono, per esempio, i quattro volumi della Ricerca del tempo perduto di Proust: compivo diciassette anni, c’erano un milione di cose diverse da fare dentro quell’età, e tuttavia immolai l’estate alla “parte di Swann”. Mi sembrò di avere sempre aspettato quel libro, e di possedere lo stesso cuore malinconico e ripetitivo del Narratore – come un organetto di Barberia scassato.
Era bello parlare, parlarne. Con un pudore quasi inscalfibile, da nipote a vice-nonna, un tono diverso da quello che usavo fra coetanei: ovvio, sì, ma valeva anche parlando di libri. Se sulle scale bianche del rettorato, all’università, qualche anno più tardi, mi sarei infiammato per pagine che a te sarebbero sembrate cervellotiche e aride – così avresti detto, e un po’ avevi ragione; se in un bar del quartiere San Lorenzo, o seduto sul letto di una studentessa fuori sede, o di un’altra i cui genitori non c’erano mai, a piazza Vescovio, se con loro facevo l’artista-da-giovane, inebriato dalle mie stesse complicazioni, con te tornavo a essere – ero ancora – il ragazzino composto che faceva bene i temi a scuola. Ritornavamo – a bordo della tua Panda, quando mi scarrozzavi verso una conferenza, la presentazione di un libro – i cultori di una letteratura casta e senza troppe ombre, pulita come quella che finisce nelle antologie scolastiche.
Quando mi avventuravo per strade diverse, era un azzardo quasi segreto. Ero esaltato, matita in mano, per pagine in cui lo stile si mostrava come un’invenzione continua, un tradimento, un esercizio a vuoto. Ero eccitato, mentre leggevo, come fossero manuali di anatomia o di educazione sessuale, romanzi di Moravia, di Philip Roth, o di Henry Miller. Nell’adolescenza, d’altra parte, bastava così poco! Oggi mi domando come sia stato possibile provare desiderio perfino per una come Lady Rowena – lei personaggio romanzesco del XII secolo, io in pieno sviluppo ormonale ottocento anni dopo – mentre leggevo Ivanhoe di Walter Scott, saltando parecchie pagine sotto il sole di luglio.
Tornavo da te come uno che deve nascondere l’odore di fumo ai propri genitori.
Quasi avessi frequentato cattive compagnie, ti nascondevo le tracce del mondo che ero riuscito a vedere. Persone lontane, diverse da me, da noi, cominciavano a raccontarmi storie insolite, inaudite, a svelarmi segreti, e rispondevano a domande che non avrei mai rivolto a te, ai miei, forse a nessuno. Mi fornivano notizie che avevano il potere di turbarmi, di farmi male e bene a un tempo, di suscitare la mia curiosità e la mia malizia. Insomma, casa mia era sempre quella, e sempre quelle le cose che si potevano dire e quelle che no. Ma poi la sera uscivo, e rientrando a notte fonda avevo addosso, al posto della scia di fumo, una serie di emozioni nuove e inattese.
Che c’entravano con me, con noi, chiacchiere di vecchi erotomani, memorie di viaggi così lontani da via Mameli 87 da sembrare impossibili, storie in cui pareva che la verità della vita fosse fatta solo di dolore, di ingiustizia, di crudeltà, di desiderio cieco, di fallimento. Ma chi stavo frequentando? Vite che non erano la mia, per tirare in ballo il titolo famoso di un libro di Emmanuel Carrère. Vite che diventavano mie.
I pregiudizi ricevevano colpi quasi mortali. Lo spazio davanti agli occhi si allargava incredibilmente, caricandosi di possibilità. Questo, è stato leggere. Questo è. Fare entrare nella propria vita molte più persone di quelle che davvero riusciamo a incontrare per strada. Intrattenersi con bambini, adolescenti, adulti, vecchi, animali, con il mistero di ciascun vivente. E con il mistero delle cose, anche. Lasciarsi toccare da ogni esperienza, lasciarla depositare in noi. Avere quasi sempre le vertigini, per come si spalanca – leggendo – non solo lo spazio, ma il tempo.
Tu, davanti a un discorso simile, avresti detto che mancava la cosa più importante. Non so nemmeno bene come tradurla: c’entra con l’idea che leggere educhi, nobiliti, o meglio, che debba educare, nobilitare, formare l’individuo, il suo “animo”.
Eterna ragazza nata all’inizio degli anni Trenta, credente, mai sposata, rifiutavi volgarità, passaggi troppo espliciti, tentazioni nichiliste. E io? Mai avuta una vocazione da maledetto, devo esserti sembrato impeccabile fino ai temi di scuola media, eccellente fino a all’esame di maturità. Già la tesi di laurea triennale – sull’immagine del corpo nella narrativa contemporanea – ti aveva lasciato qualche dubbio: scritta benissimo, mi avevi detto, ma davvero ti piacciono scrittori come quelli? La domanda non era formale, te lo chiedevi sul serio, un po’ sconcertata. Ma no, ti ho rassicurato.
E invece, per esempio, la lettura delle Particelle elementari di Michel Houellebecq, che avevo letto da poco, mi aveva entusiasmato e stordito, ricordo di avere letto l’ultima frase e di essermi alzato dalla sdraio incredulo, barcollando come ubriaco. «Questo libro è dedicato all’uomo», aveva scritto Houellebecq. Ma che cosa avresti pensato di quel deserto esistenziale, di quella rinuncia alla speranza?
Me la cavavo – se mi chiedevi cosa stessi leggendo – rispondendo «un libro che non ti piacerebbe». «Allora non lo leggo» dicevi sempre, e ci veniva da ridere. La tua vista si era fatta più debole, eri costretta a scegliere bene, dicevi, e aggiungevi che piuttosto avresti voluto il tempo per rileggere. Rileggere i libri letti da ragazza. Rileggere «i classici», ma anche certi romanzi più leggeri di una tua stagione romantica. Non capivo – io bulimico, ossessivamente curioso del nuovo e di tutto. Ci stavamo allontanando? No. Però un po’ mi dispiaceva quando dicevi che era sempre più difficile regalarmi libri, che ne avevo troppi, che li avevo letti tutti, che non capivi più i miei gusti. Allora mi invitavi a darti io il titolo di un libro da regalarmi, così che fosse impossibile sbagliare. E io facevo in modo di non deluderti.
A metà settembre del 2008, avevi letto sul giornale del suicidio di David Foster Wallace. Non l’avevi mai sentito nominare, mi hai chiesto: li hai tutti i suoi libri? Ti ho risposto che avrei voluto leggere una raccolta di racconti intitolata Oblio. Non hai aspettato un minuto, sei andata a cercarlo subito, prima nella “tua” libreria, niente, poi in altre. C’era stato un piccolo assalto. Non ti sei data pace finché non l’hai trovato. Allora sei passata da me, hai suonato il citofono, hai detto che non potevi lasciarlo nella buca delle lettere – come a volte facevi per non disturbare – perché era troppo voluminoso. Poi mi hai chiesto di promettere che, se avessi trovato un racconto bello, ma pure solo una frase, una frase che fosse bella anche per te, te l’avrei letta, o ti avrei prestato il libro. Quei racconti mi avevano ipnotizzato, rattristato, fatto pensare, costretto a pensare con la pretesa quasi tirannica di ogni pagina di Wallace. E una frase bella, una frase che ti potesse piacere, non c’entrava con i personaggi, insegnanti psicotici o bambini ustionati, e nemmeno con uno che matura l’idea di suicidarsi. C’entrava con le parole: «Le parole e il tempo cronologico creano tutti questi equivoci assoluti su quello che succede per davvero a livello elementare. Eppure al tempo stesso la lingua è tutto ciò che abbiamo per cercare di capirlo e per cercare di instaurare qualcosa di più vasto o più significativo e vero con gli altri, il che è un altro paradosso».
Mi sono dimenticato di mostrarti questa frase, mi è passato di mente. Peccato, perché credo che ti sarebbe piaciuta. Conoscendoti, avresti detto che forse si poteva dire in modo anche più semplice, ma ci saremmo trovati d’accordo sul senso. Non era stata la passione per le parole a tendere il filo di questa strana amicizia?
Di entrambi, nati a distanza di mezzo secolo l’una dall’altro, si potrebbe scrivere una seconda biografia. Della prima, per quanto riguarda te, so poco, ti ho fatto poche domande; della seconda – una biografia di lettrice – qualcosa in più: i libri che hai evocato, ricordato, che mi hai prestato, o fotocopiato; i libri che, fin quando saranno anche di carta, ingombrano le stanze e le case di chi li accumula e li conserva, componendo uno strano museo personale – la storia del nostro avere pensato, sentito, capito.
Sarebbe divertente quantificare le ore spese dietro e dentro ai libri, anche per capire come se la battono con quelle impiegate a fare tutto il resto.
Dei ventisette anni passati dal giorno in cui sono diventato lettore, da quando ho appreso questa innaturale facoltà che pesci, cani e giraffe non conoscono, che è solo di noi umani, posso dire che raramente mi è accaduto di non avere un libro sottomano. In macchina, seduto sul sedile posteriore, nelle attese dall’oculista, finché non mi mettevano le gocce e il mondo veniva cancellato dalla nebbia, o dal dentista; nella borsa della palestra del basket o del nuoto, per quel poco che ho avuto di costanza nello sport; nella borsa del mare, e nei viaggi, in tutti, uno per uno, sempre c’era con me più di un libro.
Così, se non so svelare il mistero da cui questa confidenza con carta e inchiostro origina, so che ha determinato una mole impressionante di emozioni, scoperte, incontri. Anche relazioni, anche scelte. Al punto da non riuscire a immaginare come sarei, chi sarei, se nella mia vita non ci fossero stati e non ci fossero i libri. Temo che sarei proprio un altro: né peggiore, né migliore, un altro e basta. Un altro che non sono io. E tu – sono sicuro – non saresti stata tu.
Quando Henry Miller sostiene che gli incontri con i libri siano da considerare alla stessa stregua degli incontri con altri fenomeni della vita e del pensiero, non li sta sottovalutando. Al contrario: tutti gli incontri sono connessi tra loro, dice, «non sono isolati. In questo senso, e in questo senso soltanto, i libri sono parte della vita quanto gli alberi, le stelle o il letame». Sono parte della vita. Lui, arrivato a quasi sessant’anni, si guarda intorno e decide di fare un mucchietto dei libri che per lui sono stati davvero essenziali. Non sono tanti. E d’altra parte, non si tratta di un canone estetico, intellettuale, ma di un canone affettivo.
Ho provato a comporre il mio, ed è provvisorio: ventisette libri, ventisette come gli anni, a oggi, della mia vita da lettore. Dai sette ai trentaquattro che ho compiuto. Certo, i titoli potrebbero essere il doppio, il triplo, forse il quadruplo. Ma ho scelto, ho dovuto scegliere. Non è stato facile: il solito gioco della torre. Delitto e castigo o L’idiota? Il primo. Anna Karenina o Guerra e pace? Nessuno dei due. La morte di Ivan Il’ic. Mi sono fidato dell’intensità dell’emozione: i picchi in alto di un lungo elettrocardiogramma letterario. Mi sono accorto che da ciascuna di queste storie ho imparato qualcosa, ma non sempre nel senso che intendevi tu.
Talvolta, anzi molto spesso, i romanzi mi offrivano “istruzioni per l’uso” sbagliate, a rovescio, impraticabili. Vuoi innamorarti meglio della persona sbagliata? Leggi Le notti bianche di Dostoevskij. O Le avventure della ragazza cattiva di Mario Vargas Llosa. E se vuoi “abolire” i lunedì dalle tue settimane, leggi Le avventure di Tom Sawyer, che sogna un calendario fatto tutto di domeniche. Vuoi imparare a non crescere troppo? Leggi Peter Pan! Peccato che poi si cresca lo stesso, e che i lunedì arrivino sempre e comunque. Però in un romanzo, nei romanzi, resta sempre aperto il campo della possibilità. È possibile abolire i lunedì. Immaginare, sempre. Sentir battere il cuore e inventarsi il sesso. Cercare un posto sicuro, e non invecchiare male. Trovare l’ultima parola.
Se un romanzo funziona, funziona come un viaggio. Un viaggio ci rende migliori o peggiori? Nessuna delle due cose. Diversi, di sicuro, da quando eravamo partiti. Se è davvero un viaggio, è possibile rispondere alla domanda del Giro del mondo in ottanta giorni: «Che cosa aveva riportato?».
A volte, da un libro, riporti con te anche solo una frase. Un’intuizione. Una cosa che ignoravi. Un’altra che ignoravi di ignorare. A volte anche solo una visione, il gesto di qualcuno che si aggiusta un cappello, o sta seduto e aspetta. Altre volte una storia che somiglia alla tua. Una storia che avresti voluto somigliasse alla tua. Una storia che ha ancora il tempo di somigliare alla tua. A volte un sentimento che non riuscivi a tradurre in parole. Altre volte solo una stretta al cuore, un fastidio, un po’ di noia, uno sbadiglio. Ma tutto va bene, purché non ritorni a mani vuote.
Da ciascuno dei ventisette romanzi che qui ho messo in fila, ho riportato qualcosa che non ho ancora perso. Alcuni li hai amati e letti anche tu, altri non li conoscevi, altri ancora sono fra quelli che non ti piacerebbero. Ma mi pare, in ogni caso, che avrei dovuto scrivere questo libro prima, in tempo perché tu lo leggessi, in tempo per portartelo in regalo in ospedale, l’ultima volta che ti ho vista.
Era un pomeriggio di fine dicembre – sereno e quasi tiepido, mi aveva fatto in venire in mente, guarda caso, l’inizio del Piacere di d’Annunzio, con l’anno che muore «assai dolcemente». Non volevo arrivare a mani vuote, ti ho portato una copia di un libro pubblicato da questo stesso editore; dentro c’è un mio testo che discute ironicamente la convinzione che leggere ci renda migliori. Dicevo tra l’altro che «il piacere della lettura», in senso astratto, forse non esiste. Esistono però il piacere, il divertimento, la commozione, la tristezza, il fastidio, l’indignazione, la sorpresa, suscitati di volta in volta dai singoli libri. Mi hai scritto un sms, uno degli ultimi: tu che contesti il piacere della lettura, non sembri tu. Era una provocazione, ti ho risposto.
Se ho scritto questo libro, è stato anche per aggiungere tutto il resto, tutto quello che mancava in quella risposta frettolosa. E confermarti che questo strano gesto, questo gesto inoffensivo, e concentrato, ormai secolare di mettersi a leggere qualcosa come un romanzo
- non rende più intelligenti
- può fare male
- non allunga la vita
- non c’entra con la cultura, non direttamente
e però anche che
- aiuta a non smettere mai di farsi domande
- alimenta l’inquietudine che ci tiene vivi
- permette di non vivere solo il proprio tempo e la propria storia
- offre la possibilità di non essere solo sé stessi
- rende più intenso il vissuto, e forse più misterioso il vivibile
[ti lascia sempre molte caselle vuote da riempire]
Certo, è difficile immaginare che tu possa leggere queste pagine. Però c’è una cosa che mi consola: ed è proprio il fatto di averti portato un libro, quel giorno. Forse non era quello giusto, ma sei stata contenta: mi portano solo libri pesanti, hai detto. Ti riferivi alla mole. Mi cadono dalle mani, per fortuna me ne hai portato uno più piccolo e leggero. Ti ho salutata come ci si saluta sicuri di rivedersi. E lì per lì non ci ho fatto caso. Ci sto pensando adesso: è stato il primo e l’ultimo gesto che abbiamo fatto insieme – scartare un libro regalato.
Questo, comunque, è dedicato a te.
Settembre 2017

Con Alessandro Baricco e Dave Eggers
«Neanche l’ha sfiorato l’idea che fare lo scrittore potesse bastare». Così ha detto una volta Alessandro Baricco parlando di Dave Eggers, ma forse ragionava anche di sé. I due hanno parecchi tratti in comune. Il primo esordì nel ’91, con Castelli di rabbia, a trentatré anni, «quando si è capaci di vertiginosa libertà-indipendenza-follia»; il secondo nel 2000, a trenta precisi, con L’opera struggente di un formidabile genio, e dell’esordiente che è stato dice di ricordare soprattutto il troppo gel che metteva nei capelli, indisciplinati come la sua prosa. Hanno scritto una decina di romanzi ciascuno, ma non si sono limitati a quello. Editor, imprenditori, “didatti”, performer. Hanno fondato scuole di scrittura, la Holden e 826 Valencia. Eggers si è inventato la rivista-casa editrice “McSweeney’s”, sceneggia film, crea una playlist musicale anti-Trump lunga quattro anni. Baricco continua a praticare la sua “narrazione del sapere”, dagli anni della tv alle più recenti “Mantova Lectures” in teatro. Accade spesso agli scrittori di prestarsi a diverse esperienze, spesso anche per ragioni alimentari. Nel loro caso corrisponde – direbbe l’uno – a una precisa «idea di mondo»; alla «fame che abbiamo» – direbbe l’altro – di capire, di stare davvero nel presente.
È davvero possibile, oggi, essere “solo” uno scrittore?
BARICCO: «Il mio istinto mi ha portato da subito a fare anche altro. Nel tempo, mi è parso chiaro che non ero un caso isolato; ora è abbastanza evidente che il profilo dello scrittore “puro” continuerà a esserci, ma forse circoscritto a pochi. Per il resto, si imporrà questa figura di autore che fa molte cose, o forse comunque una sola: un’opera che si compone di tanti gesti diversi».
EGGERS: «Essere uno scrittore è già parecchio. Ma a volte si presentano idee che vanno attuate fuori dalla pagina, su un piano concreto. Altre volte si presenta un problema del mondo reale, e uno scrittore, o qualunque umano, potrebbe essere in grado di vedere una soluzione possibile».
Che rapporto c’è fra i diversi piani del vostro lavoro?
EGGERS: «Accade che ci sia qualche sovrapposizione, ma la mia scrittura è molto distinta dal resto del lavoro. Quando scrivo, sono solo nel mio garage, e davvero sconnesso da tutto il resto. Il mio ultimo libro, che racconta una dentista in Alaska, non aveva legami diretti con nessun aspetto della mia vita. Be’, un legame l’ho visto dopo: quando sono andato dal dentista e ha trovato un mondo di problemi nella mia bocca».
BARICCO: «Posso dire che fra le cose che faccio, scrivere libri resta un gesto diverso, alto, faticoso, forse in assoluto il più complesso».
In ogni caso, avete in comune una certa inclinazione a sperimentare.
BARICCO: «Mettiamola così: né io né lui abbiamo mai fatto la tessera del club a cui apparteniamo, “quelli che scrivono libri”. Tutte le volte che c’era la cena sociale non siamo andati. Dove eravamo? Io magari a spiare qualcosa, a scegliere le maniglie per le porte della mia scuola; lui in Alaska con i suoi figli a vedere come si vive senza computer, o a decidere un font. Hai presente quello che nella foto di gruppo non viene mai, perché non c’era o è nascosto da qualcun altro? Ecco. Mi pare che entrambi, a proposito di collisioni, siamo impegnati in una somma di micro-collisioni quotidiane con il nostro stesso mondo».
EGGERS: «Ogni percorso è stato davvero inaspettato, non pianificato. Ho rinunciato da molto alla convinzione che la vita si sottometta a qualsiasi disegno predefinito. E quando ti apri ad “affluenti” casuali, tutto diventa di gran lunga più piacevole».
Che cosa significa per voi lavorare nel campo della formazione? La madre di Eggers era un’insegnante.
EGGERS: «Mia madre era una professoressa, sì, e amava il suo lavoro. Quando stai per molti anni su un libro, arrivano momenti in cui ti senti inutile. Ma quando lavori con uno studente, scopri qualcosa sempre, ogni giorno è una rivelazione. Gli esseri umani aspirano a essere necessari, utili, e nel campo dell’educazione un adulto si sente cruciale. Gli insegnanti lo sanno, e tutti gli altri possono, ogni tanto, averne un assaggio».
BARICCO: «Per me quella “pedagogica” è una linea di ricerca. Non saprei definirla bene nemmeno adesso, e divulgazione non mi sembra esatto. È più probabile che si tratti di una “narrazione del sapere”. Dagli anni in tv al lavoro sull’Iliade, alle “Lectures”, tutto va nella stessa direzione. Devo solo trovargli un nome. Prima o poi lo troverò. Quanto alle nostre scuole, il punto di contatto, nella diversità, mi pare questo: tutti e due crediamo che l’esercizio della scrittura renda più atti a difendersi nel presente».
Scrivere è davvero essenziale anche per chi non ne farà mai un mestiere?
EGGERS: «È assolutamente centrale. Per gli studenti a basso reddito che seguiamo nella nostra scuola, l’abilità nella scrittura può significare l’ammissione a un’università di livello, passare da scarse aspettative a luoghi di opportunità. E comunicare con efficacia è un’abilità che chiunque può acquisire con un lavoro assiduo. Negli Stati Uniti abbiamo avuto otto anni dignitosi con un presidente venuto in primo piano attraverso le sue capacità di scrittura; Obama ha scritto il proprio destino con il suo primo libro, Dreams of My Father. E questo è stato un grande esempio per gli studenti, specialmente per quelli di colore. Ora l’uomo alla Casa Bianca è l’opposto, uno che non legge libri e non sa sillabare la parola “presidente”. È un esempio devastante per cento milioni di giovani».
BARICCO: «A che serve scrivere se non si è scrittori? A trovare una gerarchia nel caos, per esempio. La più semplice delle frasi è un sistema gerarchico. E così la costruzione di un racconto esercita la capacità di organizzare un’enorme quantità di materiale. Prendi un manager: si sveglia la mattina e deve risolvere problemi. Se riesce a farlo è soprattutto perché sa metterli in ordine, rapidamente. Un’altra cosa che oggi serve in qualunque campo, è la duttilità: saper lavorare simultaneamente su tavoli diversi. Quando scrivi una storia impari, mettiamo, a costruire un dialogo fra quattro persone: un vecchio, un bambino, uno che balbetta e un analfabeta. Ecco, quando in una riunione hai davanti a te l’americano proprietario dell’azienda dove non aveva ancora messo piede, il tuo vecchio capo che non capisce più tanto, una rampante ragazza di ventott’anni e devi metterli in relazione… be’ se hai scritto un racconto come si deve, metà del lavoro l’hai già fatta».
La Repubblica, 14 luglio 2017

Una storia quasi solo d’amore
Diario di scrittura
Prima di Google, di Wikipedia e di Yahoo Answers, a chi le facevamo le domande? L’enciclopedia Grolier che avevo in casa (qualcuno se le ricorda, le enciclopedie di carta?) forniva risposte fredde e vaghe – soprattutto su ciò che, entrando nell’adolescenza, mi stava più a cuore. Topolino e Charlie Brown qualche aiuto lo davano, ma i romanzi – stavo per scoprirlo – potevano offrire perfino di meglio. Dostoevskij non era facile, ma sul primo amore sapeva tutto; Moravia, sul sesso, ancora di più. Leggere libri era come frequentare di nascosto cattive compagnie – gente che fumava, beveva, ti rivelava segreti indicibili, rispondeva a domande che non avresti mai rivolto a nessuno, e soprattutto ne faceva a te di nuove. Strane, insolite, spiazzanti. «Ma infine, che cosa ci aveva guadagnato? Che cosa aveva riportato da questo viaggio?» chiede al lettore il narratore del Giro del mondo in ottanta giorni. Le domande fondamentali. «E presto diventerei adulto?» domanda Peter Pan alla signora Darling. O forse a sé stesso. «Possibile che anche per le persone avanti negli anni così fosse la vita – allarmante, inaspettata, sconosciuta?» si domanda Lily Briscoe verso la fine del romanzo di Virginia Woolf Al faro. Ho letto, continuo a leggere i romanzi come generatori di domande. Il più delle volte non c’è nessuna risposta. Ma il bello è proprio questo: che qualcuno chieda, anche nel buio, e che l’interrogativo resti a lampeggiare per ore; che i libri sbattano come porte, diceva Breton, di cui si è persa la chiave.
Anche osservato dalla parte di chi scrive, un romanzo può essere un modo per porre questioni che non avremmo il coraggio di porre altrove. Sono in una chiesa romana, sono entrato solo per ripararmi dal caldo, tutto è solenne, fresco, fuligginoso. Non c’è quasi nessuno. Il cigolio della massiccia porta di legno annuncia un ingresso. Mi volto: è una ragazza, è bella, indossa una maglietta bianca, ha i capelli legati. Si siede all’ultimo banco, sta lì più o meno quattro minuti, poi si fa il segno della croce e va via. Vorrei fermarla, o seguirla, chiederle qualcosa. Chi sei? Dove stai andando? Che ci facevi qui? Cos’erano di preciso quei quattro minuti? Da questa piccola visione, da questo lampo di luce dentro l’ombra di una chiesa secentesca, credo sia venuta fuori Una storia quasi solo d’amore. Volevo esporre a questo mistero un ragazzo di vent’anni, uno venuto su nel nuovo secolo, senza avere nemmeno sfiorato le categorie e le ipoteche di quello vecchio. Volevo costringerlo a trovarsi davanti una ragazza più grande, misteriosa, complicata, a esserne attratto, a sentirsi – come mai prima – impacciato, goffo, come di fronte a una cartina muta.
Salinger dice che il mondo ha bisogno di storie ragazzo-incontra-ragazza; io so solo che spesso ne ho bisogno io. E che ho provato a scriverne una, per la prima volta come se fosse l’ultima. Ho avuto in testa un incipit, all’improvviso: «Eravate bellissimi», e con quell’incipit una voce precisa. L’ho segnato in fretta su un quaderno nel cuore della notte. Era febbraio, e non prendevo sonno. Nino e Teresa li ho avuti subito davanti agli occhi, li ho visti parlare davanti a un teatro, un lunedì dopo le sei di pomeriggio. Li ho pedinati, ho atteso che tornassero a incontrarsi, lunedì dopo lunedì. E che la presenza di Teresa costringesse Nino, così poco allenato alle domande, a trovarsene di fronte una valanga. Ogni incontro fra sconosciuti somiglia a una collisione fra pianeti fuori orbita – e tutto questo fa rumore e luce. Nino, da innamorato, è tecnicamente al punto più alto della sua curiosità – e così, in quella fase, siamo tutti: disposti a rinunciare ai pregiudizi che ci fanno da armatura. Sei vegano? Non importa. Mangi carne mattina e sera? Non importa. Ti piace Casaleggio? Non fa niente. Sei scappato da casa? Hai cambiato sesso? Hai figli sparsi ai quattro angoli del pianeta? Non conta, non mi spaventa. Sei credente? Vorrei capire.
Poi magari i pregiudizi tornano, riprendono fiato, ma intanto – da innamorati – ci è sembrato di non averne bisogno, di poter capire tutto, di accettare qualunque domanda. Di essere un po’ meglio di come siamo di solito: più aperti, più liberi, meno ottusi, meno stronzi. Ma perché dura così poco? «Quasi tutte le persone sono simpatiche quando si riescono a capire» (Harper Lee, Il buio oltre la siepe): vero, ma lo sforzo lo facciamo sempre poco, sempre meno. Basta uscire per strada, guardate. Nino e Teresa, che forse si stanno innamorando, non sentono la fatica, stabiliscono quella forma di alleanza fra estranei che ha qualcosa di prodigioso. Continuano a darsi appuntamento, come Whitman nella poesia allo Sconosciuto: «Devo aspettare, perché t’incontrerò di nuovo, non ho dubbi / devo vedere come non perderti più».
Da questo libro è nata anche l’esperimento “Edizione straordinaria”.


