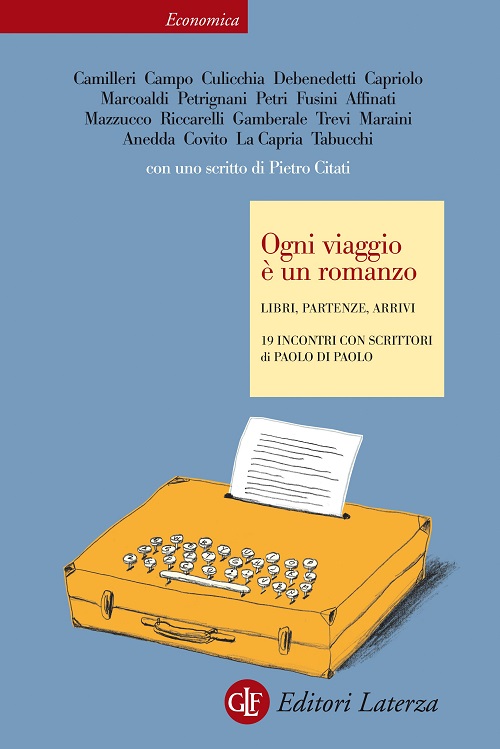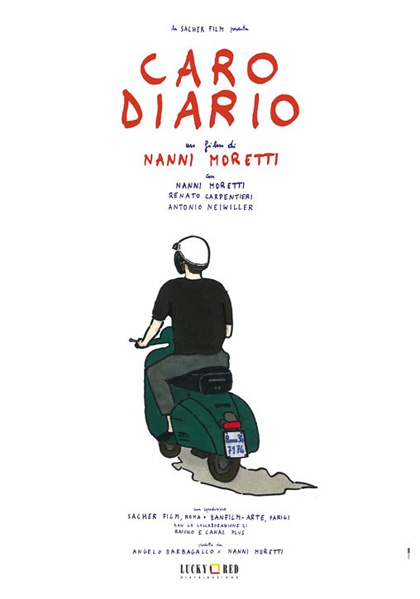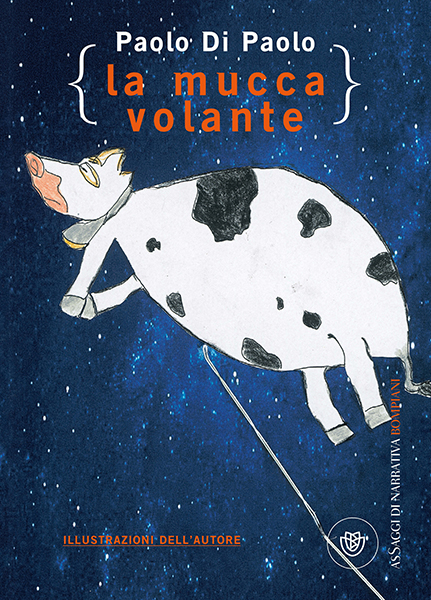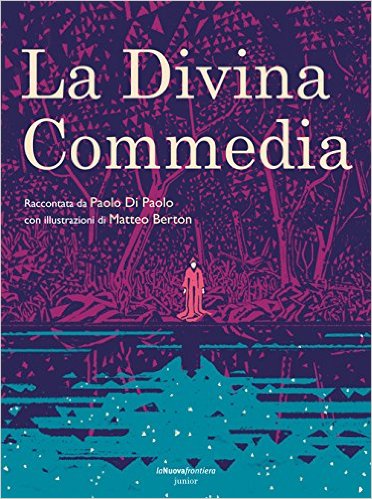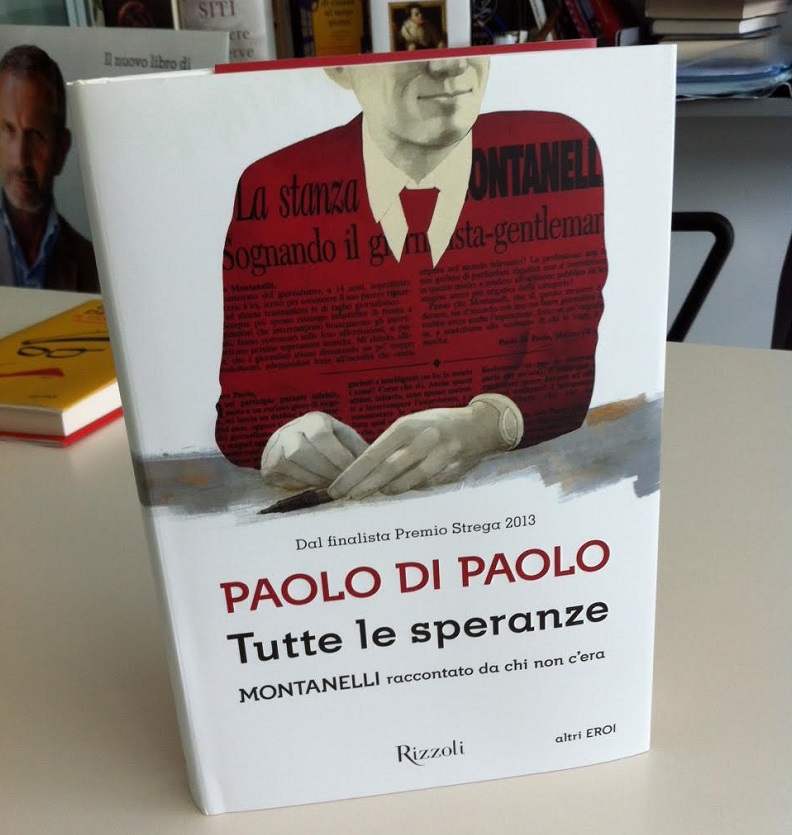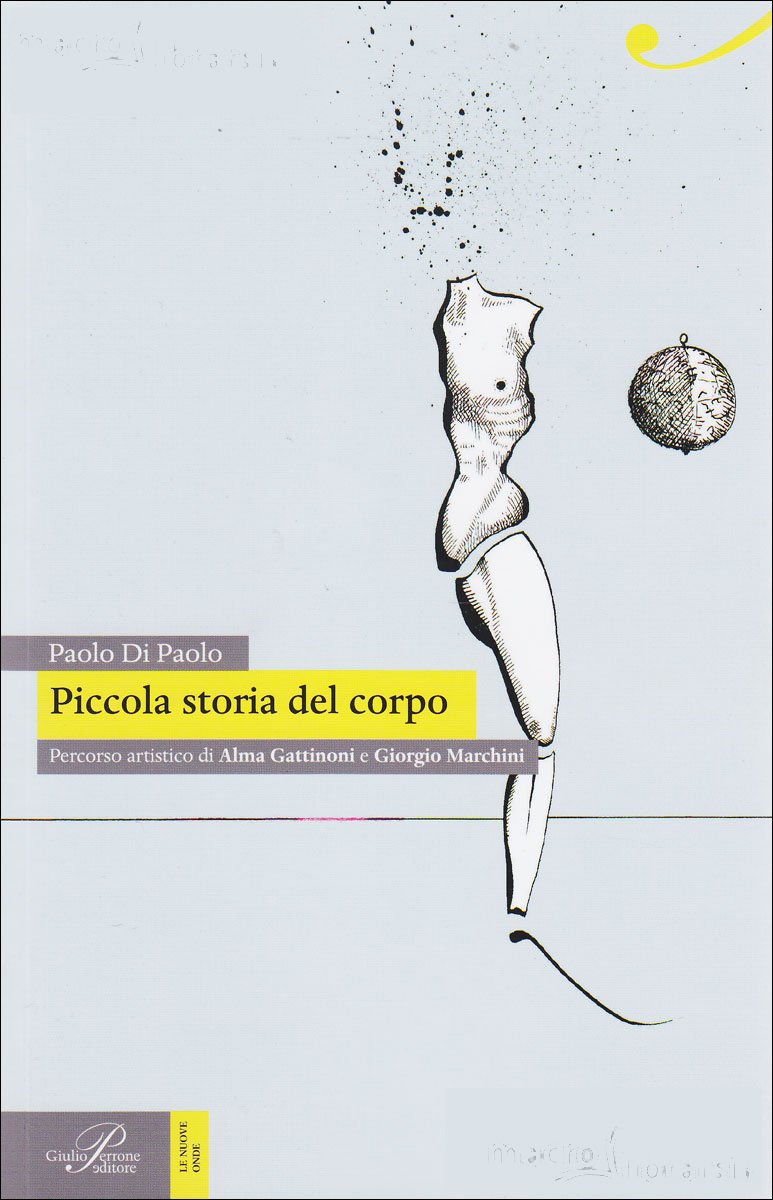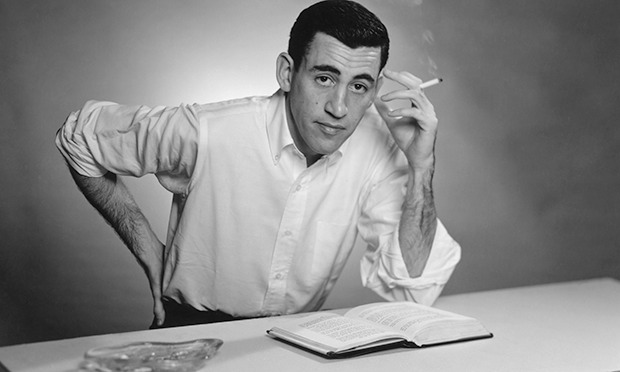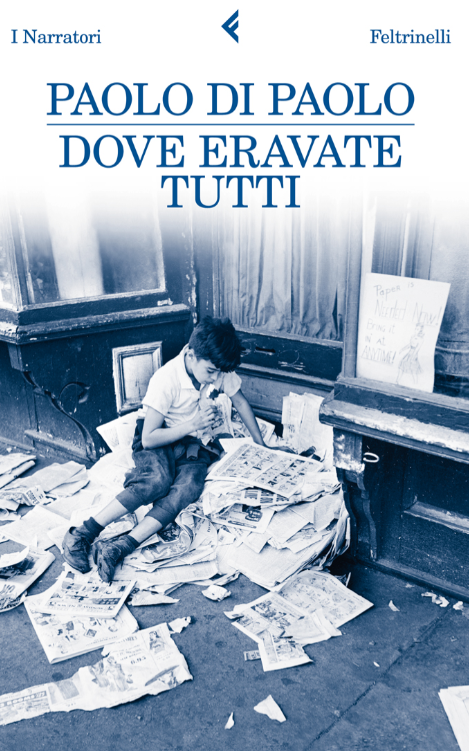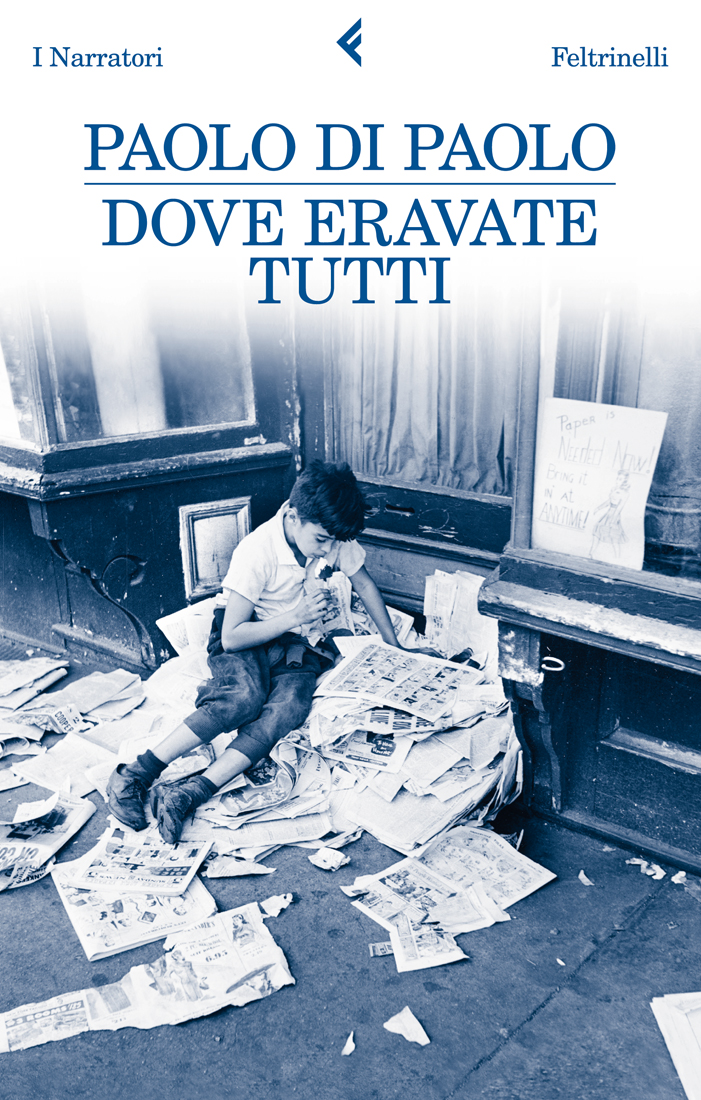Mario Martone siede a un tavolo di legno chiaro in una sala prove del Teatro India. Ci stiamo formando come compagnia in questo momento, dice agi attori. È solare, energico. Dà indicazioni, rilegge le battute in napoletano, si unisce al canto: è una Carmen di Bizet riscritta da Enzo Moscato e musicata dall’Orchestra di Piazza Vittorio. Gli attori indossano maglioni larghi, camicie stazzonate, hanno la matita in mano, non fanno che sorseggiare acqua dalle bottigliette di plastica. Si alzano stanchi, o solo nervosi, fanno avanti e indietro sul parquet pieno di graffi. Gli dico: ho visto il film su Leopardi tre volte, e le signore in età, istruite, si sono puntualmente accodate all’attore protagonista per fargli eco «Sempre caro mi fu» o «Dolce e chiara è la notte…». Quando alla finestra di fronte è apparsa la ragazza intenta a filare, i cinque o sei liceali presenti alla proiezione pomeridiana non si sono trattenuti: «Silvia!». Chiedo al regista se è una cosa che un po’ gli dispiace. Sorride. «È normale», spiega, «che le memorie scolastiche si facciano vive. Basterebbe non fidarsi solo di quelle». Sì, gli rispondo, per godere fino in fondo un film come quest’ultimo che ha fatto, Il giovane favoloso, bisognerebbe dimenticare tutto, non sapere più niente, lasciare da parte per una volta o per sempre le storie sul pessimismo diviso in fasi. Come se un sentimento, o una visione del mondo, potessero essere ridotti a fasi Bisognerebbe lasciarsi trasportare da questa «storia di un’anima» come fosse la vita di un anonimo o di un poeta straniero: così, la nebbia dei mattini d’infanzia a Recanati, i giochi e il sogno di felicità, tutta quella solitudine, il gelo del paterno ostello, le premure di un padre ingombrante, tutto tornerebbe ai nostri occhi come nuovo, più vero. «Ecco, pensa a Monaldo. È stata una delle cose più affascinanti e complesse di tutta la nostra avventura ricostruirne la personalità. Monaldo è un personaggio su cui si sono incrostati troppi luoghi comuni: questo padre è per lo più visto come figura negativa, uno che intrappola Giacomo e basta. In realtà, è un letterato capace anche di ironia, benché sia autore di un libro reazionario, tremendo che ebbe un enorme successo, molto superiore a quello che ebbero i libri di Giacomo in vita. Era in tutto e per tutto un intellettuale del tempo. Il figlio era un secolo più avanti di lui. Ma quella con Giacomo resta a tutti gli effetti una storia d’amore, di grande amore, amore reciproco, e come una drammatica storia d’amore diventa poi una storia di gelosia, di abbandono, di competitività. Solo sul set è diventato chiaro che si potesse raccontare questo rapporto così». Dovremmo sforzarci di risapere tutto da capo, di non fidarci più di nessuna nozione. Così, tornerebbe a essere più complesso, più mobile, più vivo l’itinerario esistenziale di quello che è stato il vero grande genio letterario dell’Ottocento non solo italiano. Ma Leopardi – ho pensato questo per tutto il film – non l’abbiamo mai davvero capito, schiacciati a leggere i Canti e poco più con la stessa disattenzione dei suoi contemporanei. «Loro credevano nelle “magnifiche sorti e progressive”, e mi viene da dire, da un certo punto di vista: per fortuna. Mazzini odiava Leopardi, per esempio. Ma uno come lui, ossessionato dall’utopia, non poteva che detestare il poeta di Recanati. Lo sguardo di Leopardi correva oltre, riusciva a intravvedere – nel futuro o nell’eterno dell’umano – le macerie che le “magnifiche sorti e progressive” sempre producono. D’altra parte, nel film, assumendo la prospettiva di Leopardi, non potevamo ignorare i suoi critici, i detrattori: non tanto per rimproverare agli “amici di Toscana”, o a Tommaseo, la miopia, ma per raccontare piuttosto le ferite che certe incomprensioni, scelte e ipocrisie delle eterne parrocchie della società culturale italiana hanno lasciato in lui».
Mi è venuto di pensare che nel suo film Martone, giustamente e delicatamente, insinui che anche noi, come gli azzimati frequentatori di salotti che rimproverano al conte Giacomo gli eccessi di infelicità, abbiamo capito ancora troppo poco di Leopardi. Non si spiegherebbero altrimenti certi commenti un po’ isterici, risentiti al film, venuti non dal pubblico o dalla critica cinematografica, ma – siamo alle solite – da inutili critici letterari. Nessuno si ribella all’umanissimo Turner ritratto da Mike Leigh, ma da noi saltano subito sulle sedie quando si fanno scendere i monumenti dai piedistalli. «Non posso negare di avere avuto molti timori. Ci tremavano quasi le vene dei polsi pensando a come portare sullo schermo i versi dell’Infinito o della Ginestra. Era una sfida, un azzardo. Restituire alla grandezza della mente di Leopardi il suo corpo, farlo vedere, tremare, soffrire. Leopardi non era infelice perché malato – è lui stesso a ribellarsi a questo fraintendimento – ma c’è una fortissima relazione in lui fra un’interiorità e un corpo sofferenti. Volevo mostrare come un corpo malato possa esprimere una straordinaria forza creativa. Non volevo dimenticare il suo corpo perché questo significava non dimenticare la sua fame di vita. Un’energia impressionante che per paradosso viene dalla fragilità estrema». Per questo serviva un attore, l’attore giusto. «Ho pensato a Elio Germano perché la sua sensibilità e il suo temperamento ribelle sono tratti che mi sarebbe piaciuto trasferire al Leopardi che avevo in mente. Per mesi e mesi abbiamo attraversato insieme le opere di Leopardi: la poesia, certo, ma anche l’epistolario, che è di per sé un capolavoro, lo Zibaldone, le Operette morali, sempre troppo trascurate. Elio è stato al tempo stesso rigorosissimo e liberissimo – e questo dà alla sua interpretazione un tratto unico».
Il rigore e la libertà insieme. Questo ci vuole, in un ritratto? «Bisognava guadagnarsela palmo a palmo questa libertà, senza la quale il ritratto di un uomo del passato non sarebbe “vivo”». Martone l’ha cercata anche nei luoghi e nelle scelte musicali. «Quando preparavo Noi credevamo, avevo una scatola – la chiamavo “la scatola nera del film” – in cui accumulavo ritagli di immagini pittoriche, illustrazioni d’epoca mescolate a fotografie di paesaggio italiano attuale. Come si fa un film ambientato nell’Ottocento senza creare un presepe posticcio?, mi chiedevo. Per il film sul Risorgimento così come per quello su Leopardi non ho voluto ricostruire niente: tutti gli ambienti sono reali. Ho dunque girato quei film nel presente, scavando nel presente come fanno gli archeologi. Quanto alla colonna sonora, seguendo lo stesso metodo, ho messo accanto a Rossini un musicista tedesco trentenne, Sascha Ring, conosciuto come Apparat, idolo della musica elettronica. Gli ho portato il film in un primo montaggio, senza sottotitoli: l’ha guardato senza poter capire, fidandosi solo della suggestione delle immagini. E di una versione dei Canti in inglese».
A me, il risultato – nella scena in cui Leopardi si contorce sul lungarno dopo una delusione d’amore e la camera si alza e lo osserva dall’alto – è sembrato convincente: non è forse anche questo un modo per mostrare un essere umano più avanti rispetto ai propri tempi (e rispetto ai nostri)? Un essere umano nel «sempre». Spiazzante? Sì, ma come è bene che spiazzi l’ingegno di Leopardi. «Quest’idea di sapere libero, la disinvoltura con cui passava dalla filologia all’astronomia, non è forse tutt’oggi spiazzante?» domanda Martone. «Nella scena finale», mi spiega, «quella in cui la voce fuori campo di Germano recita i versi della Ginestra, resta soltanto la forza delle sue parole. La sua capacità di sentire la verità della Natura, di sprofondare in essa. Il suo corpo non c’è più». Al soggiorno napoletano dedica parecchio spazio. «L’importanza di Napoli nel film non è riguarda solo le mie origini. Una delle ragioni più forti che mi hanno spinto a girare Il giovane favoloso è stato proprio quel viaggio con Antonio Ranieri. Anni fa, portai in scena un monologo di Enzo Moscato su Leopardi a Napoli, e da lì viene anche la famosa – o famigerata – scena del lupanare, l’unica che non sia nelle “fonti”. Quando ho visto Recanati – una prigione borgesiana così opposta al colore e al calore di Napoli – mi sono chiesto che strano viaggio potesse aver compiuto quel giovane uomo tanto fragile». A un certo punto, Leopardi è in cattive condizioni di salute e il medico dice di aprire le finestre. Entra un’onda di luce del Sud. Anche in Noi credevamo il buio e la luce erano come due spazi distinti dell’esistenza. A Napoli, si fa ancora più drammatico il conflitto fra le energie del corpo e le energie del pensiero, diciamo pure le idee, la capacità di sentire, di vedere, di capire e di desiderare – una corrente elettrica che tocca poche antenne, le più all’erta. Lo spazio che Martone dedica all’amicizia prima con Pietro Giordani (è commovente la scena in cui Leopardi riceve una delle prime lettere di apprezzamento) e con Ranieri poi, ha a che vedere con questo piccolo cordone di difesa che, in ambienti ostili, tiene vivo Giacomo e un po’ meno solo.
L’Anna Banti di Noi credevamo, Leopardi per le Operette morali portate splendidamente a teatro e per il film biografico, e prima Elena Ferrante per L’amore molesto, e Goffredo Parise per L’odore del sangue: con la letteratura Martone ha un rapporto molto stretto. «Sì, la scrittura, la pittura, il teatro, la musica – tutto è parte della mia unica fede, quella nella capacità di immaginazione umana. Sono affascinato dal gesto di chi crea, di chi compone, di chi dà forma a un tessuto di parole o di immagini. È un gesto che ha del miracoloso: fa esistere qualcosa che non c’era in natura – una musica di Mozart, un grande romanzo – e apre uno spazio di relazione fra esseri umani che spesso scavalca i secoli». Martone sembra interrogarsi di continuo sulla tradizione, sulla memoria collettiva. «Inseguo un’idea di passato laddove sento che può rimanifestarsi come cosa viva. Nessuna nostalgia. Il punto sarebbe far rivivere il presente di chi non c’è più, riattivarlo senza avere per questo una visione postuma. Tutti i miei film nascono da domande sul presente, anche Il giovane favoloso, perfino Noi credevamo, che indaga nel nostro Risorgimento. Non sono mai stato uno studente modello, non coltivo nessuna ambizione accademica e non sono appassionato alle ricostruzioni d’epoca. Nello specifico, del Risorgimento sapevo molto poco, come credo parecchi italiani anche colti. Mi sono sentito chiamato da quei ventenni di allora, dalle loro storie, con un’urgenza che riguardava l’oggi. D’altra parte diventare quel che si è, è impossibile senza fare i conti con il passato. Che sì, resta sempre una terra straniera, un posto abitato da fantasmi. Ma se funziona come giacimento e alimenta il presente, lo rende perfino più vivo».
Ecco: diventare ciò che si è. È il tema portante di qualunque ritratto. Il ritratto di Leopardi, certo. Ma anche il ritratto di Martone, volendo. Sarei curioso di riavvolgere la sua storia di artista diviso fra teatro, cinema, opera lirica. Chi era il ragazzo Mario, nato a Napoli nel ’59? Quando ha capito che sarebbe diventato ciò che è? «Diventare ciò che si è» ripete, «sì, è una frase chiave. Riguarda il rapporto fra sé e quello che per comodità chiamiamo destino. Ho iniziato giovanissimo: a cinquantacinque anni me ne trovo già alle spalle quaranta di lavoro. La prima regia teatrale la firmai da adolescente, erano gli anni delle cantine e delle sperimentazioni». Ma c’è un istante, un segno in cui ha riconosciuto una vocazione? Ci pensa, dice di ricordare lui che si volta, una sera, in un teatro, quando il pubblico se n’era andato e c’erano gli oggetti di scena accatastati, muti sul palco. «Li ho guardati, un fascio di luce li illuminava, o forse addirittura li trasfigurava, e ho pensato che quello era il mio luogo, il luogo che avrei voluto abitare». Sostiene di avere una memoria intermittente, di ricordare per lampi. «Comunque, da ragazzino già mi piaceva raccontare storie. Prendevo in mano soldatini, animaletti di plastica, oggetti trovati in casa e inventavo storie di cui mio fratello più piccolo era lo spettatore obbligato». Non l’ha mai sfiorato l’idea di fare l’attore. Il primo successo, con lo spettacolo-performance Tango glaciale, fu tale da rischiare di «schiantare ogni possibilità futura». Arrivò in America ed ebbe fra gli spettatori anche Warhol e Scorsese. «Fu invece l’inizio di un percorso fitti di evoluzioni e anche di ripensamenti. Era un teatro molto visivo, le immagini e la musica erano centrali. Le parole erano in secondo piano. Ci ho messo un po’ a fare pace con le parole, ho dovuto cercare una chiave d’accesso. A distanza di anni mi rendo conto che anche in quegli esordi c’erano i semi di lavori futuri. Mi sembra di essermi sempre mosso come all’interno di uno stesso arcipelago, le isole sono autonome ma non del tutto estranee l’una all’altra. Così, quando diressi un Otello di Verdi, qualcosa di Tango glaciale c’era ancora, come un deposito sotterraneo di suggestioni. E ancora oggi, portando in scena la Carmen, ritrovo corrispondenze imprevedibili con gli esperimenti del passato, segni di continuità di cui io stesso rimango stupito». La carriera di un artista, dice Martone, è sempre uno strano percorso fatto di salti spazio-temporali. Idee, temi, persone – tutto torna, si lega, si riannoda. «Mi conforta pensare all’esistenza di qualche spettatore che possa aver seguito un ampio tratto di questo percorso. E magari riesce a vedere dei segni, dei legami che non vedo nemmeno io». Puoi giocare a fare tabula rasa quanto vuoi, ma autentiche cesure non esistono: «Io provo sempre, per quanto posso, a sparigliare, a spiazzare. Vedi? Dopo Leopardi faccio questa Carmen di Bizet napoletanizzata. Eppure non si riparte mai davvero da zero». Gli domando come si sia trovato a incrociare l’opera lirica, visti quegli esordi sperimentali. Un’eredità familiare? «No, tutt’altro. La musica, come dicevo, c’era moltissimo nelle prime performance. Incidevamo sul revox la colonna sonora della spettacolo è quella diventava la spina dorsale dell’azione scenica. Per certi versi si può dire questo anche dell’opera. Mi era stato proposto varie volte di allestire una, ma temevo le rigidità di quel mondo, le poche prove. Fino a quando Mauro Bolognini chiamò me e il mio gruppo di lavoro perché ci occupassimo delle scenografie video di una Vedova allegra molto classica, con i costumi di Piero Tosi”. Più avanti sarebbe arrivata la proposta di allestire Così fan tutte di Mozart: “E fu una scoperta importante, perché si tratta in effetti di un’opera non solo musicale ma teatrale in senso pieno. Dissi a me stesso: proviamo. Gli spazi d’azione erano ampi, me ne resi conto strada facendo. Fu l’inizio di un viaggio che dura tuttora».
E il passaggio dal teatro al cinema come avvenne? «In modo molto naturale. Non ho fatto scuole, ho cercato sempre di capire come realizzare i progetti su un piano pratico, da falegname del teatro e del cinema. Sulla strada ho incontrato maestri che in verità consideravo più fratelli maggiori che padri. Penso a Fabrizia Ramondino, a Carlo Cecchi. O ad Antonio Neiwiller, di poco più grande di me: la sua scomparsa prematura è stata un grande colpo, che ha spezzato la mia vita. Era, nel nostro gruppo, il più radicale, ossessionato da come mantenere viva l’anima e non tradirsi in un contesto come quello dello spettacolo, che non potrebbe non avere anche aspetti commerciali». Di Martone, Carlo Cecchi dice che è uno degli uomini più indaffarati che conosca. Bisogna sempre un po’ inseguirlo, in effetti. «I tanti piani di lavoro a cui mi dedico non mi consentono di ritagliare molte pause riflessive, o momenti di bilancio. Preferisco il movimento inesausto e il rumore di un cantiere». Mi viene in mente, gli dico, la città di Tecla immaginata da Calvino. C’è un gran fragore di gru, martelli, viti e bulloni. Il viaggiatore chiede quale sia il senso del costruire, quale sia il progetto. Gli rispondono: ora non possiamo interrompere, te lo mostreremo quando scende la notte. Arriva il momento, è una notte stellata, e gli abitanti di Tecla indicano il cantiere: ecco il progetto, dicono. «I riconoscimenti che arrivano fanno bene, spingono ad andare avanti, ma non mi fermo mai troppo a considerarli, preso dal progetto successivo. E comunque non dimentico i fallimenti, le difficoltà: per anni, a ogni riunione natalizia con la famiglia, ho ripetuto che stavo preparando un film sul Risorgimento. A un certo punto nessuno ci credeva più. Neanch’io».
Nuovi Argomenti, gennaio-marzo 2015